 |
| "Spirit" di Jacopo Rumignani, da https://arte magazine.it/tag/de-m- venice-art-gallery-2/. |
Il cavallo addomesticato (Equus ferus caballus, Linnaeus 1758) è un mammifero perissodattilo (ordine di mammiferi euteri al quale appartengono equini, rinoceronti e tapiri; caratteristica distintiva di questo gruppo di ungulati è la presenza di arti con dita dispari, dovuta alla scomparsa di alcune di esse, che ha prodotto arti con asse portante sul terzo dito) di medio-grossa taglia appartenente alla famiglia degli Equidi. Con l'avvento dell'addomesticamento si è distinto dal cavallo selvatico, di cui è considerato una sottospecie.
Il cavallo ha accompagnato e accompagna l'uomo in una notevole varietà di scopi: ricreativi, sportivi, di lavoro e di polizia, bellici, agricoli, ludici e terapeutici. Tutte queste attività hanno generato vari modi di cavalcare e guidare i cavalli usando ogni volta i finimenti più appropriati. L'uomo trae dal cavallo anche carne, latte, ossa, pelle e capelli, nonché estratti di urine e sangue per scopi farmaceutici.
La femmina del cavallo, chiamata
giumenta, ha un periodo di gestazione (gravidanza) dei puledri di
circa undici mesi, al termine dei quali il piccolo, una volta
partorito, riesce a stare in piedi e a correre da solo dopo
pochissimo tempo. Solitamente l'addomesticamento avviene dopo i tre
anni di vita dell'animale. A cinque anni è completamente adulto, con
una prospettiva di vita che si aggira sui 25-30 anni. Il cavallo
presenta un'elevata specializzazione morfologica e funzionale
all'ambiente degli spazi aperti come le praterie, in particolare ha
sviluppato un efficace apparato locomotore e un apparato digerente
adatto all'alimentazione con erbe dure integrate con modeste quantità
di foglie, ramoscelli, cortecce e radici.
 |
| Cavallo Belga da QUI |
 |
| Cavallo Murgese da QUI |
Mesomorfo - Cavallo con struttura fisica molto più leggera rispetto al brachimorfo, ma comunque potente e compatta. E' il cavallo da esercito dell'età moderna, da caccia o da campagna, intesa come equitazione non agonistica; a questo tipo appartengono moltissimi cavalli moderni, soprattutto mezzosangue. Esempi di cavalli di tipo mesomorfo sono: Murgese, Arabo, Albino, Bardigiano, Andaluso, Basuto ecc.
 |
| Cavallo Purosangue Inglese da QUI |
 |
| Cavallo Irlandese da tiro da QUI |
 |
| Cavallo Holstein da QUI |
e nobile nel portamento. A questa tipologia appartengono il Lipizzano, l'Holstein e il Danubiano, che mostrano agilità e potenza.
 |
| Cavallo Shire da QUI |
 |
| Cavallo Lipizzano da QUI |
 |
| Cavallo Arabo da QUI |
 |
| Le parti del cavallo, da http:// www.pgarazze.altervista.org/ razze_cavalli_ingresso.htm |
 |
| Illustrazione di Tarpan da QUI |
 |
| Tarpan allo zoo di Mosca nel 1884, da QUI. |
 |
Le steppe pontico-caspiche. |
 |
Cartina delle varie migrazioni degli Indoeuropei dal 3.500 / 2.500 a.C. |
 |
Mappa diacronica che mostra gli areali centum (blu) e satem (rosso), la cui probabile area di origine è in rosso scuro, da: |
 |
Ricostruzione del "cromlech" di Stonhenge. |
 |
Carta tolemaica del III secolo della Scizia (Scythia e Serica) La Scizia è separata in due parti dai monti Imai (l'Himalaya). |
 |
| Cavaliere Scita della Cultura Pazyryk con un'arcaica sella, reperto in feltro. Immagine da https://it.wiki pedia.org/wiki/Sciti#/media/ File:PazyrikHorseman.JPG. |
 |
Carta della Scizia, con le popolazioni Scite in marrone, gli Agatirsi assimilabili agli Sciti in verde e le popolazioni limitrofe in ocra. Clicca sull'immagine per ingrandirla. |
 |
Franz von Stuck: "Amazzone ferita" (1903) |
 |
| Carta del 100 a.C. con la Scizia e Sarmazia oltre alla Partia. |
Dal 1.200 a.C. popolazioni nomadi a cavallo e armate di arco, fra cui i sarmatici Roxolani, Iazigi, Aorsi e Alani oltre ai Taifali, domineranno a lungo il territorio fra le pianure del Danubio e le steppe del mar Nero. Nonostante l'invasione di Goti e Vandali nel III sec. d.C., gli eserciti dei quali erano principalmente formati da agricoltori appiedati, Sàrmati e Taifali riuscirono a preservare il loro dominio in alcune aree, almeno sino alla comparsa degli Unni.
 |
| Carta con quella che ancora oggi chiamiamo "Pianura Sarmatica" fino al Kuban' caucasico. |
 |
| Carta dell'antica Roma di Romolo. La cinta muraria esterna fu iniziata da Tarquinio Prisco e ultimata da Servio Tullio. |
 |
| I 7 colli di Roma, da ht tps://it.wikipedia.org/w iki/Campidoglio#/m edia/File:7Colli Schizzo.jpg. |
 |
| Le tre aree di Roma interessate dalle tre imprese di Romolo e Tazio. |
 |
| Schema dell'organizzazione sociale nella prima Roma monarchica. |
 |
| Denario con gli dèi Quirino e Ceres. Immagine di Classical Numismatic Group, Inc. http://www. cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=4782551 |
Tratto da https://www.romanoimpero.com/2010/04/gli-equites-romani.html: "Celeres vale a dire pronti e leggeri. Romolo diede questo nome a trecento giovani dei quali aveva composta la sua guardia e che erano comandati da tre Centurioni sotto un ufficiale generale che chiamavasi Tribuno dei Celeri. La lancia e la spada servivano d'armi ordinarie a queste guardie, che circondavano il re in ogni tempo ma principalmente alla guerra ove essi dovevano essere i primi all'attacco e gli ultimi alla ritirata." (G.J. Monchablon, Prof. dell'Università di Parigi - 1832)
Fra i cavalieri c'erano quindi gli "Equites Romani Equo Publico" e i semplici "Equites". Solo un numero ristretto di cavalieri, un quarto circa del totale, riusciva ad entrare nell'arruolamento di ordine pubblico, col privilegio del cavallo fornito e mantenuto dallo Stato, mentre i semplici Equites dovevano comprarlo e mantenerlo a proprie spese; ma soprattutto gli "Equites Romani Equo Publico" avevano il vantaggio di poter ottenere delle cariche pubbliche, sia giuridiche che senatoriali, che agli equites ordinari erano precluse.
Fin dai tempi degli Equites Romani Equo Publico quindi, con l'espressione "cavaliere" ci si poteva riferire sia ad una qualifica militare che ad una appartenenza politico-sociale.
 |
| Cavaliere ausiliario con lancia, particolare da una pietra tombale romana di Colonia, I secolo. Di Mediatus - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia. org/w/index.php? curid=6555742. |
I monumenti mostrano che anche i cavalieri romani seguivano la generale tendenza delle cavallerie di tutti i popoli d'Italia ad adottare l'armamento greco: conservarono però l'ascia e imbracciarono lo scudo rotondo di bronzo (parma). È attestato anche per Roma l'uso dei due cavalli, pares equi, uno per il guerriero e l'altro per lo scudiero; e forse dagli scudieri degli equites si era a un certo momento sviluppata quella cavalleria leggera dei ferentarii, armati di iacula, una piccola lancia, ricordati dalle fonti, ma scomparsi dall'esercito romano almeno prima dell'età di Polibio, forse già nel secolo III. L'opinione del Helbig, che gli antichissimi equites non fossero che una fanteria pesante montata, che si giovava dei cavalli per spostarsi più rapidamente e più agevolmente, è, se formulata troppo rigidamente, eccessiva.
 |
| Lazio nel 600 a.C. |
 |
| Cartina dell'antica Roma nel 600 a.C. con le mura serviane. |
 |
| Statuetta romana di Mater Matuta. |
Si deve rilevare quindi che Livio e Dionisio abbiano descritto l'ordinamento centuriato con 193 centurie in una fase nella quale era già venuta meno l'eventuale originaria funzione delle centurie come distretti di leva e che la struttura primordiale fosse molto più semplice. Non è assurdo supporre che la distinzione fra seniores e iuniores non sia originaria (come ha sostenuto Beloch) e inoltre l'uso, corrente anche in età avanzata, di chiamare 'classici' i pedites della prima classe e 'infra classem' i rimanenti, può far pensare che nei primordi vigesse soltanto questa distinzione elementare, sicché 80 sole centurie (40 di classici e 40 infra classem) fornissero i contingenti alla fanteria. Se poi si pensa che prima della presa di Crustumerium (circa 450 a.C.) le tribù erano venti, la commensurabilità fra tribù e centurie sarebbe stata stabilita almeno per un periodo iniziale.
Ma una siffatta ipotesi urterebbe con il fatto che proprio l'ordinamento descritto dagli antichi è condotto in ogni particolare sulla falsariga di un esercito di due legioni. Le centurie di iuniores delle prime tre classi darebbero 6.000 uomini di armatura pesante (3.000 per legione): le classi quarta e quinta darebbero 2.500 uomini di armatura leggera, con una minima differenza in più rispetto ai 1.200 per legione. Solo i seicento cavalieri delle legioni disporrebbero di un numero triplo di unità comiziali: ma il punto di partenza dei 600 è evidente nella posizione privilegiata dei sex suffragia, i cavalieri di ordine pubblico. In quest'ordine di idee, preferiamo ritenere che l'ordinamento attribuito a Servio Tullio non abbia mai avuto rapporto con la leva, anzi abbia distribuito i partecipanti al comizio ad imitazione della distribuzione delle forze nell'esercito.
Quanto alla data approssimativa dell'ordinamento centuriato, poiché dalla critica delle liste dei tribuni militum consulari potestate sembra risultare che il raddoppiamento della legione avvenne circa nel 405 a.C., l'adozione del comizio centuriato è quasi coevo; se ne ha una riprova nella diffusione che proprio allora ebbe la piccola proprietà fondiaria.
La funzione tattica della cavalleria legionaria di epoca regia e di inizio Repubblica, si basava sulla mobilità e aveva compiti di avanguardia ed esplorazione, di scorta, nonché per azioni di disturbo o di inseguimento al termine della battaglia o infine per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia e prestare soccorso a reparti di fanteria in difficoltà. I cavalieri usavano briglie e morsi, ma le staffe e la sella erano sconosciuti: non è quindi ipotizzabile una cavalleria "da urto". Quei cavalieri che, nelle stele funerarie appaiono armati di lancia e spada, protetti da un elmo, magari con scudo e piastra pettorale, erano molto probabilmente una sorta di fanteria oplitica mobile. Tito Livio racconta che ancora nel 499 a.C., il dittatore Aulo Postumio Albo Regillense, ordinò ai cavalieri di scendere dai cavalli ed aiutare la fanteria contro quella dei Latini in prima linea: «Essi obbedirono all'ordine; balzati da cavallo volarono nelle prime file e andarono a porre i loro piccoli scudi davanti ai portatori di insegne. Questo ridiede morale ai fanti, perché vedevano i giovani della nobiltà combattere come loro e condividere i pericoli. I Latini dovettero retrocedere e il loro schieramento dovette ripiegare.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, II, 20). Si trattava delle fasi conclusive della battaglia del lago Regillo. I cavalieri romani risalirono, infine, sui loro destrieri e si diedero ad inseguire i nemici in fuga. La fanteria li seguì e venne conquistato il campo latino.
 |
| Consoli della Repubblica di Roma. |
 |
| Lazio, 482 a.C., da https://it.wiki pedia.org/wiki/Guerre_tra_Ro ma_e_Veio#/media/File:Carte_ GuerresRomanoVeies _482avJC.png |
 |
| Metopa del Partenone: lotta fra un Centauro e un Lapita. |
Tratto da https://studiahumanitatispaideia.blog/2013/10/27/difendere-la-citta/: È lecito ritenere che siano stati gli Spartani a inventare la falange, anche se l’unico vero tratto che distingueva gli opliti lacedemoni da quelli delle altre póleis rimase il loro distintivo mantello rosso (τρίβων), che si avvolgevano completamente intorno al corpo, sia d’estate sia d’inverno, senza mai lavarlo, ma che d’altronde non usavano in battaglia: le fonti tramandano che fosse stato Licurgo a stabilire per i Lacedemoni indumenti rossi, perché essi non tolleravano la minima somiglianza con l’abbigliamento femminile. Plutarco invece riporta che gli Spartiati, i cittadini-guerrieri di Sparta discendenti dei Dori, che avevano occupato la Laconia e schiavizzato i Messeni, indossavano mantelli rossi in battaglia affinché non fossero visibili loro eventuali ferite, apparendo così invulnerabili. La falange oplitica appare come la logica trasposizione, sul campo di battaglia, di quello stretto cameratismo che veniva inculcato negli Spartiati e della loro società di «eguali» (ὅμοιοι).
 |
| La falange greca, formazione serrata con cui combattevano gli opliti dell'antica Grecia. |
La Tessaglia era famosa per i suoi cavalli e i suoi cavalieri. Durante la Guerra del Peloponneso, quando ad Atene, finita la politica di Cimone e dopo l'assassinio di Efialte, la guida politica passò a Pericle, Atene stupulò in chiave anti-spartana un'alleanza con Argo e con la Tessaglia, così da poter disporre di un potente esercito e di una cavalleria formidabile, oltre che della flotta più potente dell'Egeo. Nella seconda spedizione ateniese in Sicilia o grande spedizione ateniese in Sicilia, per distinguerla da quella del 427 a.C., avvenuta tra la primavera-estate del 415 e quella del 413 a.C., dopo le prime vittorie ateniesi, che avevano messo in seria difficoltà l'esercito siracusano, le sorti della guerra furono capovolte grazie ai rinforzi spartani sotto il comando di Gilippo, ma soprattutto si evidenziava la carenza della cavalleria.
 |
| Schema della battaglia di Leuttra, da https://it.wi kipedia.org/wiki/Battag lia_di_Leuttra#/media /File:Battle_of_Leuctra, _371_BC_-_Decisive_ action-it.png. |
Importanza della CAVALLERIA a CARTAGINE - Da QUI: Grande importanza nella storia militare dell'antichità ebbe la cavalleria cartaginese, specialmente con Annibale. Poiché gli eserciti cartaginesi dal principio del sec. V vennero sempre più largamente formati con mercenarî di svariata provenienza, la cavalleria cartaginese risultava composta da elementi di diverse nazionalità, con diversi armamenti diverse tattiche. I Numidi, longe primum equitum in Africa... genus (Liv., IX, 34, 5), ne formavano il grosso. Montati su piccoli e resistenti cavalli indigeni (a volte tenevano un cavallo dì ricambio), i Numidi, agilissimi, armati di un piccolo scudo di cuoio e di giavellotto, caricavano al galoppo il nemico gridando e scagliando le loro armi, ripetendo l'attacco se il primo impeto non fosse riuscito. Grande era la loro abilità nelle scorrerie e nelle esplorazioni ed erano terribili nell'inseguimento di una truppa battuta. Dopo la conquista della Spagna, si ebbero anche importanti contingenti di cavalleria spagnola, composti di mercenarî e di sudditi. I Cartaginesi reclutarono cavalieri mercenarî anche fra i Galli, i Campani d'Italia e altre popolazioni. La cavalleria cartaginese era necessariamente divisa per nazioni, suddivisa per provenienza (Numidi, Spagnoli, Galli, ecc.). L'ufficialità inferiore apparteneva alla stessa nazione della truppa e talvolta principi alleati comandavano l'intero loro contingente, ma i gradi elevati erano in genere affidati a Cartaginesi, specialmente quello di comandante l'intera cavalleria. Nelle guerre contro i Romani, i Cartaginesi furono in genere superiori nella cavalleria (contro Regolo, in Africa, schierarono 16.000 fanti e 2.000 cavalieri, Annibale disponeva di 11.000 cavalli alla Trebbia e 10.000 a Canne contro i 4.000 e 6.000 dei Romani: il rapporto risulterà invece inverso a Zama, quando i Numidi erano dalla parte di Scipione), e avevano inoltre migliorato l'armamento di parte della loro cavalleria, facendone una cavalleria di linea. Nelle battaglie annibaliche la cavalleria si schierava alle ali, con l'obiettivo di spazzar via la cavalleria nemica e avviluppare quindi la fanteria nemica: l'esempio classico è stata la battaglia di Canne.
CAVALLERIE degli ITALICI - Da QUI: Anche presso le popolazioni dell'Italia antica, nelle battaglie ai cocchi si aggiunse e poi subentrò completamente la cavalleria. Notizie sulla storia dell'arma della cavalleria ne abbiamo solo per Roma, ma i monumenti ci danno un'idea abbastanza chiara dell'armamento e del modo di combattere dei cavalieri italici, specialmente degli Etruschi e delle popolazioni sabelliche dell'Italia meridionale, la cui cavalleria è celebrata anche dalle fonti letterarie, specialmente la sannita e la campana. I cavalieri dell'Italia meridionale portavano elmo, spesso con cresta e penne o corna, corazza e alle volte anche un grande scudo, erano armati di una o due lance e per poter vibrare con maggior violenza il colpo o per altre circostanze particolari, smontavano talvolta da cavallo e combattevano a piedi.
 |
| Luoghi della Cultura celtica di Golasecca con le varie genti Liguri, Celto-Liguri e Celtiche lì stanziate. |
 |
| Stele di Bormio. |
 |
| Carta della Venetia, X Regio della Roma Imperiale. |
 |
| Cavallo degli antichi Veneti o Venetici. |
 |
La falange "pesante" Macedone. |
La Cavalleria superava il modello greco. Durante il V sec. a.C., l'urto della cavalleria macedone aveva sempre sortito un buon effetto sui compatti schieramenti delle falangi greche. Filippo, mentre da una parte riformava la fanteria con le migliori innovazioni che il mondo militare mediterraneo poteva fornire, si assicura anche di avere a propria disposizione corpi di cavalleria perfettamente addestrati.
La battaglia di Cheronea (del 338 a.C.) in Beozia, vinta da Filippo II di Macedonia, contiene in sé gli elementi che saranno tipici della tattica macedone alla base delle vittorie di Alessandro Magno, ovvero la collaborazione tra fanteria e cavalleria come armi combinate: la falange di picchieri utilizzata come elemento di arresto del nemico e la cavalleria come forza decisiva dello scontro (incudine e martello). La battaglia di Cheronea, combattuta dall'esercito macedone contro un esercito di alleati greci, è la prima nella quale vediamo in azione la tattica macedone. Reperti archeologici rinvenuti sul luogo della battaglia permettono di ipotizzare che sia stata anche la prima in cui la falange macedone adottò le sarisse.
La sarissa (in greco: σάρισα o σάρισσα) era la picca usata dai guerrieri del regno di Macedonia. Lunga fino a 6-7 metri, aveva corpo in legno di corniolo di grande diametro, una grossa punta di ferro (circa 30 cm) e un tallone anch'esso metallico. L'intera lunghezza dell'asta era ottenuta con due rami distinti di corniolo uniti da un tubo centrale di bronzo, utile anche per bilanciare il centro di gravità. Arma formidabile, se maneggiata da soldati ben addestrati, la sarissa poteva vanificare gli attacchi di un carro falcato, di una carica di cavalleria (risultato comunque ottenuto anche dai normali opliti della Grecia Antica) e frenare le cariche della temuta fanteria pesante greca.
Per contrastare l'invasione di Filippo, l'esercito alleato aveva condotto una campagna dilatoria, ma il macedone riuscì ugualmente a costringere il nemico alla battaglia presso l'acropoli di Cheronea, in Beozia. Dal corso degli eventi successivi, si desume che lo schieramento macedone si presentasse obliquo rispetto a quello delle poleis greche alleate, in posizione forte, con entrambi i fianchi protetti: quello sinistro appoggiato sulle pendici dell'acropoli e quello destro protetto da una palude.
 |
| Schema della battaglia di Cheronea, da https://it.wiki pedia.org/wiki/Battaglia_ di_Cheronea_(338_a.C.)#/ media/File:Battle_of_ Chaeronea_338_BC.png. |
Con l'andare del tempo entrerà nel meccanismo con un ruolo sempre più attivo anche la fanteria leggera, che a Cheronea non sembra aver avuto un ruolo particolarmente significativo, ma la macchina bellica macedone è già pronta a conquistare il mondo. Filippo II di Macedonia aveva: «costituito la prima ben equilibrata armata permanente nei Balcani; a cui poteva aggiungere i suoi sudditi stranieri, la cavalleria pesante tessala nella sua formazione "a diamante", i cavalieri leggeri ed i lanciatori di giavellotto delle tribù tracie, la fanteria greca che combatteva contro i compatrioti senza mostrare la minima riluttanza» (Robin Lane Fox). Scomparso il genitore, Alessandro ereditò quindi questa formidabile macchina bellica che, con la sua genialità strategica e la sua innegabile fortuna, fornirà all'esercito macedone la fama di invincibilità per almeno due secoli.
 |
| "Bucefalo", di Jacopo Rumignani, da https:// artemagazine.it/tag/de -m-venice-art- gallery-2/. |
 |
| Cavaliere legionario dal Tabularium di Roma: rilievo originale dell'episodio di Mezio Curzio al Lacus Curtius. Immagine di Lalupa - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=37054225. |
La funzione tattica della cavalleria legionaria di epoca regia e di inizio Repubblica, si basava sulla mobilità e aveva compiti di avanguardia ed esplorazione, di scorta, nonché per azioni di disturbo o di inseguimento al termine della battaglia o infine per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia e prestare soccorso a reparti di fanteria in difficoltà. I cavalieri usavano briglie e morsi, ma le staffe e la sella erano sconosciuti: non è quindi ipotizzabile una cavalleria "da urto". Quei cavalieri che, nelle stele funerarie appaiono armati di lancia e spada, protetti da un elmo, magari con scudo e piastra pettorale, erano molto probabilmente una sorta di fanteria oplitica mobile.
Tito Livio racconta che ancora nel 499 a.C., il dittatore Aulo Postumio Albo Regillense, ordinò ai cavalieri di scendere dai cavalli ed aiutare la fanteria contro quella dei Latini in prima linea: «Essi obbedirono all'ordine; balzati da cavallo volarono nelle prime file e andarono a porre i loro piccoli scudi davanti ai portatori di insegne. Questo ridiede morale ai fanti, perché vedevano i giovani della nobiltà combattere come loro e condividere i pericoli. I Latini dovettero retrocedere e il loro schieramento dovette ripiegare.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, II, 20). Si trattava delle fasi conclusive della battaglia del lago Regillo. I cavalieri romani risalirono, infine, sui loro destrieri e si diedero ad inseguire i nemici in fuga. La fanteria li seguì e venne conquistato il campo latino.
Marco Furio Camillo (in latino Marcus Furius Camillus; 446 a.C. circa - 365 a.C.) è stato un politico e militare romano oltre che statista, di famiglia patrizia. Censore nel 403 a.C., ha celebrato il trionfo quattro volte, cinque volte è stato dittatore ed è infine stato onorato con il titolo di Pater Patriae, Secondo fondatore di Roma.
 |
| Formazione a testuggine nella colonna traiana. Foto di Cristian Chirita - Opera propria CC BY- SA 3.0, https://commons.wikimedia .org/w/index.php?curid=819860 |
Le Centurie erano quindi le unità, originariamente di 100 uomini, in cui fu suddivisa la cittadinanza romana a scopo sia militare che politico, sulla base del censo. In ambito politico, l’ordinamento in centurie vigeva nell’assemblea popolare dei comizi centuriati mentre nell'ambito militare, la centuria era l’unità di base della legione. La centuria intesa come unità fondamentale della legione romana, raggruppava un numero variabile tra i sessanta e i cento uomini, ma in alcuni casi arrivava fino a 160 e in alcune fonti si racconta addirittura di centurie formate da 300 elementi. Il centurione comandava una centuria legionaria.
Il censo (lat. census), istituito da re Servio Tullio, era l'elenco dei cittadini e dei loro beni nella Roma antica. Il compito di stilare l'elenco era affidato ai censori. Col passare del tempo il termine venne inteso solamente come elenco dei beni posseduti. Secondo la tradizione, fu Servio Tullio a compiere una prima riforma timocratica dei cittadini romani, che li suddivise per patrimonio, dignità, età, mestiere, funzione, inserendo tali dati in pubblici registri. Tale riforma era fondamentale ai fini di stabilire quali cittadini dovessero prestare il servizio militare (obbligatoriamente e perciò chiamati adsidui).
Nell'esercito i più ricchi erano gli "equites", i cavalieri, appannaggio dell'aristocrazia, che potevano possedere e mantenere un cavallo e disporre inoltre di protezioni oltre alle armi offensive (elmi e corazze), anche se la cavalleria romana, oltre alla funzione di guardia del corpo dei comandanti, si basava sulla mobilità e aveva quindi solo compiti di avanguardia ed esplorazione, di ricognizione, scorta ed eventuale inseguimento al termine della battaglia; all'epoca fra l'altro non si usavano selle e staffe.
Da epoca remota, probabilmente dal tempo dell'introduzione dell'ordinamento timocratico, la cavalleria romana è permanente, nel senso che lo stato assicura il reclutamento della cavalleria corrispondendo a un numero fisso di cittadini (nell'epoca storica 1.800) un'indennità per l'acquisto di uno o due cavalli (aes equestre) e per il foraggio (aes hordiarium); si riconoscono cioè le speciali esigenze di addestramento e di allenamento che richiede il servizio a cavallo. La scelta dei cavalieri era fatta dai magistrati supremi, re e consoli nel tempo più antico, dai censori dopo l'istituzione di questa carica; e alle stesse persone spettava la rassegna periodica della cavalleria per accertarsi delle attitudini militari dei cavalieri e della tenuta delle cavalcature e delle armi. Lo stato si riservò tuttavia il diritto, almeno da una certa epoca, d'imporre il servizio a cavallo anche a coloro che, pur non godendo dell'assegno equestre, possedessero però un determinato patrimonio, che gli mettesse di provvedere con mezzi propri al reperimento di cavalli da guerra. Così si fissò per tempo il cosiddetto "censo equestre" e a questi cavalieri si ricorreva quando non fossero stati sufficienti gli equites equo publico.
I cittadini romani adsidui dovevano disporre di un reddito/capitale di valore superiore o pari a 11.000 assi e nel I sec. d.C. un asse valeva all'incirca 0,50 €. Dovevano potersi armare a proprie spese ed erano raggruppati in centurie distinte in cinque classi, sulla base del censo.
 |
| Asse dell'antica Roma repubblicana, caratterizzato dalla testa di Giano al diritto e da una prua di una galea al rovescio, da https://it.wikipedia.org/wiki /Asse_(moneta)#/media/File:Eckhel_i_3.jpg. |
Con il passaggio alla monetazione al martello, l'asse diventerà una moneta fiduciaria, il cui valore cioè non era più quello del metallo che la costituiva. Durante la Repubblica di norma l'asse era caratterizzato dalla testa di Giano al diritto e da una prua di una galea al rovescio. Un sesterzio equivaleva a quattro assi e nel I secolo d.C. con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme; quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa 2 €.
Lo schema del numero di centurie nell'esercito, espresso dalla ripartizione in classi a seconda del censo dei cittadini, dato da Livio in I, 43 (Tito Livio, Patavium, l'attuale Padova, 59 a.C. - Patavium, 17 d.C., è stato l'autore della “Ab Urbe condita”, una storia di Roma dalla sua fondazione fino al 9 a.C.) e da Dionisio in IV, 16 segg. (Dionigi di Alicarnasso o anche Dionisio di Alicarnasso, Alicarnasso, 60 a.C. circa - 7 a.C., la sua opera principale è stata Antichità romane) è il seguente:
 |
| Denario emesso da Gaio Cassio Longino nel 63 a.C.; un elettore ad un plebiscito che deposita la tabella col voto, contrassegnata da una V che sta per 'Vti rogas', equivalente ad un 'sì'. Da https: //commons.wikimedia.org/ wiki/File:Roman_Election.jpg |
 |
| Ricostruzione di Brenno dal Museo della Marina Francese, da https://it .wikipedia.org/w iki/Battaglia_del_ fiume_Allia#/me dia/File:Brennus _mg_9724.jpg |
Lo scontro fra i due eserciti avvenne sul fiume Allia, «ad appena undici miglia dalla città, là dove il fiume Allia, scendendo dai monti Crustumini in una gola profonda, si getta nel Tevere poco sotto la Via Salaria»; il fiume Allia corrisponde probabilmente all'attuale "Fosso Maestro", un piccolo affluente di sinistra del Tevere. Mentre l'esercito celtico con ogni probabilità era ben addestrato ed equipaggiato, sebbene desse l'impressione di avanzare come un branco di predoni non organizzato, quello romano era poco più che raccogliticcio e composto da due legioni più gli alleati latini. La condotta dei Romani, così come descritta dai primi analisti e da Tito Livio, appare presuntuosa e temeraria. I tribuni militari schierarono l'esercito «senza aver scelto in anticipo uno spazio per il campo, senza aver costruito una trincea che potesse fungere da riparo in caso di ritirata, dimentichi, per non dire degli uomini, anche degli dèi, non essendosi minimamente preoccupati di trarre i dovuti auspici e di offrire sacrifici augurali». Dopo le prime manovre (le riserve romane avevano conquistato un'altura e i Galli si erano diretti contro di loro), il grosso dell'esercito romano si diede a una fuga precipitosa prima ancora che cominciasse il combattimento.
 |
| Schema della battaglia dell'Allia, da https:// best5.it/post/le-5- sconfitte-peggiori- dellimpero-romano/ |
In seguito alla disfatta dell'Allia e al sacco di Roma del 390-388 a.C. che ne seguì, venne distrutto l'archivio di stato e molte fonti storiche andarono dunque perdute.
Al di là del nuovo intervento di Furio Camillo descritto da Eutropio: «Ma Camillo, che viveva da esiliato in una città vicina, portò il suo aiuto e sconfisse duramente i Galli. Ma non solo: Camillo inseguendoli ne fece tale strage che recuperò sia l'oro ch'era stato loro consegnato, sia tutte le insegne militari da essi conquistate. Così riportando il trionfo per la terza volta entrò in Roma e venne chiamato "secondo Romolo" come fosse egli stesso fondatore della patria.», pare che da lì i romani adottarono le necessarie misure per ottenere un esercito più mobile e compatto. Infatti in seguito, i Galli verranno vinti in molte battaglie successive: Battaglia del Sentino, Battaglia di Talamone, Battaglia del lago Vadimone, ecc.
 |
| Simbolo di manipolo, di MatthiasKabel - Opera propria QUI. |
 |
| Schieramento della legione manipolare secondo Tito Livio, di Cristiano64 - Opera propria, CC BY -SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=28075258. |
 |
| Ordine manipolare secondo Livio. Da Cristiano64-Opera propria, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index .php?curid=45852193 e https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid= 45852195 |
«Quando l'esercito aveva assunto questo schieramento, gli Hastati iniziavano primi fra tutti il combattimento. Se gli Hastati non erano in grado di battere il nemico, retrocedevano a passo lento e i Principes li accoglievano negli intervalli tra loro. [...] i Triarii si mettevano sotto i vessilli, con la gamba sinistra distesa e gli scudi appoggiati sulla spalla e le aste conficcate in terra, con la punta rivolta verso l'alto, quasi fossero una palizzata... Qualora anche i Principes avessero combattuto con scarso successo, si ritiravano dalla prima linea fino ai Triarii. Da qui l'espressione latina "Res ad Triarios rediit" ("essere ridotti ai Triarii"), quando si è in difficoltà.» (Livio, Ab Urbe condita libri, VIII, 8, 9-12.)
 |
| Scutum romano, di Redtony - Opera propria, CC BY -SA 3.0, https://com mons.wikimedia.org/ w/index.php?curid= 2704034 |
 |
| Tre pila romani, immagine: Bratislav - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:// commons.wikimedia .org/w/index.php?cu rid=24717003. |
Le prime versioni di pilum erano costituite da un bastone relativamente corto e da una punta più piccola di quella delle lance e probabilmente era chiamato iacula, ossia "oggetto da lancio", e adoperato per lo più dalle truppe da interdizione, i Velites. Le sue successive evoluzioni del II e I secolo a.C. lo portano ad essere un'arma più pesante e lunga in dotazione ai primi due ordini di soldati: i Principes e gli Hastati. In questo periodo il pilum gode della sua fortuna e vive la sua massima evoluzione con l'invenzione dell'accoppiata codolo piatto - anello antirottura (come nell'esempio di Oberaden), al fine di impedire che possa smorzare parte dell'energia nel piegamento o nella rottura. L'uso tattico del pilum aveva un'importante conseguenza: il lancio congiunto dalle prime file poteva fermare l'assalto del nemico con un urto letale creando grande scompiglio.
I tribuni militum consulari potestate (tribuni militari con potestà consolare) o più brevemente tribuni consolari, erano eletti con potere consolare durante il cosiddetto "conflitto degli ordini" che si era scatenato nella Repubblica Romana dall'anno 444 a.C. e si era poi riacceso dall'anno 398 a.C. al 394 a.C. e, dopo un breve interludio, dall'anno 391 a.C. fino al 367 a.C.
Normalmente si arruolava una legione all'anno, ma nel 366 a.C. successe per la prima volta che due legioni fossero arruolate in uno stesso anno.
 |
| Carta con i territori teatro della seconda guerra sannitica. |
Intorno al 310 a.C. le legioni erano comunque 4, e raggiunsero, durante le guerre annibaliche, il numero di 28. Le operazioni di mobilitazione, congedo e ripartizione delle legioni, erano ogni anno stabilite dal senato. Ancora all’epoca di Polibio (206 - 118 a.C.) era ritenuto normale il numero di 4.200 fanti per
Il contubernium era la più piccola unità militare dell'esercito romano e in epoca classica indicava anche un rapporto permanente tra servi o tra dominus e serva. Il contubernium era composto da otto uomini possibilmente facenti capo ad un decano e in alcuni casi uno o più servi erano a disposizione dei legionari che ne facevano parte, secondo le disponibilità economiche degli stessi soldati. Dieci contubernia formavano una centuria. I soldati di uno stesso contubernium condividevano la stessa tenda (per questo erano definiti contubernales) ed erano ricompensati o puniti insieme. Tale termine ha passato tutta la storia romana divenendo un termine adoperato addirittura dai soldati dell'esercito inglese del 1800 per indicare i compagni di tenda, esattamente come accadeva nelle legioni dell'antica Roma.
La decimazione era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti dell'antica Roma, per punire ammutinamenti o atti di codardia, uccidendo un soldato ogni dieci. La parola deriva dal latino decimatio che significava "eliminare uno ogni dieci". In questa accezione la decimazione è stata utilizzata ancora durante la prima guerra mondiale nel Regio Esercito del Regno d'Italia, e in Libia da parte del regime fascista italiano.
Il reparto che si voleva punire per decimazione, era diviso in gruppi di 10 legionari; ciascun gruppo sceglieva a sorte uno di loro che veniva ucciso dai suoi commilitoni per lapidazione o a bastonate. Ai soldati rimanenti era poi dato da mangiare un rancio a base di orzo invece che di frumento e quindi mandati a dormire all'addiaccio fuori dell'accampamento, senza la protezione del vallum. Il rischio e la paura di essere sorteggiati gravava indistintamente, dunque, su tutti. Polibio aggiunge che, nel caso fossero stati numerosi a commettere gli stessi reati sopra elencati, o che interi manipoli, pressati dal nemico, avessero abbandonato il proprio posto, i Romani preferivano evitare di infliggere a tutti quanti la pena della bastonatura (fustuarium) o della morte. La soluzione che essi avevano trovato era quella della decimazione. In questo caso, il tribuno, una volta riunita la legione, faceva condurre al centro dello spiazzo i responsabili dell'abbandono del posto, li rimproverava aspramente e poi alla fine sorteggiava tra tutti i colpevoli, ora cinque, ora otto, ora venti, in modo che il totale corrispondesse sempre alla decima parte del numero complessivo degli imputati.
Quali fossero le estensioni territoriali minime per ciascuna classe, non sappiamo, ma l'affollamento della prima classe sembra dimostrare che vi partecipassero tutti i proprietari che conservassero intera l'unità fondiaria (7 iugeri? Lo iugum nell'antica Roma era l'unità di misura di superficie equivalente a 0,252 ha e indicava il terreno arabile in una giornata da una coppia di buoi attaccati allo stesso giogo), e che alle classi inferiori fossero iscritti quelli che per ragioni ereditarie o di altro ordine possedessero di quella unità rispettivamente i tre quarti, la metà, un quarto, o una frazione minore.
La prima moneta standardizzata da parte dello stato Romano e stata l'aes grave (asse in italiano), introdotta con l'avvio dei commerci su mare intorno al 335 a.C.
 |
| Asse grave romano in bronzo del 240- 225 a.C. di 259,53 g, di Classical Numismatic Group, Inc. http://www .cngcoins.com, CC BY-SA 3.0 https ://commons.wikimedia.org/w/index .php?curid=37054217 |
Il peso dell'asse (aes grave) era pari ad una libbra romana (327,46 g) e avendo un peso costante può essere considerata come una prima unità di misura della monetazione, infatti il valore nominale, ossia quello "stampato, o meglio impresso sulla moneta" era uguale al valore intrinseco. Queste monete erano diverse per fattezza ma avevano lo stesso peso e quindi lo stesso valore standard. Multipli dell'asse furono il dupondio (2 assi), il tripondio (3 assi) ed il decusse (10 assi). Frazioni dell'asse furono il semisse (mezzo asse), il triente (un terzo d'asse), il quadrante (un quarto d'asse), il sestante (un sesto d'asse) e l'oncia (un dodicesimo d'asse).
Con il passaggio alla monetazione "al martello", l'asse diventerà una moneta fiduciaria, il cui valore non sarà più legato al contenuto in metallo. Il peso dell'asse conobbe una progressiva diminuzione, acquisendo via via il peso delle sue frazioni: mezza libbra romana nel 286 a.C., un sesto di libbra nel 268 a.C., 1 oncia (cioè un dodicesimo di libbra) nel 217 a.C. e mezza oncia nell'89 a.C. L'uso del bronzo in periodo repubblicano terminò nel 79 a.C., per riprendere solo durante il principato.
Nel I secolo d.C. con un asse si potevano acquistare 542 grammi di grano, due chili di lupini, un quarto di vino comune, mezzo chilo di pane, o entrare alle terme; quindi un asse poteva valere all'incirca 0,5 € e un sesterzio circa 2 €.
Lo schema del numero di centurie nell'esercito, espresso dalla ripartizione in classi a seconda del censo dei cittadini, dato da Livio in I, 43 (Tito Livio, Patavium, l'attuale Padova, 59 a.C. - Patavium, 17 d.C., è stato l'autore della “Ab Urbe condita”, una storia di Roma dalla sua fondazione fino al 9 a.C.) e da Dionisio in IV, 16 segg. (Dionigi di Alicarnasso o anche Dionisio di Alicarnasso, Alicarnasso, 60 a.C. circa - 7 a.C., la sua opera principale è stata Antichità romane) è il seguente:
Probabilmente la consapevolezza dei Romani di determinare il proprio destino (homus faber), concetto che li faceva sentire liberi da condizionamenti di entità immateriali e li rendeva consapevoli della propria autodeterminazione nella vita, gli permise la realizzazione di progetti grandiosi, in vari ambiti, compreso quello di modificare l'ambiente a misura delle proprie esigenze.
La prima strada consolare a essere costruita fu la Via Appia. La costruzione delle strade inizialmente era stata dettata dalla necessità di spostare rapidamente le truppe in qualsiasi regione conquistata, ed infatti le prime strade furono costruite proprio dai legionari. Anche se in principio avevano una funzione militare permisero un notevolissimo sviluppo al commercio dell'Urbe favorendo lo spostamento di merci e mercanti, oltre che della gente comune e dei messaggeri. In poco tempo le prime vie Consolari come: l'Appia, l'Aemilia, la Salaria, la Postumia ed altre, vennero prolungate, fino a formare un complesso sistema che permetteva di raggiungere qualsiasi punto dell'Impero in poco tempo; si calcola che furono costruite più di 29 strade che percorrevano oltre 120.000 Km (due volte il giro della Terra!). Le strade romane avevano il compito fondamentale di mettere in comunicazione Roma con il resto dello Stato nel modo più rapido effettuabile. Per questo venivano tracciate il più rettilinee possibile per evitare allungamenti, anche a costo di lasciare isolati i centri più piccoli, i quali venivano comunque collegati con vie secondarie. La necessità di superare ostacoli naturali come specchi d'acqua o colline per dare continuità al tracciato venne compiuta con la costruzioni di mirabili ponti, viadotti e gallerie in parte tuttora praticabili. Ricordiamo per tutti, il ponte più lungo dell'antichità costruito sul Danubio per volere di Traiano, con una lunghezza di oltre 2,5 km.
 |
| La via sacra dell'antica Roma. |
 |
| Le strade che gli antichi Romani hanno edificato in Italia. |
Nel II secolo d.C. l'Imperatore Marco Ulpio Traiano crea una un percorso alternativo tra Benevento e Brindisi passando attraverso gli Appennini, dando origine alla Via Appia Traiana, la quale permetteva di risparmiare oltre un giorno di marcia. Questa opera è ricordata sopratutto per il fatto che durante i lavori di costruzione, per riuscire a oltrepassare uno scaglione di roccia molto alto, i Romani lo fecero letteralmente tagliare e tutt'ora è possibile vedere ciò che ne resta.
VII. Via Latina: collegava l'Urbe direttamente con Capua passando per Anagnia, Frusino, Casinum.
IX. Via Salaria: prende il nome dalla materia prima (il sale) che per secoli fu trasportata lungo il suo tracciato. Essa partiva da Roma e giungeva fino Castrum Truentinum (Porto d’Ascoli), passando per Reate e Asculum.
X. Via Postumia: passando per la Pianura Padana univa Genua con Aquileia, attraversando Cremona, Verona, Vicetia.
XII. Via Cassia: congiungeva l'Urbe al Nord Italia, passando attraverso Arretium, Florentia, Pistoia, Luca.
 |
| Manto stradale sezionato che mostra i vari strati di cui erano costituite le strade romane. |
 |
| Roma nella tavola Peutingeriana, copia medievale di una antica carta Romana. |
 |
| Le strade che i Romani hanno edificato in Europa. |
 |
| La struttura degli acquedotti romani sopraelevati. |
 |
| Francia, ponte di acquedotto romano sul fiume Gard, che riforniva di acqua la città di Nemasus, l'odierna Nimes. |
Alcune derivazioni dall'acquedotto giungevano presso il Campidoglio e Trastevere.
 |
| Percorsi di Pirro nella penisola italica, da QUI. |
| Cartina della penisola italica nel 272 a.C. con l'estensione dei territori della Repubblica di Roma in rosso, i limiti a nord dei fiumi Magra e Rubicone. In blu i territori controllati da Cartagine. |
Nella prima fase della repubblica romana l'esercito aveva continuato ad evolversi e, sebbene tra i romani vi fosse la tendenza ad attribuire tali cambiamenti a grandi riformatori, è più probabile che i cambiamenti fossero il prodotto di una lenta evoluzione piuttosto che di singole e deliberate politiche di riforma.
Secondo il militare e storico greco Polibio (206 - 118 a.C.), l'adozione della formazione manipolare nella legione romana era stata probabilmente copiata da quella adottata dai Sanniti, quando avevano sconfitto i romani, nei loro territori a sud di Roma, durante la Seconda guerra sannitica. Non a caso Polibio scriveva dei Romani: «I Romani, quando vennero a conoscenza di [determinate] armi [e tattiche], subito le imitarono, perché più di qualsiasi altro popolo sono capaci di cambiare abitudini e di puntare al meglio.» (Polibio, VI, 25.11.)
I cittadini romani erano obbligati a prestare servizio militare, entro il quarantaseiesimo anno di età, per almeno 10 anni per i cavalieri e 16 anni per i fanti (o anche 20 in caso di pericolo straordinario).
Il cursus honorum prevedeva che nessuno potesse intraprendere la carriera politica senza aver prestato almeno 10 anni di servizio militare.
Erano esclusi dal servizio militare legionario coloro che avevano un censo inferiore alle 400 dracme (paragonabili a 4.000 assi secondo il Gabba, quindi molto meno del censo minimo del valore di 11.000 assi della prima età repubblicana) anche se venivano poi impiegati nel servizio navale.
Nell'esercito Romano i contingenti di cavalleria più numerosi erano formati dalle unità alleate dei socii italici (ovvero le Alae, poiché erano poste alle "ali" dello schieramento della legione), costituite dallo stesso numero di fanti della legione ma superiori di tre volte nei cavalieri (900 per unità).
Le unità alleate di socii (ovvero le Alae, poiché erano poste alle "ali" dello schieramento) erano costituite, invece di un numero pari di fanti, ma superiori di tre volte nei cavalieri (900 per unità). Sappiamo inoltre, sempre da Polibio, che se ai cavalieri romani erano date razioni mensili per sette medimni di orzo e due di grano (che il questore detraeva poi dallo stipendium), agli alleati (socii) invece erano dati gratuitamente un medimno e un terzo di frumento e cinque di orzo al mese, considerando che 1 medimno equivaleva a 52 kg.
Fondamentale novità del periodo relativo alla legione manipolare, dovendosi condurre campagne militari sempre più lontane dalla città di Roma, vide il proprio gruppo di genieri costretti a trovare nuove soluzioni difensive adatte al pernottamento in territori spesso ostili. Ciò indusse i Romani a creare, sembra a partire dalle guerre pirriche, un primo esempio di accampamento militare da marcia fortificato, per proteggere le armate romane al suo interno.
Nell'epoca classica, la cavalleria romana è attribuita alle legioni (ciò non escludeva però che sul campo di battaglia essa venisse riunita in una o due masse sulle ali) e secondo la proporzione tradizionale di 1 a 10, cioè 300 cavalieri per i 3000 fanti in linea della legione. L'armamento dei cavalieri, pesante nell'epoca regia, s'era venuto prima alleggerendo, e Polibio (VI, 25, 3 seg.; passo molto discusso) dice che la cavalleria romana più antica (III sec.?) non portava corazza ma un cinturone, due aste leggiere e senza σαυρωτήρ (punta al calcio della lancia) che servivano poco e si spezzavano facilmente, scudo leggero ovale e concavo di pelle di bue che si guastava con la pioggia e non assicurava una sufficiente protezione. Perciò la cavalleria romana all'età di Polibio aveva da tempo adottato un armamento regolamentare di tipo greco, che consisteva nell'elmo (cassis), di solito di tipo italico, corazza corta con gonnellino, di cuoio solo o con sopra una cotta di maglia metallica o a squame (lorica) o di maglia e squame combinate in varia forma, e scudo leggiero ovale di legno, cuoio e metallo (scutum equestre); armi offensive: una sola lancia con sauroter (dal greco antico "uccisore di lucertole", il tallone in metallo dell'asta) come l'hasta o la tragula e la spada che fu poi la iberica, portata a sinistra. I cavalieri ricevevano triplo soldo del fante, cioè un denaro al giorno, e tripla razione, ed erano dispensati dai lavori dell'accampamento, nel quale avevano invece per turno l'ispezione ai posti di guardia. Ma la cavalleria cittadina romana cominciò molto per tempo (già dalla fine del sec. III) a decadere come arma combattente. Molti degli equites prestavano servizio come magistrati o come ufficiali superiori e gli altri provavano una crescente riluttanza a servire nella truppa degli squadroni; gli equites si trasformarono così in una classe che, quando prestava servizio, esigeva di prestarlo come ufficiale. Il governo romano non tentò rimedî a questa trasformazione della cavalleria cittadina, che aveva cause profonde d'ordine politico e sociale, e provvide alla cavalleria degli eserciti ricorrendo sempre più largamente agli alleati e agli ausiliarî stranieri. Al tempo di Polibio, mentre il contingente di fanteria degli alleati era all'incirca pari o di poco superiore alla fanteria della legioni romane, quello della cavalleria era il triplo (Polib., VI, 26, 7); cioè per un esercito di due legioni sei alae di 300 cavalli comandate da ufficiali romani.
 |
Annibale Barca (Barca in cartaginese significava Folgore). |
La battaglia di Canne del 2 agosto del 216 a.C., è stata una delle principali battaglie della seconda guerra punica ed ebbe luogo in prossimità della città di Canne, nell'antica Apulia (Puglia odierna). L'esercito di Cartagine, comandato con estrema abilità da Annibale, accerchiò e distrusse quasi completamente un esercito numericamente superiore della Repubblica romana, guidato dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. È stata, in termini di caduti in combattimento, una delle più pesanti sconfitte subite da Roma, seconda solo alla battaglia di Arausio del 105 a.C., ed è considerata come una delle più grandi manovre tattiche della storia militare.
Ci sono tre resoconti principali della battaglia, nessuno di loro contemporaneo ad essa. Il più vicino è quello di Polibio, scritto 50 anni dopo la battaglia. Tito Livio ha scritto il proprio al tempo di Augusto, e Appiano di Alessandria ancora più tardi. Il resoconto di Appiano descrive eventi che non hanno alcuna relazione con quelli di Tito Livio e di Polibio. Polibio ritrae la battaglia come il nadir finale di fortuna romana, fungendo da espediente letterario in modo tale che la successiva ripresa romana fosse più drammatica. Ad esempio, alcuni sostengono che i suoi dati sulle vittime siano esagerati, "più simbolici che reali". Gli studiosi tendono a sottovalutare il resoconto di Appiano. Il giudizio di Philip Sabin "una farragine senza valore", è tipico.
Polibio narra che Annibale, ancor prima dell'arrivo dei nuovi consoli, mosse con le sue truppe da Geronio e, giudicando vantaggioso costringere i nemici a combattere a ogni costo, si impadronì della rocca della città di nome Canne, in una posizione strategica rispetto a tutto il territorio circostante. In questa i Romani avevano raccolto il grano e gli altri vettovagliamenti dal territorio di Canusio, e da qui li portavano nell'accampamento romano presso Geronio a mano a mano che se ne presentava il bisogno. Secondo i vari scrittori di epoca imperiale (secoli I-II d.C.), la rocca di Canne era situata nella Regio II Apulia et Calabria, presso il fiume Aufidus (l'odierno Ofanto); Annibale così si mise tra i Romani e le loro fonti principali di approvvigionamento. Come fa notare Polibio, la cattura di Canne «ha causato grande scompiglio nell'esercito romano, perché non è stata solo la perdita del posto e delle scorte in essa che li angosciava, ma il fatto che essa dominava il distretto circostante».I nuovi consoli, dopo aver deciso di affrontare Annibale, marciarono verso sud alla ricerca del generale cartaginese.
Riorganizzatisi dopo le precedenti sconfitte nelle battaglie della Trebbia (218 a.C.) e del lago Trasimeno (217 a.C.), i Romani avrebbero deciso di affrontare Annibale a Canne, con 8 legioni, circa 86.000 tra soldati romani e truppe alleate. Tuttavia, alcuni autori hanno suggerito che la distruzione di un esercito di 90.000 uomini sarebbe stata impossibile e sostengono che Roma abbia messo in campo probabilmente 48.000 fanti e 6.000 cavalieri contro i 35.000 fanti e i 10.000 cavalieri di Annibale. Anche se non esiste alcun numero definitivo delle truppe romane, tutte le fonti concordano sul fatto che l'esercito cartaginese affrontò un esercito avversario avente una grande superiorità numerica. Le legioni romane avevano due terzi degli effettivi costituiti da reclute, i cosiddetti tirones, ma c'erano almeno due legioni formate da legionari esperti e preparati, provenienti dall'esercito del console del 218 a.C., Publio Cornelio Scipione.
«Il Senato decise di mettere in campo otto legioni, il che non era mai stato fatto prima a Roma, ogni legione composta da 5.000 uomini, oltre agli alleati. [...] I Romani combattono la maggior parte delle loro guerre con due legioni al comando di un console, con i loro contingenti di alleati, e raramente utilizzano tutte e quattro le legioni in una sola volta e per un solo compito. Ma in questa occasione, tanto grande era l'allarme e il terrore di ciò che sarebbe potuto accadere, che decisero di mettere in campo non solo quattro, ma otto legioni.» (Polibio, Storie III, 107.9-11[16])
«Affermano alcuni che per reintegrare le perdite si arruolarono diecimila nuovi soldati; altri parlano di quattro legioni nuove, per affrontare la guerra con otto legioni; e si dice pure che le legioni furono accresciute di forze, tanto di fanti quanto di cavalieri, aggiungendo a ciascuna circa mille fanti e cento cavalieri, così che risultassero di cinquemila fanti e di trecento cavalieri, e che gli alleati diedero un numero doppio di cavalieri ed egual numero di fanti.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino) XXII, 36)
L'esercito cartaginese era composto da circa 10.000 cavalieri, 40.000 soldati della fanteria pesante e 6.000 della fanteria leggera sul campo di battaglia, esclusi i distaccamenti. L'esercito cartaginese era una combinazione di guerrieri reclutati in differenti aree geografiche. C'erano 22.000 fanti iberici e celti fiancheggiati da due corpi di fanteria pesante africana in riserva tattica, costituiti complessivamente da 10.000 libici. Anche la cavalleria proveniva da regioni diverse. Annibale disponeva di una cavalleria composta da 4.000 numidi, 2.000 iberici, 4.000 galli e 450 libici-fenici. Infine, Annibale aveva circa 8.000 guerrieri della fanteria leggera fra frombolieri delle Isole Baleari e lancieri di nazionalità mista. Ognuno di questi gruppi diversi di guerrieri apportava le sue specifiche qualità militari allo schieramento cartaginese. Il fattore unificante nell'esercito cartaginese era il forte legame di lealtà e fiducia che ciascun gruppo aveva con Annibale. Anche se normalmente i Cartaginesi schieravano elefanti nelle battaglie per terrorizzare i cavalli nemici e scompaginare la fanteria, nella battaglia di Canne non era presente alcun elefante, in quanto nessuno di quelli che erano partiti dall'Iberia e che riuscirono a valicare le Alpi era sopravvissuto.
Se l'esercito romano non fosse stato così numeroso, ciascuno dei due consoli avrebbe comandato la propria parte dell'esercito, ma dal momento che i due eserciti erano stati concentrati insieme, la legge romana prevedeva di alternare il comando su base giornaliera. È possibile che Annibale avesse capito che al comando dell'esercito romano si alternavano i due consoli e avesse pianificato la sua strategia di conseguenza. Nel racconto tradizionale Varrone deteneva il comando il giorno della battaglia ed egli avrebbe deciso di affrontare il combattimento in campo aperto, nonostante il parere contrario di Emilio Paolo: gran parte della colpa per la sconfitta è stata attribuita dagli storici antichi all'avventatezza del console popolare. Tuttavia esistono controversie riguardanti chi fosse realmente al comando il giorno della battaglia, poiché secondo alcuni studiosi potrebbe essere stato Emilio Paolo il capo dell'esercito quel giorno.
La cronologia degli avvenimenti secondo il racconto di Polibio, è semplice e chiara: il primo giorno (27 luglio) i Romani partirono da Geronio verso la località dove si trovavano i Cartaginesi. Sotto il comando di Emilio Paolo, giunti il secondo giorno (28 luglio) in vista dei nemici, si accamparono alla distanza di circa cinquanta stadi (circa 9,25 km) dalle loro posizioni. Nella giornata successiva (29 luglio) tolsero il campo per ordine di Varrone e avanzarono verso i Cartaginesi, ma vennero attaccati da Annibale mentre erano in marcia. Varrone respinse con successo l'attacco cartaginese e al sopraggiungere della notte gli avversari si separarono. Questa vittoria, in realtà una semplice scaramuccia senza alcun valore strategico, rafforzò fortemente la fiducia dell'esercito romano e avrebbe anche rinsaldato la sicurezza e l'aggressività di Varrone.
Il giorno successivo (30 luglio), per ordine di Emilio Paolo, i Romani costruirono due accampamenti presso il fiume Aufido: il maggiore, occupato da due terzi delle forze, su una riva del fiume a ovest, e il minore, con un terzo delle forze, sull'altra riva a levante del guado. Lo scopo di questo secondo accampamento sarebbe stato quello di proteggere le azioni di foraggiamento dall'accampamento principale e di intralciare quelle del nemico.
Secondo Polibio, i due eserciti rimasero nelle rispettive posizioni per due giorni. Durante il secondo giorno (1º agosto), Annibale, consapevole che Emilio Paolo era in quel momento al comando dell'esercito romano, lasciò il suo accampamento e schierò l'esercito per la battaglia. Emilio Paolo, tuttavia, non volle entrare in combattimento. Dopo che il nemico ebbe rifiutato di entrare in battaglia, Annibale, riconoscendo l'importanza dell'acqua dell'Aufidus per le truppe romane, mandò i suoi cavalieri numidi verso l'accampamento romano più piccolo per infastidire il nemico e per danneggiare l'approvvigionamento d'acqua. A questa circostanza forse si collega lo stratagemma, non riportato da Polibio, che Annibale avrebbe intorbidito l'acqua per rovinare la salute dei Romani o, addirittura, vi avrebbe fatto gettare dentro dei cadaveri. Secondo Polibio, la cavalleria di Annibale cavalcò audacemente fino ai limiti dell'accampamento minore romano, causando confusione e la completa interruzione dell'approvvigionamento di acqua. L'unico motivo che trattenne i Romani dall'attraversare immediatamente il fiume e disporsi a battaglia sarebbe stato il fatto che quel giorno il comando supremo era in mano ad Emilio Paolo. Così, il giorno successivo, Varrone, senza aver consultato il collega, fece esporre il segnale di battaglia e fece attraversare il fiume alle truppe schierate, mentre Emilio Paolo lo seguiva, poiché non poteva non assecondare questa decisione.
Annibale, nonostante la netta superiorità numerica del nemico, era assolutamente desideroso di combattere e, a dispetto dei timori e dei dubbi manifestati da alcuni suoi subordinati, mostrò fiducia e imperturbabilità davanti all'imponente schieramento romano che si stava accuratamente posizionando di fronte alle sue truppe a est del fiume, dove era l'accampamento minore romano, la mattina del 2 agosto. Infatti, secondo quanto riferisce Plutarco, a un ufficiale cartaginese di nome Gisgo che, stupefatto, aveva evidenziato quanto fosse sterminato l'esercito romano, Annibale avrebbe risposto ironicamente: «Un'altra cosa che ti è sfuggita, Gisgo, è ancora più sorprendente: che anche se ci sono così tanti Romani, non ce n'è nemmeno uno tra loro che si chiami Gisgo».
I consoli Terenzio Varrone ed Emilio Paolo scelsero coscientemente di affrontare la battaglia a est del fiume Aufidus, schierando il loro enorme esercito a nord delle forze avversarie, con fronte a mezzogiorno e il fianco destro a contatto con il corso del fiume, e ritennero di poter minimizzare la superiorità della cavalleria nemica e l'abilità tattica di Annibale proprio grazie alla configurazione del terreno. Varrone e Paolo credevano che i legionari, numericamente superiori, avrebbero duramente pressato i Cartaginesi, fino a spingerli nel fiume dove, senza spazio di manovra, sarebbero morti nel panico. Tenendo presente che le due vittorie precedenti di Annibale erano state in gran parte decise dalla sua abilità e scaltrezza, Varrone e Paolo ricercarono un campo di battaglia scoperto e privo di insidie. Il campo di Canne sembrava corrispondere a questa esigenza, perché privo di luoghi dove nascondere truppe per compiere un agguato al nemico; inoltre, la presenza di alcune colline sul fianco sinistro dei Romani avrebbe dovuto impedire anche in questa zona le agili manovre della cavalleria numida ed evitare manovre di aggiramento in profondità.
Annibale non era preoccupato per la sua posizione vicina al fiume Aufidus; al contrario, questo fattore venne da lui utilizzato per favorire la sua strategia. A causa del fiume i Romani non avrebbero potuto effettuare una manovra a tenaglia intorno all'esercito cartaginese, in quanto uno dei fianchi dell'esercito di Annibale era schierato troppo vicino al fiume. I Romani erano intralciati sul loro fianco destro dal fiume Aufidus, e quindi il fianco sinistro era l'unica via praticabile di ripiegamento. Inoltre, le forze cartaginesi avrebbero manovrato in modo che i Romani avessero la faccia rivolta a sud. In tal modo il sole del mattino batteva l'una e l'altra parte, molto opportunamente, di fianco, e il vento a tergo dei Cartaginesi avrebbe alzato polvere contro le facce dei Romani. In ogni caso la straordinaria distribuzione dell'esercito effettuata da Annibale, basata sull'analisi del territorio e sulla sua comprensione delle capacità delle proprie truppe, si rivelò decisiva.
 |
| Prima fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |
La cavalleria pesante ibero-celtica, schierata sul fianco sinistro attaccò quindi violentemente la cavalleria romana, impiegando una tattica inconsueta, ma ben preparata e non prevista dai Romani; Asdrubale ordinò una carica corpo a corpo. Polibio narra come i cavalieri ispanici e celti affrontarono la battaglia a piedi dopo essere scesi dai cavalli in quello che egli considera un metodo barbaro di combattere. I Romani, sorpresi dall'attacco, urtati e pressati dai nemici, schiacciati sia nelle prime linee sia in quelle più indietro dello schieramento, dovettero scendere dai loro cavalli, probabilmente anche per la difficoltà di controllarli e perché impossibilitati a manovrare in uno spazio troppo stretto. In tal modo uno scontro di cavalleria si trasformò in prevalenza in un combattimento tra cavalieri appiedati.
«L'ala sinistra della cavalleria gallica e ispanica si azzuffò con l'ala destra romana, non tuttavia in forma di combattimento equestre: bisognava infatti lottare frontalmente poiché non era presente attorno spazio per evoluzioni; da un lato le serravano le schiere dei fanti e dall'altro il fiume. Si urtarono dunque da entrambe le parti in linea di fronte; forzati a immobilità dalla calca i cavalli, i cavalieri si abbrancavano l'uno per gettar l'altro di sella. La battaglia era ormai divenuta prevalentemente pedestre; tuttavia si combatté più aspramente che a lungo, e i cavalieri romani, respinti, volsero in fuga.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 47)
«Dopo dunque la disposizione di tutto il suo esercito in linea retta, prese le compagnie centrali degli Ispanici e dei Celti e avanzò con loro, mantenendo il resto della linea in contatto con queste compagnie, ma a poco a poco essi si staccarono, in modo tale da produrre una formazione a forma di mezzaluna, la linea delle compagnie fiancheggianti stava crescendo in sottigliezza poiché era stata prolungata, il suo scopo era quello di impiegare gli Africani come forza di riserva e di iniziare l'azione con gli Ispanici ed i Celti» (Polibio, Storie III, 113)
Si ritiene che lo scopo di questa formazione sia stato quello di rompere lo slancio in avanti della fanteria romana, e ritardare la sua avanzata prima di altri sviluppi autorizzati da Annibale per distribuire la sua fanteria africana nel modo più efficace. Detto questo, mentre la maggior parte degli storici ritengono che l'azione di Annibale sia stata deliberata, ci sono quelli che hanno chiamato questo racconto di fantasia, e sostengono che le azioni descritte rappresentino prima la curvatura naturale che si verifica quando un ampio fronte di fanteria marcia in avanti e poi (quando il senso della mezzaluna si invertì) la ritirata del centro cartaginese causata dall'azione scioccante di incontrare il centro della linea romana dove le forze erano grandemente concentrate.
Dopo la breve fase iniziale degli scontri tra i reparti di fanteria leggera, le legioni romane, guidate dai consolari Marco Minucio Rufo e Gneo Servilio Gemino, diedero inizio al loro massiccio attacco frontale da cui i consoli si attendevano risultati decisivi; in formazione serrata, protetti dai lunghi scudi affiancati, con i gladi pronti sulla mano destra, i legionari si avvicinarono metodicamente alla mezzaluna formata dalla fanteria ibero-gallica urtando inizialmente solo la punta dello schieramento avversario. Con i manipoli schierati in file profonde e i legionari più esperti presenti nelle prime linee e nelle zone centrali delle legioni, i Romani, oltre 55.000 soldati contro circa 20.000, esercitarono un urto irresistibile contro il sottile fronte nemico.
Sull'ala destra dell'esercito Cartaginese, i Numidi si impegnarono per agganciare e trattenere la cavalleria alleata ai Romani e la battaglia in questo settore si prolungò senza risultati decisivi. Dopo aver sconfitto la cavalleria romana, i cavalieri ispanici e gallici di Asdrubale accorsero in aiuto dei Numidi e la cavalleria alleata ai Romani venne sopraffatta e si disperse abbandonando il campo di battaglia. I Numidi li inseguirono fuori dal campo.
 |
| Seconda fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |
Tito Livio inserisce nella sua narrazione l'episodio di un inganno della cavalleria leggera cartaginese: «All'ala sinistra dei Romani, dove contro i Numidi stavano i cavalieri degli alleati, ardeva la battaglia [...] Circa cinquecento numidi, che oltre le solite armi e i giavellotti avevano gladii nascosti sotto le corazze, erano avanzati allontanandosi dai loro compagni fingendosi disertori, con gli scudi dietro le spalle; poi celermente erano scesi da cavallo, e, gettati ai piedi dei nemici gli scudi e i dardi, furono accolti in mezzo allo schieramento e, condotti nelle ultime file, ebbero l'ordine di fermarsi là dietro. Finché la battaglia non fu accesa da tutte le parti, stettero fermi; quando poi la lotta tenne occupati gli occhi e l'animo di tutti, allora, dato piglio agli scudi, che giacevano sparsi qua e là tra i mucchi degli uccisi, assalirono i soldati romani alle spalle, e, ferendoli alla schiena e tagliando loro i garetti, produssero grande strage, spavento e confusione anche maggiori.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 48)
Mentre i Romani avanzavano, il vento dall'Est secondo Theodore Dodge o il Volturno da sud secondo Livio soffiava polvere nei loro volti e oscurava la loro visione. Mentre il vento non è stato un fattore importante, la polvere che entrambi gli eserciti crearono dovrebbe essere stato invece un fattore limitante per la vista. Anche se la polvere avesse reso la vista difficile, le truppe sarebbero state comunque in grado di vedere gli altri a distanza ravvicinata. La polvere, però, non era l'unico fattore psicologico coinvolto nella battaglia. Perché la posizione della battaglia era alquanto distante da entrambi gli accampamenti, entrambe le parti sono state costrette a combattere dopo un riposo notturno insufficiente. I Romani affrontarono un altro inconveniente causato dalla mancanza di una corretta idratazione a causa dell'attacco di Annibale contro l'accampamento romano durante il giorno precedente. Inoltre, il numero molto elevato di truppe provocò una straordinaria quantità di rumore di fondo. Tutti questi fattori psicologici resero la battaglia particolarmente difficile per i fanti.
Battaglia di Canne 216 a.C. - Distruzione dell'esercito romano
Dopo meno di un'ora di scontri corpo a corpo tra gli ibero-galli e le disciplinate legioni romane, imbattibili in uno scontro frontale per la coesione dello schieramento, la capacità dei centurioni e la superiorità dell'armamento, le linee cartaginesi iniziarono a ripiegare subendo numerose perdite. Annibale iniziò quindi il ritiro controllato dei suoi uomini nel debole centro del fronte. La mezzaluna delle truppe ispaniche e galliche si piegò verso l'interno, a mano a mano che i guerrieri si ritiravano. Conoscendo la superiorità dei legionari romani, Annibale aveva istruito la sua fanteria a ritirarsi volontariamente, creando così un semicerchio sempre più serrato intorno alle forze attaccanti romane. In questo modo, aveva trasformato la forza d'urto delle legioni romane, guidate anche dal console Emilio Paolo che era sopravvissuto allo scontro tra le cavallerie, in elemento di debolezza. Inoltre, mentre le prime file stavano avanzando gradualmente, la maggior parte delle truppe romane cominciò a perdere la coesione, in quanto esse cominciarono ad affollarsi in avanti per accelerare la prevista vittoria. Ben presto sotto la pressione delle linee successive lo schieramento delle legioni divenne ancor più serrato, massiccio e compresso, limitando gli spazi e la libertà di movimento dei legionari.
In questa fase critica Annibale e Magone riuscirono nel difficile compito di evitare un crollo totale delle forze ibero-galliche e a mantenere uno schieramento difensivo che, pur subendo pesanti perdite, non si frantumò ma riuscì a ripiegare lentamente conservando la coesione e permettendo al condottiero cartaginese di completare la sua audace manovra combinata sui fianchi e alle spalle della grande massa delle legioni in formazione serrata anche perché, premendo in avanti con la volontà di schiacciare al più presto le truppe ispaniche e galliche, i Romani avevano ignorato (forse a causa anche della polvere) le truppe africane che si trovavano non impegnate sulle estremità sporgenti della mezzaluna ormai rovesciata.
 |
| Terza fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |
Grazie alla manovra, sebbene la fanteria ibero-galla avesse subito perdite di oltre 5.000 uomini per la micidiale potenza d'urto frontale dei legionari romani, Annibale riuscì a guadagnare il tempo necessario alla cavalleria cartaginese per costringere alla fuga la cavalleria romana su entrambi i fianchi e per attaccare il centro romano nella parte posteriore. Inoltre fece in modo che i Romani esponessero pericolosamente i fianchi dove erano schierati i reparti meno esperti delle legioni romano-italiche.
La fanteria romana, ormai esposta su entrambi i fianchi a causa della disfatta della cavalleria, aveva quindi formato un cuneo spinto sempre più in profondità nel semicerchio cartaginese, avanzando in una breccia avente ai lati la fanteria africana. A questo punto, Annibale ordinò alla sua fanteria africana, che aveva addestrato a combattere in formazioni meno serrate, corpo a corpo con il gladio, rinunciando alle tattiche oplitiche, di girare verso l'interno e avanzare contro i fianchi del nemico, creando un accerchiamento delle legioni romane in uno dei primi esempi conosciuti di manovra a tenaglia.
Quando la cavalleria cartaginese attaccò i Romani alle spalle, ed i fanti africani li assalirono sui fianchi destro e sinistro, la fanteria romana in avanzata frontale fu costretta a fermarsi. Sui fianchi i legionari romani si trovarono in grave difficoltà e, sorpresi dalla comparsa della fanteria pesante africana, non riuscirono a contenere il nemico. Rifluendo indietro con gravi perdite questi reparti laterali andarono ad urtare le altre linee delle legioni, costringendole ad arrestarsi, accrescendo la confusione ed impedendo alla massa dei legionari di entrare in combattimento a causa della mancanza di spazio.
 |
| Quarta fase della battaglia di Canne, da https://best5.it/post /le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |
Il console Emilio Paolo, anche se all'inizio del combattimento era stato gravemente ferito da una fionda, decise di rimanere sul campo e di combattere fino alla fine; in alcuni punti riaccese la battaglia, sotto la protezione dei cavalieri romani. Infine mise da parte i cavalli, perché gli mancavano anche le forze per riuscire a rimanere in sella. Livio narra che allorché Annibale apprese che il console aveva ordinato ai cavalieri di smontare a piedi, avrebbe detto: «Quanto preferirei che me li consegnasse già legati!». Il console aristocratico alla fine cadde valorosamente sul campo, bersagliato dai nemici in avanzata, senza essere stato riconosciuto. Cowley afferma che per sei ore, circa 600 legionari furono massacrati ogni minuto; fino a quando l'oscurità pose fine alla carneficina.
«Tante migliaia di Romani stavano morendo [...] Alcuni, le cui ferite erano eccitate dal freddo mattino, nel momento in cui si stavano alzando, coperti di sangue, dal mezzo dei mucchi di uccisi, erano sopraffatti dal nemico. Alcuni sono stati trovati con le teste immerse nelle buche in terra, che avevano scavato; avendo, così come si mostrò, realizzato buche per loro stessi, e essendosi soffocati.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 51).
Dopo la morte di Emilio Paolo, i superstiti fuggirono in modo disordinato: settemila uomini ripiegarono nell'accampamento più piccolo, diecimila in quello più grande, e circa duemila nello stesso villaggio di Canne; questi furono subito accerchiati da Cartalone e dai suoi cavalieri, poiché nessuna fortificazione proteggeva il villaggio. Nei due accampamenti i soldati romani erano quasi disarmati e privi di comandanti; quelli dell'accampamento maggiore chiesero agli altri di unirsi a loro, mentre la stanchezza ancora ritardava l'arrivo dei nemici, esausti dalla battaglia e impegnati nei festeggiamenti per la vittoria, si sarebbero diretti tutti insieme a Canusio. Alcuni respinsero la proposta bruscamente, chiedendo perché dovessero essere loro a esporsi tanto al pericolo andando all'accampamento maggiore e non potessero invece essere gli altri ad andare da loro. Ad altri non tanto spiaceva la proposta quanto mancava il coraggio di muoversi.
La sera, avendo raggiunto la vittoria completa, i Cartaginesi sospesero l'inseguimento dei nemici, tornarono nell'accampamento e, trascorse alcune ore di festa, si misero a dormire. Durante la notte, a causa dei feriti che giacevano ancora sulla piana, riecheggiarono lamenti e grida. La mattina successiva iniziò la depredazione, da parte dei Cartaginesi, dei corpi dei Romani caduti in battaglia. Poiché l'odio mortale e inestinguibile che i Cartaginesi provavano per i loro nemici non era stato placato dal massacro di 40.000 di loro, essi picchiarono e pugnalarono i feriti ancora in vita ovunque li trovarono, come una sorta di passatempo mattiniero dopo le dure fatiche dei giorni precedenti. Questo massacro, tuttavia, potrebbe difficilmente essere considerato una crudeltà verso le povere vittime, perché molti di loro scoprirono il proprio petto agli assalitori, e invocarono il colpo mortale che avrebbe posto fine alle loro sofferenze. Durante l'esplorazione del campo, un soldato cartaginese fu trovato ancora vivo, ma imprigionato dal cadavere del suo nemico Romano disteso su di lui. Il volto del cartaginese e le sue orecchie erano orrendamente lacerate. Il romano, cadendo su di lui quando entrambi erano gravemente feriti, aveva continuato a battersi con i denti, poiché non riusciva più a usare la sua arma, e morì alla fine, bloccando il suo nemico esausto con il proprio corpo esanime.
Polibio scrisse che della fanteria romana e degli alleati, 70.000 furono uccisi, 10.000 catturati, e "forse" solo 3.000 sopravvissero. Egli riferisce anche che dei 6.000 cavalieri romani e alleati, solo 370 riuscirono a mettersi in salvo.
Tito Livio scrisse: «45.000 fanti, si dice, e 2.700 cavalieri, metà romani e metà alleati, caddero uccisi: tra essi i due questori dei consoli: Lucio Atilio e Lucio Furio Bibàculo, e ventinove tribuni dei soldati, alcuni consolari e già stati pretori o edili (tra essi Cneo Servilio e Marco Minucio, che era stato maestro della cavalleria l'anno precedente e console alcuni anni addietro); e inoltre ottanta/novanta senatori o eleggibili senatori per le cariche già esercitate, i quali si erano arruolati come volontari. 3.000 fanti e 1.500 cavalieri si narra che furon fatti prigionieri. Altre uccisioni e migliaia di prigionieri verranno fatti tra i milites delle due legioni lasciate a difesa e come riserva negli accampamenti]» Anche se Livio non cita la sua fonte con il nome, è stato probabilmente Quinto Fabio Pittore, uno storico romano che ha combattuto nella Seconda guerra punica, che scrisse riguardo ad essa. È Pittore colui che Livio nomina quando riferisce le perdite nella battaglia del Trebbia. In seguito tutti gli storici romani (e greco-romani) seguirono in gran parte le cifre di Livio. Appiano di Alessandria disse che 50.000 furono uccisi e "moltissimi" furono presi prigionieri. Plutarco era d'accordo, «50.000 Romani caddero in quella battaglia [...] 4.000 sono stati presi vivi». Quintiliano scrisse: «60.000 uomini sono stati uccisi da Annibale a Canne». Eutropio: «20 funzionari consolari e di rango pretorio, 30 senatori e 300 altri di discendenza nobile sono stati presi o uccisi così come 40.000 fanti e 3.500 cavalieri.»
La maggior parte degli storici moderni, pur considerando le cifre di Polibio errate, sono disposti ad accettare le cifre di Livio. Alcuni storici più recenti sono giunti a cifre molto più basse. Cantalupi propose che le perdite romane siano state fra le 10.500 e le 16.000 unità. Anche Samuels considera le cifre di Livio come troppo elevate per il fatto che la cavalleria sarebbe stata insufficiente per prevenire la fuga della fanteria romana. Egli dubita anche che Annibale Barca volesse un alto numero di morti poiché gran parte dell'esercito era composto da italici che egli sperava di avere come alleati in futuro.
Tito Livio riferisce che Annibale perse 6.000 o circa 8.000 uomini. Polibio riporta 5.700 morti: 4.000 galli, 1.500 spagnoli e africani, e 200 cavalieri. Annibale comandò che allo splendore dell'aurora del giorno seguente si desse sepoltura ai compagni morti con roghi funebri.
Verso la fine della battaglia, un ufficiale romano di nome Lentulo, mentre stava fuggendo a cavallo, vide un altro ufficiale seduto sulla pietra, debole e sanguinante. Quando scoprì che era Emilio Paolo gli offrì il proprio cavallo, ma Emilio, vedendo che era troppo tardi per salvare la propria vita, declinò l'offerta ed esortò Lentulo a fuggire al più presto dicendo: «Vai avanti, quindi, tu stesso, il più veloce che puoi, sfrutta al meglio la tua strada verso Roma. Chiama le autorità locali qui, da me, che tutto è perduto, e devono fare ciò che essi possono per la difesa della città. Vai più veloce che puoi, o Annibale sarà alle porte prima di te.» Emilio mandò un messaggio anche a Fabio, declinando le proprie responsabilità nella battaglia e dichiarando che aveva fatto ciò che era in suo potere per continuarne la strategia. Lentulo, avendo ricevuto questo messaggio, e vedendo che i Cartaginesi gli erano vicini, se ne andò, abbandonando Emilio Paolo al suo destino. I Cartaginesi, accortosi dell'uomo ferito, infilzarono le lance uno alla volta nel suo corpo, finché non smise di muoversi. Il giorno dopo la battaglia Annibale si compiacque di onorare il nemico ordinando il funerale del console Emilio Paolo. Il suo corpo fu posto su un rogo altissimo e fu elogiato da Annibale, che gettata sul cadavere una clamide tessuta d'oro e un drappo fiammeggiante di cupa porpora, gli diede così l'estremo addio: «Va, o gloria d'Italia, ove dimorano spiriti eccelsi d'insigne valore! La morte ti diede già lode immortale mentre la Fortuna agita ancora i miei eventi e mi nasconde l'avvenire».
Varrone invece si rifugiò a Venosa con un drappello di circa cinquanta cavalieri e decise che avrebbe cercato di radunare lì i resti dell'esercito.
«Mai prima d'ora, mentre la stessa città era ancora sicura, c'era stato tanto turbamento e panico tra le sue mura. Non cercherò di descriverlo, né io indebolirò la realtà andando nei dettagli. Dopo la perdita di un console e dell'esercito nella battaglia del Trasimeno l'anno precedente, non fu una ferita dopo l'altra, ma una strage molto (più) grande quella che era stata appena annunciata. Secondo le fonti due eserciti consolari e due consoli sono stati persi, non c'era più nessun accampamento romano, nessun generale, nessun soldato in esistenza, Puglia, Sannio, quasi tutta l'Italia giaceva ai piedi di Annibale. Certamente non c'è altro popolo che non avrebbe ceduto sotto il peso di una simile calamità.» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri (testo latino), XXII, 54.)
Per un breve periodo di tempo, i Romani furono nel caos completo. I loro migliori eserciti nella penisola erano stati distrutti, i pochi restanti erano fortemente demoralizzati, e l'unico console restante (Varrone) era completamente screditato. Fu una catastrofe terribile per i Romani. Come si racconta, Roma dichiarò una giornata di lutto nazionale, in quanto non c'era nessuno a Roma che non avesse una qualche relazione con una persona che vi era morta o che non ne fosse almeno conoscente. Le principali misure adottate dal Senato furono di cessare tutte le processioni pubbliche, vietare alle donne di uscire di casa e punire i venditori ambulanti, tutte queste decisioni per fermare il panico. Divennero così disperati che, guidati dal ceto politico senatorio in cui era ritornato a dominare Quinto Fabio Massimo Verrucoso, ricorsero al sacrificio umano, due volte seppellendo persone vive al Foro di Roma e abbandonando un bambino di grandi dimensioni nel Mare Adriatico. Tito Livio riporta che il sacrificio fu decretato dai "decemviri sacrorum" dopo una loro consultazione dei Libri Sibillini (libri fatales). In base al responso di procedere con "sacrificia aliquot extraordinaria" (alcuni sacrifici straordinari), furono seppelliti vivi nel Foro Boario un uomo e una donna celti e due greci. Prima di tali cruenti riti, Plutarco ricorda come nel 228 a.C., si fosse già proceduto ad analoghi sacrifici umani prima della guerra contro gli Insubri (forse uno degli ultimi casi registrati di sacrifici umani che i Romani avrebbero eseguito, a meno che le esecuzioni pubbliche dei nemici sconfitti dedicate a Marte vengano contate). Lucio Cecilio Metello, un tribuno militare, è noto per aver molto disperato per la causa romana in seguito alla battaglia, tanto da ritenere che tutto fosse perduto e perciò invitò gli altri tribuni a fuggire via mare all'estero e prestare servizio per qualche principe straniero. In seguito per questa sua proposta fu costretto a pronunciare un giuramento indissolubile di fedeltà a Roma.
Inoltre, i sopravvissuti romani di Canne furono successivamente riuniti in due legioni e assegnati alla Sicilia per il resto della guerra, come punizione per il loro umiliante abbandono del campo di battaglia. Oltre alla perdita fisica del suo esercito, Roma avrebbe sofferto una sconfitta simbolica di prestigio. Un anello d'oro era un segno di appartenenza alle classi patrizie della società romana. Annibale con il suo esercito aveva raccolto più di 200 anelli d'oro dai cadaveri sul campo di battaglia, e questa collezione è stata ritenuta essere pari a "tre moggi e mezzo", vale a dire più di 27 litri. Inviò, nelle mani del suo fratello Magone Barca, tutti gli anelli a Cartagine come prova della sua vittoria. La collezione fu versata sul vestibolo della curia cartaginese.
Annibale, dopo aver ottenuto l'ennesima vittoria (dopo le battaglie della Trebbia e del Lago Trasimeno), aveva sconfitto l'equivalente di otto eserciti consolari (sedici legioni oltre a un numero uguale di alleati). Nel giro delle tre stagioni della campagna militare (20 mesi), Roma aveva perso un quinto (150.000) di tutta la popolazione di cittadini che aveva oltre i diciassette anni di età. Inoltre, l'effetto morale di questa vittoria fu tale che la maggior parte dell'Italia meridionale si vide indotta ad aderire alla causa di Annibale. Dopo la battaglia di Canne, le province meridionali greche di Arpi, Salapia, Herdonia, Uzentum, comprese le città di Capua e Taranto (due delle più grandi città-stato in Italia) revocarono tutte la loro fedeltà a Roma e promisero la loro lealtà ad Annibale. Come nota Polibio, «Quanto più grave è stata la sconfitta di Canne, rispetto a quelle che l'hanno preceduta, lo si vede dal comportamento degli alleati di Roma; prima di quel fatidico giorno, la loro lealtà rimase irremovibile, ora ha cominciato a vacillare per la semplice ragione che disperano del potere romano.» Nello stesso anno, le città greche in Sicilia sono state indotte alla rivolta contro il controllo politico romano. Il re macedone Filippo V, aveva promesso il suo appoggio ad Annibale e venne pertanto avviata la prima guerra macedonica contro Roma. Il neo re Geronimo di Siracusa, sovrano dell'unica località della Sicilia che era indipendente, concordò un'alleanza con Annibale.
Dopo la battaglia, Maarbale, comandante della cavalleria numida, esortò Annibale a cogliere l'opportunità e marciare immediatamente su Roma dicendo: «Anzi, perché tu ben sappia quanto si sia ottenuto con questa giornata, [io ti dico che] fra cinque giorni banchetterai vincitore sul Campidoglio. Seguimi, io ti precedo con la cavalleria, affinché ti sappiano giunto prima di apprendere che ti sei messo in marcia». Si dice che il rifiuto di quest'ultimo abbia provocato un'esclamazione di Maarbale: «Gli dei evidentemente non hanno concesso alla stessa persona tutte le doti: tu sai vincere, Annibale, ma non sai approfittare della vittoria». Ma Annibale aveva buone ragioni per giudicare la situazione strategica dopo la battaglia in modo diverso da come fece Maarbale. Come sottolinea lo storico Hans Delbrück, a causa dell'elevato numero di morti e feriti tra i suoi ranghi, l'esercito punico non era in condizione di eseguire un attacco diretto su Roma. Una marcia verso la città sul Tevere sarebbe stata una dimostrazione inutile che avrebbe annullato l'effetto psicologico di Canne sugli alleati di Roma. Anche se il suo esercito fosse stato in piena forza, un assedio di successo di Roma avrebbe richiesto ad Annibale di sottomettere una parte considerevole dell'entroterra al fine di garantire il proprio approvvigionamento ed impedire quello del nemico. Anche dopo le perdite enormi subite a Canne, e la defezione di un certo numero di suoi alleati, Roma aveva ancora manodopera abbondante per evitare questo e per mantenere allo stesso tempo forze considerevoli in Iberia, in Sicilia, in Sardegna e altrove, nonostante la presenza di Annibale in Italia. Come dice Sean McKnight, dell'accademia militare di Sandhurst: «I Romani probabilmente avevano a disposizione ancora molti uomini disposti ad arruolarsi, la città avrebbe radunato nuove truppe e si sarebbe difesa strenuamente, impegnare il suo esercito in un'impresa così rischiosa avrebbe potuto vanificare le vittorie della campagna militare. Ma forse considerando che Annibale alla fine perse la guerra, era un rischio che avrebbe dovuto correre.». Il comportamento di Annibale dopo le vittorie sul Trasimeno (217 a.C.) e a Canne (216 a.C.), e il fatto che abbia attaccato per la prima volta la stessa Roma solo cinque anni più tardi (nel 211 a.C.), suggerisce che il suo obiettivo strategico non era la distruzione del suo nemico, ma scoraggiare i Romani con una serie di stragi sui campi di battaglia e ridurli ad un accordo di pace moderata privandoli dei loro alleati.
Subito dopo Canne, Annibale inviò Cartalone a Roma per negoziare un trattato di pace con il Senato in termini moderati. Eppure, nonostante le molteplici catastrofi che Roma aveva sofferto, il Senato romano rifiutò di trattare. Anzi, raddoppiò nuovamente gli sforzi dei Romani, dichiarando piena mobilitazione della popolazione maschile romana e creò nuove legioni arruolando contadini senza terra e persino gli schiavi.] Queste misure erano tanto severe che la parola “pace” fu proibita, il lutto era limitato a soli 30 giorni e l'esternazione del proprio dolore in pubblico fu vietata anche alle donne. I Romani, dopo aver vissuto questa sconfitta catastrofica e perso altre battaglie, avevano a questo punto imparato la lezione. Per il resto della guerra in Italia, non avrebbero più accumulato grandi forze sotto un unico comando contro Annibale, come era stato durante la battaglia di Canne, invece avrebbero utilizzato molteplici eserciti indipendenti, ancora superando le forze puniche nel numero di eserciti e di soldati. Questa guerra ebbe ancora battaglie occasionali, ma fu incentrata maggiormente attorno al prendere capisaldi e ad un combattimento costante, secondo la strategia di Quinto Fabio Massimo. Ciò infine costrinse Annibale con la sua carenza di personale a ritirarsi a Crotone, da dove venne richiamato in Africa per la battaglia di Zama, ponendo fine alla guerra con una completa vittoria romana.
La battaglia di Canne è rimasta famosa per la tattica seguita da Annibale e per il ruolo che rivestì nella storia di Roma. Si trattò forse del più sanguinoso scontro campale in assoluto in un solo giorno combattuto in occidente. In questa occasione, non solo Annibale inflisse una sconfitta alla Repubblica romana in una maniera che non si sarebbe ripetuta per oltre un secolo, fino alla meno nota battaglia di Arausio, ma ebbe anche luogo una battaglia destinata ad acquisire una notorietà significativa nel campo dell'intera storia militare. Come storico militare, Theodore Ayrault Dodge ha scritto: «Poche battaglie dei tempi antichi sono maggiormente segnate dall'abilità strategica [...] rispetto alla battaglia di Canne. La situazione era tale da rendere tutti i vantaggi dalla parte di Annibale. Le modalità secondo cui avanzarono i piedi iberici e gallici ben lungi dall'essere perfetti in una linea a scalare, […] si trattennero e poi si ritirarono passo dopo passo, finché non avessero raggiunto la posizione inversa [...] è un capolavoro semplice di tattiche di combattimento. L'avanzamento al momento opportuno della fanteria africana, e la sua conversione a destra ed a sinistra sui fianchi dei legionari romani disordinati ed ammassati, è molto oltre la lode. L'intera battaglia, dal punto di vista cartaginese, è un'eccellente opera d'arte, poiché non ci sono, nella storia della guerra, esempi che la superino, mentre pochi la eguagliano.»
Come scrisse Will Durant: «È stato un supremo esempio di abilità militare, mai superato nella storia [...] e fissò le linee delle tattiche militari per 2.000 anni.» Si tratta, fra l'altro, del primo utilizzo attestato di manovra a tenaglia nel mondo occidentale.
Considerata l'esempio per eccellenza di scaltrezza e di abilità di manovra, è ancora oggi la battaglia più studiata da militari e da esperti di tattica e strategia. Oltre a essere una delle più grandi sconfitte mai inflitte all'esercito romano, la battaglia di Canne rappresenta l'archetipo della battaglia di annientamento. Lo scontro assunse un ruolo "mitico" anche nella scienza strategica degli eserciti moderni; in particolare, lo stato maggiore tedesco-prussiano considerò lo schema strategico della battaglia di Canne come un punto di arrivo ideale da ricercare costantemente in guerra. Come Dwight D. Eisenhower, comandante supremo delle forze di spedizione alleate nella seconda guerra mondiale, scrisse una volta: «Ogni comandante di terra cerca la battaglia di annientamento; nella misura in cui le condizioni lo permettano, cerca di duplicare nella guerra moderna l'esempio classico di Canne».
 |
| Publio Cornelio Scipione detto poi l'Africano, dal Museo Puškin di Mosca. Di shakko - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://co mmons.wikimedia.org/w/ ùindex.php?curid=5654234. |
Dopo una serie di pesanti sconfitte, il sinedrio cartaginese aveva deciso di richiamare Annibale dall'Italia. Nel 203 a.C., il Barcide toccò il suolo africano, dopo 33 anni, nella Byzacena, ad Hadrumetum (oggi Susa), 80 km più a sud di dove la sua famiglia aveva dei possedimenti.
Barcidi erano chiamati i componenti della famiglia di Annibale, tra le più in vista dell'aristocrazia dell'antica Cartagine. Grandissima nemica di Roma, la famiglia si distingueva dal soprannome di Amilcare, padre di Annibale, Asdrubale e Magone oltre a tre femmine, detto "Barak", ovvero "folgore", "fulmine", per le sue qualità di condottiero di eserciti e di politico decisionista. Secondo un'altra interpretazione il nome di Barca deriverebbe da "Baruk" ovvero "il benedetto" a indicare una particolare protezione da parte degli Dèi. "Barca" non è quindi un cognome vero e proprio che, come nell'uso romano, stava ad indicare una famiglia o una gens. Amilcare Barca fu un generale davvero geniale e innovativo: perfezionò la manovra avvolgente, ereditata dall'Oriente ellenistico e da Santippo, e introdusse un metodo per frenare gli elefanti da guerra imbizzarriti, in modo da evitare che si volgessero contro le unità dell'esercito punico: dotò i cornac (i conducenti) di mazzuoli e grandi chiodi che, all'occorrenza, venivano conficcati nel cranio degli animali, uccidendoli.
Appena sbarcato con i suoi 15.000 veterani, Annibale si diede a risistemare l'esercito cartaginese, ricevendo nuove reclute da Cartagine oltre ai mercenari di Asdrubale Giscone e del proprio fratello Magone Barca, (figlio minore di Amilcare Barca) per prepararsi a combattere una battaglia che sapeva essere decisiva. I Punici, sicuri della vittoria, rifiutarono il trattato di pace offerto da Scipione, che immediatamente si diede a devastare i territori dell'interno della Tunisia, mentre richiamava Massinissa e la sua cavalleria, impegnati a pacificare alcune zone del regno numida in rivolta.
Da https://www.skuolasprint.it/versione-livio/annibale-parla-a-scipione-prima-della-battaglia-di-zama-A_92046.html, il discorso di Annibale a Scipione: "Certamente sarebbe stato molto meglio che ci fosse quel pensiero, dato dagli dei ai nostri padri, che con il dominio, sia voi dell'Italia, sia noi dell'Africa, saremmo stati contenti. E certo nemmeno per voi Sicilia e Sardegna sono compensazioni sufficienti per la perdita di tante flotte, di tanti eserciti, di tanti straordinari comandanti persi; ma i tempi passati si possono criticare più che correggere. E così abbiamo desiderato le cose altrui così che ora dobbiamo combattere per i nostri, così che non c'è solo la guerra per noi in Italia e per voi in Africa, ma come voi avete visto le insegne e le armi dei nemici quasi alle vostre porte e alle mura, così noi udiamo da Cartagine lo strepito degli accampamenti romani. Ciò che noi soprattutto vorremmo scongiurare e voi, invece, vorreste desiderare, poiché vi trovate in una situazione più favorevole, è considerare la possibilità della pace. A trattare siamo dunque noi, ai quali soprattutto interessa che si faccia la pace, le nostre città accetteranno senz'altro le condizioni decise da noi: quello che conta è che il nostro animo non sia alieno da progetti di pace. Per quanto mi riguarda, ormai l'età, le fortune e le avversità ammaestrarono me, che ritorno vecchio in patria da dove partii fanciullo, al punto da farmi preferire di seguire i consigli della ragione piuttosto che le vicende della fortuna; mi fanno paura la tua giovinezza ed i tuoi continui successi, dai quali proviene quell'orgoglio che è nemico delle soluzioni pacifiche. Colui che la fortuna non ha mai abbandonato, difficilmente considera le incertezze della sorte. Oggi sei tu quello che io fui al Trasimeno e a Canne. La fortuna in nessuna circostanza ha mai tradito te che hai fin da principio affrontato ogni tua impresa con incredibile audacia, per quanto avessi assunto il supremo comando in età appena atta al servizio militare."
Preciso che non sappiamo esattamente dove fosse il sito chiamato Zama in cui si svolse la battaglia.
 |
| Romani e Cartaginesi schierati a Zama. Di Mohammad adil at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.o rg/w/index.php?curid= 17974420. |
 |
| Parte degli elefanti scompaginano la cavalleria numidica cartaginese che viene annientata da quella di Massinissa, mentre gli altri elefanti si incanalano nei corridoi della fanteria romana. Di Mohammad adil en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ w/index.php?curid=17974405. |
A questo punto la battaglia era diventata piuttosto ardua per la compagine romana. Pur avendo probabilmente subito perdite minori rispetto ai Punici, i combattimenti con le prime due linee cartaginesi avevano permesso ad Annibale di fiaccare i fanti romani, nonché di sfruttare nel migliore dei modi la superiorità numerica. Infatti, i ripiegamenti dei mercenari e dei cittadini punici, avevano permesso di coprire i fianchi ai veterani d'Italia, che erano ancora freschi e saldi al centro dello schieramento cartaginese.
 |
| Lo scontro frontale fra fanterie nella battaglia di Zama. Di Mohammad adil en.wikipedia CC BY-SA 3.0, https://commons .wikimedia.org/w/index. php?curid=17974395. |
 |
| Con la fanteria romana schierata al massimo dell'estensione e del conseguente assottigliamento, vista l'inferiorità numerica, torna la cavalleria che attacca i punici alle spalle. Immagine ricavata da Mohammad adil en.wikipedia CC BY-SA 3.0, https://comm ons .wikimedia.org/w/index. php?curid=17974395. |
 |
| Carta che riepiloga date e scontri durante la seconda guerra punica. Di Mediterranean at 218 BC-en.svg: Goran tek-enderivative work: Cristiano64 - Questo file deriva da: Mediterranean at 218 BC -en.svg: Goran tek-en, CC BY-SA 4.0,https://com mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42832111. |
Fonti storiografiche riportano un primo conteggio di quattro legioni durante la guerra latina (340-338 a.C.), a cui andava sommato un numero pari di truppe alleate di fanteria e un numero triplo di cavalleria, il quale arriva al suo apice durante la seconda guerra punica dove l'esercito romano arrivò a contare ben 23 legioni tra cittadini romani e Socii (nel 212-211 a.C.); si trattava di una forza pari a circa 115.000 fanti e 13.000 cavalieri in base alle fonti, che non tenevano conto delle truppe dislocate in Spagna, agli ordini dei fratelli Gneo e Publio Scipione.
 |
| Gladio |
 |
| Formazione a testuggine nella colonna traiana. Foto di Cristian Chirita - Opera propria CC BY- SA 3.0, https://commons.wikimedia .org/w/index.php?curid=819860 |
Un primo esempio di formazione “a testuggine” utilizzato dalla fanteria romana, viene menzionato da Tito Livio durante l’assedio di Veio e di quello di Roma degli inizi del IV secolo a.C.. In questa situazione i soldati romani serravano le file e si avvicinavano tra loro, quasi fossero delle tegole di un tetto che ripara dalla “pioggia di dardi e frecce”, sovrapponendo gli scudi, tenendoli di fronte a loro ed alzati sulle loro teste. La testuggine era una sorta di carro armato dell’antichità, che avanzava sotto i colpi degli arcieri nemici, limitando al minimo le perdite. Ovviamente questo tipo di formazione aveva anche i suoi punti deboli, primo fra tutti la lentezza e per questo era spesso utilizzata negli assedi, per avvicinarsi alle mura avversarie, oppure in battaglia in campo aperto, quando i legionari si trovavano circondati da ogni lato, come accadde nella campagna partica di Marco Antonio.
Perché fosse efficace la testuggine necessitava di grande affiatamento di reparto, coordinazione nei movimenti ed esercitazioni specifiche, vediamo ora come Cassio Dione la descrive: « Descriverò ora la formazione a testuggine e come si forma. I bagagli, la fanteria leggera ed i cavalieri sono collocati al centro dello schieramento. Una parte della fanteria pesante, armata con gli scudi concavi semicircolari, si dispone a forma di quadrato (agmen quadratum) ai margini dello schieramento, con gli scudi rivolti verso l’esterno a protezione della massa. Gli altri che hanno gli scudi piatti, si raccolgono nel mezzo e stringendosi alzano gli scudi in aria a difesa di tutti. Per questo motivo, in tutto lo schieramento si vedono solo gli scudi e tutti sono al riparo dalle frecce nemiche, grazie alla compattezza della formazione. […] I Romani ricorrono a questa formazione in due casi: quando si avvicinano ad una fortezza per conquistarla […]; o quando, circondati da ogni parte da arcieri nemici, si mettono in ginocchio in contemporanea, compresi i cavalli che sono addestrati a mettersi sulle ginocchia o a sdraiarsi a terra. così fanno credere al nemico di essere sfiniti e quando i nemici si avvicinano, si alzano all’improvviso e li annientano. ».
 |
| Lapide di eques da QUI. |
 |
| Denario del 96 a.C. col busto di Diana e sul retro tre cavalieri al galoppo che seguono uno stendardo verso un nemico (latino) caduto. In esergo: A ALBINVS S F. Denario romano coniato da Aulo Postumio Albino nel 96 a.C. per ricordare il suo avo; i cavalieri, sul rovescio, ricordano la battaglia del lago Regillo dove, secondo la tradizione, Aulo Regillense lanciò uno stendardo tra le schiere nemiche. Di Classical Numismatic Group, Inc. http:/ /www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia .org/w/index.php?curid=10473541. |
 |
| Il generale e più volte console Gaio Mario. |
Da questa premessa il console di quell'anno, Gaio Mario, decise di aprire le legioni a chiunque, che fosse o meno possidente, senza discriminazioni di censo e sarebbe stata la Repubblica ad assumersi l'onere di equipaggiare, rifornire e retribuire le truppe legionarie, permettendo a tutti, compresi i nullatenenti, di arruolarsi.
Precedentemente le centurie di Romani avevano doveri sia civili (elettorali nei comizi centuriati) che militari nelle legioni, ma dalla riforma militare dell'esercito voluta da Gaio Mario, con la quale l'esercito diveniva volontario e quindi di professione,
Il servizio militare era remunerato con uno stipendio, atto che poneva le fondamenta per un esercito di professionisti ed era inoltre consuetudine assegnare appezzamenti di terreno nei territori conquistati o nelle colonie, ai militari congedati, nella misura proporzionale al loro grado. : l’esercito era costituito da molte legioni affiancate da reparti di auxilia di fanteria leggera e cavalleria,
Il primo centurione, (Prior) della prima coorte, era chiamato "primipilo" (Primus pilus), un grado di grandissimo rilievo nella legione e forse l'unico grado che oggi potremmo considerare come quello di "ufficiale", riportato alla codifica moderna. In ogni centuria erano presenti quelli che si potrebbero definire "sottufficiali", come il Tesserarius, il responsabile delle parole d'ordine, il Signifer, il portainsegne di reparto, l'Optio, una sorta di centurione dormiente in grado di prendere il posto in battaglia di quello operativo se ucciso e il Buccinator, il trombettiere responsabile dei comandi sonori. Molti altri ruoli erano presenti all'interno di ciascuna centuria, con compiti diversi e non sempre relativi a specialità belliche, forse con la sola eccezione degli artiglieri.
Nel 106 a.C. il console Quinto Servilio Cepione marcia da Narbona, alla testa di ben 8 legioni (composte di 5 000÷6 000 armati l'una), contro le tribù ribellatesi a Roma stanziate nella zona di Tolosa. Si racconta che Cepione cercasse, all'interno della città di Tolosa e per diversi giorni, il tesoro di cui narrava una leggenda, un'enorme quantità di oro che pare fosse custodita nei santuari dei templi (il cosiddetto Oro di Tolosa o Aurum Tolosanum). Non trovando nulla, decise di prosciugare i laghi vicini alla città e ritrovò così sotto la melma 50.000 lingotti d'oro, 10.000 lingotti d'argento e macine interamente in argento, una fortuna incredibile. Durante il trasporto verso Massilia (l'odierna Marsiglia), nel tratto tra Tolosa e Narbona, dove avrebbe dovuto essere imbarcato), 1.000 predoni si impadronirono dei 450 carri che trasportavano i soli lingotti d'oro. A Roma si sospettò dello stesso Cepione, che però fu confermato nel comando anche per l'anno successivo, ma si unì a lui nelle operazioni in Gallia meridionale anche uno dei due nuovi consoli, Gneo Mallio Massimo.
Al pari di Gaio Mario, anche Gneo Mallio Massimo era un uomo nuovo, che non faceva cioè parte di alcuna élite romana e la collaborazione fra lui e Quinto Servilio Cepione si dimostrò fin da subito impossibile. Nel 105 a.C., Cimbri, Teutoni e Ambroni erano apparsi sul corso del fiume Rodano proprio mentre l'esercito di Mallio si trovava nella stessa zona. Cepione, che era accampato sulla riva opposta del fiume, si rifiutò in un primo momento di venire in soccorso del collega minacciato, decidendosi ad attraversare il fiume solo dopo che il Senato gli aveva ordinato di cooperare con Mallio. Tuttavia si rifiutò di unire le forze dei due eserciti mantenendosi a debita distanza dal collega. Il primo scontro si ebbe 65 km a nord di Arausio (l'attuale Orange in Francia) quando un certo Marco Aurelio Scauro, alla testa di 5.000 cavalieri, ingaggiò una prima battaglia, che gli fu sfavorevole, con le avanguardie della coalizione germanica. I successivi due scontri si rivelarono disastrosi per entrambi i comandanti romani. Prima Cepione (alla testa di 7 legioni) fu battuto a 48 km a Nord di Arausio e poi Manlio (alla testa delle 7 legioni precedenti a cui se ne erano aggiunte altre 2) a soli 8 km a nord di Arausio, il 6 ottobre del 105 a.C., subì una nuova disfatta. I Romani dovettero combattere con il fiume alle spalle che impediva loro la ritirata e, stando alle cronache, furono uccisi 80.000 soldati e 40.000 ausiliari. Dopo gli scontri, i Cimbri si spostarono in direzione dell'Hispania per dedicarsi al saccheggio della penisola iberica mentre Teutoni e Ambroni si stanziarono nella Gallia Narbonense, diventata dal 121 a.C. provincia romana.
Le perdite subite nel decennio precedente erano state molto gravi, ma questa sconfitta, provocata soprattutto dall'arroganza della nobiltà che si rifiutava di collaborare con i più capaci capi militari non nobili, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non soltanto le perdite umane erano state enormi, ma l'Italia stessa era ormai esposta all'invasione delle orde barbariche. Il malcontento del popolo contro l'aristocrazia stava raggiungendo ormai l'esasperazione. Nell'autunno del 105, mentre si trovava ancora in Africa, Gaio Mario fu rieletto console. L'elezione in absentia era una cosa abbastanza rara e inoltre una legge successiva all'anno 152 a.C., imponeva un intervallo di almeno 10 anni fra due consolati successivi, mentre sembra che una legge del 135 a.C. addirittura proibisse che questa carica potesse essere rivestita per due volte dalla stessa persona. La grave minaccia incombente dal nord fece tuttavia passare sopra ad ogni legge e consuetudine e Mario, ritenuto il più abile comandante disponibile, sarà rieletto console per ben 5 volte consecutive, dal 104 al 100 a.C., cosa mai avvenuta in precedenza.
 |
| Gaio Mario. Immagine © José LuizBernardes Ribeiro,CCBY-SA4.0 https://commons.wiki media.org/w/index.ph p?curid=62268155. Da https://it.wikiquote. org/wiki/Gaio_Mario #/media/File:Bust_of_ Marius_(GL_319)_- _Glyptothek_-_Munich _-_Germany_2017.jpg |
Nel 103 a.C. i Germani indugiavano ancora nelle proprie scorribande in Hispania ed in Gallia e questo fatto, insieme alla morte del console collega Lucio Aurelio Oreste, consentì a Gaio Mario, che stava già marciando verso nord, di rientrare a Roma per venirvi confermato console per l'anno 102 a.C., insieme ad un nuovo collega, Quinto Lutazio Càtulo.
Gaio Mario (Cereatae, nel territorio del comune di Veroli, in provincia di Frosinone, oggi Casamari, da "casa Marii",157 a.C. - Roma, 13 gennaio 86 a.C.) è stato un "uomo nuovo", che non faceva cioè parte di alcuna élite romana. Militare e politico romano, per sette volte è stato console della Repubblica romana. Lo storico Plutarco gli dedicherà una delle sue "Vite parallele", raffrontandolo al re d'Epiro Pirro, della stirpe macedone di Alessandro. La carriera di Gaio Mario non sembrava destinata a grandi successi fino al 110 a.C., quando gli fu proposto un matrimonio con una giovane esponente dell'aristocrazia, Giulia Maggiore, sorella del senatore Gaio Giulio Cesare il vecchio e futura zia di Gaio Giulio Cesare. Mario accettò, divorziando dalla sua prima moglie Grania di Pozzuoli. La gens Iulia era una famiglia patrizia di antichissime origini (faceva risalire la propria discendenza a Iulo, figlio di Enea, e a Venere, dea della bellezza), ma nonostante ciò i suoi appartenenti avevano, per ragioni finanziarie, notevoli difficoltà a ricoprire cariche più elevate di quella di pretore (solamente una volta, nel 157 a.C. un Giulio Cesare era stato console). Il matrimonio permise alla famiglia patrizia di rimettere in sesto le proprie finanze e diede a Mario la legittimità per candidarsi al consolato. Da sottolineare comunque che Gaio Mario è stato il campione del partito dei populares così come Lucio Cornelio Silla lo è stato degli aristocratici optimates e lo stesso Gaio Giulio Cesare rimarrà fedele ai populares fino al suo assassinio, avvenuto nel Senato, il tempio degli optimates patrizi, i patres della patria.
 |
| Invasione di Cimbri e Teutoni. Croci verdi per le loro vittorie e croci rosse per le sconfitte. Immagine di TcfkaPanairjdde - Cimbri ans and Teutons.png, CC BY-SA 3.0, https://comm ons.wikimedia.org/w/ind ex.php?curid=4033347. Da https://it.wikipedia. org/wiki/Guerre_cimbric he#/media/File:Cimbrians _and_Teutons_-_it.png |
Nel 102 a.C. i Cimbri dall'Hispania tornano in Gallia e insieme ai Teutoni e agli Ambroni, decidono un attacco congiunto alla Repubblica romana. Dalla Gallia, i Teutoni e gli Ambroni avrebbero dovuto puntare a sud-est dirigendosi verso le coste del Mediterraneo, mentre i Cimbri dovevano penetrare nell'Italia Settentrionale da nord-est attraversando il passo del Brennero (”per alpes Rhaeticas”). Infine i Tigurini, la tribù celtica loro alleata che aveva sconfitto Longino nel 107, progettava di attraversare le Alpi provenendo da nord-ovest. La decisione di dividere in questo modo le loro forze si sarebbe dimostrata fatale, poiché diede ai Romani, avvantaggiati anche dalle linee di approvvigionamento molto più corte, la possibilità di affrontare separatamente i vari contingenti, concentrando le proprie forze laddove era di volta in volta necessario. Così mentre Ambroni e Teutoni transitavano nella Gallia Narbonense (a est di Marsiglia) verso l'Italia, i Cimbri si dirigevano verso il passo del Brennero (”per alpes Rhaeticas”) per poi entrare da lì in Italia. Il console Gaio Mario decise così di intercettare Teutoni e Ambroni, che si trovavano in quel momento nella provincia romana della Gallia Narbonense e si stavano dirigendo verso le Alpi alla volta dell'Italia, stabilendo un campo sul loro percorso.
 |
| Aquilifer. Immagine di Marten253 - Opera propria, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikime dia.org/w/index.ph p?curid=4285150. |
Gli Ambroni e i Teutoni, guidati dal loro re Teutobod, assaltarono il campo romano venendo respinti e decisero quindi di proseguire verso l'Italia aggirando il campo, ma Mario li seguì accampandosi vicino a quella che sarebbe passata alla storia col nome di battaglia di Aquae Sextiae (l'attuale Aix en Provence, insediamento fondato dal console Gaio Sestio Calvo nel 109 a.C.), in modo da sbarrare il cammino ai Germani. Gaio Mario aveva organizzato nel migliore dei modi la propria armata, i soldati erano stati sottoposti ad un addestramento che mai in precedenza si era visto, e si erano abituati a sopportare senza lamentele le fatiche delle lunghe marce e dell'allestimento di accampamenti e macchine da guerra, tanto da meritarsi il soprannome di muli di Mario. Ad Aquae Sextiae, alcuni contingenti di Ambroni, l'avanguardia dell'esercito dei Germani, si lanciarono avventatamente all'attacco delle posizioni romane, senza aspettare l'arrivo di rinforzi, attaccando i Romani mentre stavano attingendo acqua da un vicino fiume. I Liguri, alleati dei Romani, accorsero ad aiutarli ricacciando gli Ambroni al di là del fiume. Secondo Plutarco, in occasione della battaglia di Aquae Sextiae del 102 a.C., quando i Liguri alleati dei romani urlarono "Ambrones!" come grido di battaglia, ottennero in risposta lo stesso grido dal fronte opposto dei Celti Ambroni, che seguendo i costumi celtici, urlavano il nome della propria tribù durante le entrate in battaglia. Da ciò deriva l'ipotesi di una derivazione culturale o contaminazione, nel settentrione italico, dei Celti dai Liguri (la cui originaria espansione si estendeva presumibilmente dalla penisola a quella iberica e nella Francia meridionale prima dell'espansione dei Celti, mentre i Romani consideravano gli Ambroni Germani, non Celti. Queste circostanze suggeriscono la presenza di etnie miste, probabilmente in origine liguri poi celtiche così come etnie celtiche assimilate poi dai Germani. Non solo gli Ambroni provenivano da una regione settentrionale recentemente germanizzata, ma in quel periodo le tribù germaniche venivano pesantemente influenzate dalla cultura celtica.
Nella battaglia di Aquae Sextiae (ad Aix-en-Provence), i Romani ricompattarono i ranghi rigettando gli Ambroni che tentavano di nuovo di oltrepassare il fiume e lì gli Ambroni persero buona parte delle loro forze e 30.000 di loro rimasero uccisi. Gaio Mario schierò poi un contingente di 3.000 uomini per tendere un'imboscata al grosso dell'esercito dei Germani, che presi alle spalle e attaccati frontalmente, furono completamente sterminati e persero 100.000 uomini mentre quasi altrettanti ne furono catturati. Gli Ambroni furono annientati e, fondendosi con i Celti locali, diedero vita ad una nuova tribù, gli Aduatuci, storia che si può trovare nella vita di Gaio Mario nell'opera "Vite Parallele" di Plutarco scritta nell'80. Dopo la battaglia, i Teutoni non verranno più nominati nelle fonti romane. Le parti dell'esercito teutone sopravvissute alla sconfitta si stabilirono presso la Mosa sotto il nome anch'essi, di Aduatuci. Verosimilmente, ancora nel II - III secolo d.C., risiedevano nei dintorni del Meno. Dalle loro prime vittorie contro gli eserciti romani, si era creato un collegamento fra i Teutoni ed il terrore che avevano generato, così che gli storici romani parlavano di furor teutonicus, furore teutonico. A partire dalla tarda età carolingia, l'aggettivo latino teutonicus venne utilizzato per indicare la popolazione residente nell'Impero carolingio che non parlasse una lingua romanza (così come il termine "theod" da cui deriva "theodiscus" da cui "tedesco") e nel corso del Medioevo, venne utilizzato come traduzione per deutsch, tedesco (ad esempio, Ordo Teutonicus o ordine dei Cavalieri Teutonici, è la traduzione di Deutscher Orden). A volte, un "tedesco tipico" viene indicato come teutone o teutonico nel senso di "un uomo di forma possente e robusta" o di deutschtümelnd, oppure, a scopo ironico, un individuo che accenti fortemente i tratti caratteriali di tedesco.
Nel 101 a.C. il collega di Gaio Mario, Quinto Lutazio Càtulo, console nel 102, non era invece riuscito ad impedire che i Cimbri forzassero il passo del Brennero avanzando nell'Italia settentrionale verso il finire del 102 a.C.. Gaio Mario apprese la notizia mentre si trovava a Roma, dove era rieletto console per l'anno 101 a.C. e immediatamente si mise in marcia per ricongiungersi con Càtulo, il cui comando fu prorogato anche per il 101 a.C. Infine, nell'estate del 101 a.C., a Vercelli, nella Gallia Cisalpina, in una località allora chiamata Campi Raudii, ebbe luogo lo scontro decisivo. Ancora una volta la ferrea disciplina dei Romani ebbe la meglio sull'impeto dei Cimbri e almeno 65.000 di loro (o forse 100.000) perirono, mentre tutti i sopravvissuti furono ridotti in schiavitù. I Tigurini, clan dei Celti Elvezi, a quel punto rinunciarono al loro proposito di penetrare in Italia da Nord-Ovest e rientrarono nelle loro sedi. Càtulo e Mario, come consoli in carica, celebrarono insieme uno splendido trionfo, ma nell'opinione popolare, tutto il merito venne attribuito a Mario. In seguito Càtulo si trovò in contrasto con Mario, divenendone uno dei più accaniti rivali. Come ricompensa per avere sventato il pericolo dell'invasione barbarica, Mario venne rieletto console anche per l'anno 100 a.C. Gli avvenimenti di quell'anno, tuttavia, non gli furono propizi, poiché proprio nel corso dell'anno il tribuno della plebe Lucio Appuleio Saturnino richiese con forza che si varassero riforme simili a quelle per cui si erano in passato battuti i Gracchi. Propose quindi una legge per l'assegnazione di terre ai veterani della guerra appena conclusasi e per la distribuzione da parte dello stato di grano a prezzo inferiore a quello di mercato. Il senato si oppose a queste misure, provocando così lo scoppio di violente proteste, che presto sfociarono in una vera e propria rivolta popolare, e a Mario, come console in carica, fu chiesto di reprimerla. Sebbene egli fosse vicino al partito popolare, il supremo interesse della repubblica e l'alta magistratura da lui rivestita gli imposero di assolvere, sebbene riluttante, a questo compito. Dopodiché lasciò ogni carica pubblica e partì per un viaggio in Oriente mentre Roma conobbe alcuni anni di relativa tranquillità.
 |
| Marco Licinio Crasso da QUI. |
La battaglia di Carre fu combattuta il 9 giugno dell'anno 53 a.C. presso la città di Carre (oggi Harran, in Turchia) tra l'esercito della Repubblica romana comandato dal generale romano Marco Licinio Crasso e l'esercito partico al comando dell'Eran Spahbod Surena. La battaglia si rivelò un disastro per le forze romane in Medio Oriente. Convenientemente il casus belli (motivo della guerra) gli fu fornito dalle lotte dinastiche dei Parti: dopo la morte di re Fraate III, i figli - Mitridate e Orode - se ne contesero il trono; i Romani appoggiavano Mitridate, ma fu Orode il vincitore e Mitridate richiese il loro intervento. Crasso decise di entrare nel territorio nemico dal sud attraverso il deserto siriano - anziché dalle montagne armene a nord - con l'intento di sorprendere Surena, e avanzò con circa 32.000 legionari e 4.000 ausiliari. Anziché seguire il corso dell'Eufrate fino a Seleucia, così assicurandosi un fianco protetto e rifornimenti di acqua - come avevano suggerito i subordinati, specialmente Cassio, questore delle legioni - Crasso decise di attraversare il deserto siriano, mirando al colpo decisivo con il grosso del nemico. Secondo Plutarco, la decisione di attraversare il deserto fu presa dopo che tre nobili Parti, presentatisi orribilmente mutilati - di labbra, naso e mani - convinsero Crasso del loro desiderio di vendetta per le torture subite e gli consigliarono di seguire un percorso alternativo, per sorprendere le forze partiche stanziate nel deserto. Impressionato dalla crudeltà con la quale i tre erano stati torturati, Crasso seguì il loro consiglio avventurandosi tra le sabbie, ignaro che in realtà questi nobili si erano fatti mutilare volontariamente per tendergli un tranello.
Dal momento che le truppe romane avanzavano lentamente arrancando nel deserto, durante la marcia i Parti, invece di accettare uno scontro campale attaccavano coi loro arcieri a cavallo, colpendo a distanza e infliggendo gravi perdite al nemico per dileguarsi prima che questo potesse reagire. Lungi dall'allarmarlo, tale tattica persuase Crasso che i Parti fossero codardi, incapaci di un confronto aperto.
Quando finalmente i Parti decisero di dare battaglia, le forze romane erano stanche dal lungo peregrinare nel deserto. Crasso schierò inizialmente l'esercito nella classica formazione in linea con la fanteria al centro e la cavalleria sulle ali, ma poi decise di schierare il suo esercito a quadrato: una formazione difensiva contro un esercito, quello partico, formato prevalentemente dalla cavalleria. Dopo le iniziali schermaglie con la fanteria leggera romana, i Parti caricarono con i loro cavalieri catafratti, che però non riuscirono a sfondare e si ritirarono. A quel punto entrarono in battaglia gli arcieri a cavallo che con il loro incessante lancio di frecce inflissero gravi danni all'esercito romano e lo indussero ad attaccare. Il lato sinistro dello schieramento comandato da Publio, figlio di Crasso, attaccò con tutti i 1300 cavalieri gallici e 8 coorti: i veloci arcieri a cavallo parti si ritirarono, continuando a lanciare frecce e portando l'ala nemica sempre più lontana dal resto della formazione. Poi circondarono e caricarono le truppe romane con i cavalieri catafratti, fino a distruggerle e ad uccidere Publio.
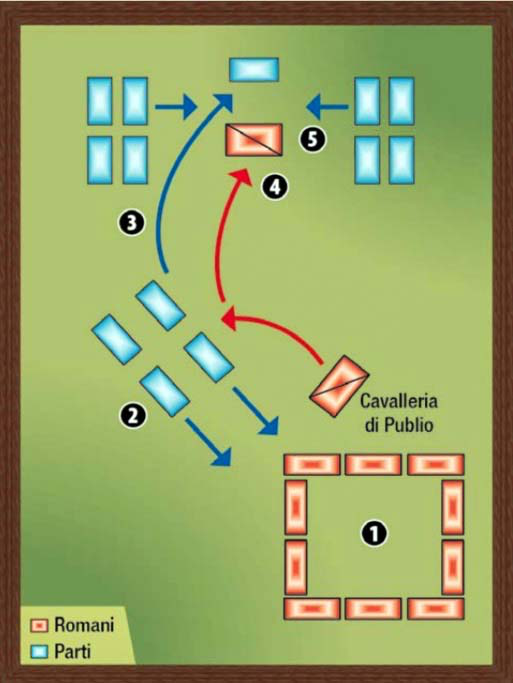 |
| Schema della battaglia di Carre, da https://best5.it/ post/le-5-sconfitte-peggi ori-dellimpero-romano/. |
 |
| Scordiscum, dal libro "Ad Arma!" |
 |
| Gaio Giulio Cesare, da QUI. |
Il costante contatto con il mondo dei Celti e dei Germani, indusse Gaio Giulio Cesare a rivalutare il corpo della cavalleria, tanto che ne fece un impiego crescente negli anni, reintroducendo unità di cavalleria permanente accanto alla fanteria delle legioni e a quella ausiliaria. Reclutò tra le sue fila soprattutto Galli e Germani, inquadrando queste nuove unità sotto decurioni romani, con grado pari a quello dei centurioni legionari. L'equipaggiamento dei cavalieri era costituito da un sago, una cotta di maglia in ferro, l'elmo e probabilmente uno scudo rotondo. La sella era di tipo gallico, con quattro pomi ma senza staffe. I cavalli erano probabilmente ferrati, come da tradizione gallica. Come armi da offesa portavano il gladio e il pilum, o un'asta più pesante detta contus.
Nelle campagne per la conquista delle Gallie, Cesare richiedeva, alle popolazioni celtiche assoggettate-alleate, contingenti di cavalleria, che veniva così definita cavalleria gallo-romana, utilizzata perlopiù per contrastare i vari insediamenti di Germani nelle Gallie stesse. Già verso la fine della conquista delle Gallie poi, anche i Germani andarono a costituire reparti di cavalleria ausiliaria dell'esercito Romano.
Giulio Cesare era giunto in Gallia nel 58 a.C., dopo il consolato dell'anno precedente. Era, infatti, consuetudine che i consoli, gli ufficiali più elevati in grado di Roma, alla fine del loro mandato fossero nominati governatori in una delle province dal Senato. Grazie agli accordi del Primo triumvirato (l'alleanza politica non ufficiale con Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso), Cesare era stato nominato governatore della Gallia Cisalpina (la regione, compresa fra Alpi, Appennini e Adriatico, che corrisponde all'odierna Italia settentrionale), dell'Illirico e della Gallia Narbonense.
Cesare, col pretesto di dover impedire che il popolo celtico degli Elvezi migrasse attraverso la Gallia e lasciasse i propri terrori ai Germani, evento scomodo per Roma, si era intromesso negli affari interni delle popolazioni celtiche, che i romani chiamavano Galli, finché non furono tutte assoggettate: cominciò da quelle della Gallia Belgica, per poi spingersi fino a sottomettere quelle della costa atlantica, fino all'Aquitania. Furono battute inoltre, diverse popolazioni germaniche, in entrambe le sponde del Reno; Cesare attraversò il Reno due volte, nel 55 e 53 a.C. e, primo tra i Romani, condusse due spedizioni contro i Britanni d'oltre Manica nel 55 e 54 a.C.
Prima della conquista della Gallia da parte di Gaio Giulio Cesare, spinte alle spalle dalla pressione dei Suebi, le tribù germaniche degli Usipeti e dei Tencteri avevano vagato per tre anni e si erano spinte a nord del fiume Meno, fino a raggiungere le regioni abitate dalla tribù celtico-gallica dei Menapi, alla foce del Reno. I Menapi possedevano, su entrambe le sponde del fiume, campi, casolari e villaggi e quindi, spaventati dall'arrivo di quella moltitudine di genti (Cesare sostiene fossero ben 430.000 persone), abbandonarono gli insediamenti a est del Reno e posero alcuni presidi lungo il fiume, per impedire ai Germani di passare in Gallia. Non riuscendo ad attraversare il fiume, Tencteri ed Usipeti simularono la ritirata per poi tornare improvvisamente di notte facendo strage dei Menapi che erano tornati nei loro villaggi. Si impadronirono quindi delle loro navi e passarono il fiume Reno, occuparono i loro villaggi in Gallia e si nutrirono per tutto l'inverno con le loro provviste.
Venuto a conoscenza di questi fatti, Cesare decise di anticipare la sua partenza per la Gallia e raggiungere le sue legioni, che svernavano nei territori della Gallia Belgica. Era venuto inoltre a sapere che alcune tribù galliche avevano invitato le tribù germaniche ad abbandonare i territori appena conquistati del basso Reno, per inoltrarsi in Gallia. « Attratti da questa speranza, i Germani si spinsero più lontano con le loro scorrerie, fino ai territori degli Eburoni e dei Condrusi, che sono un popolo cliente dei Treviri [...] Cesare dopo aver blandito ed incoraggiato i capi della Gallia, ed avergli richiesto reparti di cavalleria alleata, stabilì di portare la guerra ai Germani [...] Cesare dopo aver provveduto a raccogliere frumento ed arruolati i cavalieri si diresse verso le regioni dove si diceva si trovassero i Germani. » (Cesare, De bello Gallico, IV, 6-7,1).
I Germani Usipeti e Tencteri, che si trovavano in una località non molto distante dall'attuale città olandese di Nimega (in olandese Nijmegen), una volta venuti a conoscenza dell'avvicinamento dell'esercito romano decisero di inviare ambasciatori a Cesare, per chiedere al generale il permesso di stanziarsi in quei territori, offrendo in cambio la loro amicizia. Gli ricordarono il motivo per cui erano stati costretti a migrare ed il loro valore in battaglia, ma Cesare negò loro il permesso di occupare territori della Gallia sostenendo che non era giusto che i Germani si impadronissero delle terre di altri popoli, proprio loro che non erano stati capaci di difendere i propri territori dalle scorrerie dei Suebi. Cesare consigliò loro di riattraversare il Reno e di occupare i territori del popolo amico degli Ubi, che avevano chiesto a Cesare di intervenire oltre il grande fiume offrendogli la loro alleanza, per potersi liberare finalmente dal giogo dei vicini Suebi.
Gli Ubi (in latino Ubii) erano un'antica popolazione germanica che aveva abitato, fino al 38 a.C., la sponda destra del fiume Reno nei territori di fronte all'attuale città di Koeln (Colonia), territori che confinavano a sud con quelli dei Suebi, di cui gli Ubi dovettero diventare tributari. Appartenenti, secondo Tacito, agli Istaevones (i Germani occidentali), confinavano, nella Gallia al di là del Reno, con i Treveri, anch'esso popolo originariamente germanico. Nel 55 a.C., Giulio Cesare, poco prima di oltrepassare il Reno e compiere la prima incursione romana in territorio germanico, descriveva così questo popolo:
Nel frattempo era stata quindi stabilita una tregua fra Usipeti e Tencteri con Cesare, al fine di giungere ad una soluzione, ma durante la tregua, quei Germani si scontrarono con uno squadrone di cavalleria gallo-romana, e lo costrinsero alla fuga. Così, quando gli ambasciatori di Usipeti e Tencteri si recarono da Cesare per giustificarsi, lui li accusò di non aver rispettato l'accordo, li fece imprigionare, dopodiché con una mossa fulminea, piombò sull'accampamento germanico difeso solo da carri e bagagli, massacrò uomini donne e bambini (quasi 200.000 persone) e costrinse i superstiti alla fuga verso nord, in direzione della confluenza del Reno con la Mosa, lungo uno dei tratti finali del Reno, quello più occidentale, chiamato Waal. L'azione, particolarmente cruenta, suscitò la sdegnata reazione di Catone, che propose al senato di consegnare Cesare ai Galli, in quanto colpevole di aver violato i diritti degli ambasciatori. Il Senato invece, proclamò una lunghissima supplicatio di ringraziamento di ben quindici giorni.
Le legioni , per necessità militari, ebbero modo di costruire eccellenti infrastrutture, come strade, acquedotti, fortificazioni e ponti.
 |
| Ricostruzione del ponte sul Reno fatto costruire da Gaio Giulio Cesare, tela di John Soane del 1814, da https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Cesare_sul_ Reno#/media/File:Il_ponte_di_Cesare_sul_Reno.jpg |
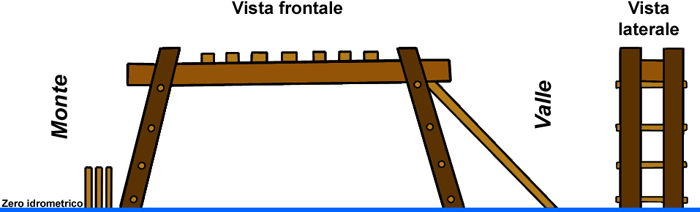 |
| Ponte romano sul Reno di Lo Scaligero, da https:// commons.wikimedia.org/wiki/File:Ponte_romano _sul_Reno.png#mediaviewer/File:Ponte_romano _sul_Reno.png. |
I ponti sul Reno, fatti costruire da Gaio Giulio Cesare dai propri legionari nel corso delle campagne condotte per la conquista delle Gallie, sono stati due.
I due eserciti si scontrarono presso la collina fortificata di Gergovia, dove Vercingetorige riuscì - più per l'indisciplina dei legionari romani, che non obbedirono all'ordine di ritirarsi dopo una ben orchestrata sortita, che per demeriti dello stesso Cesare - ad ottenere una limitata vittoria. Cesare, dopo due giorni consecutivi col suo esercito ai piedi della capitale arverna, preferì tornare ad Agendico e ricongiungersi con l'armata del suo luogotenente Labieno.
Forti di questo primo, seppur parziale e non determinante successo, le tribù galliche decisero di unire le forze per provare a cacciare definitivamente l'invasore romano. Un concilio generale fu organizzato a Bibracte grazie all'iniziativa degli Edui, che erano stati fino ad allora fedeli alleati di Cesare. Solo i Remi ed i Lingoni preferirono mantenere l'alleanza con Roma. Il concilio nominò Vercingetorige, re degli Arverni, comandante degli eserciti gallici uniti.
Poco prima di raggiungere il luogo della battaglia finale, la rocca di Alesia nel territorio dei Mandubi, i due contendenti ebbero un nuovo scontro, combattuto dalle rispettive cavallerie: «… Vercingetorige divisa la cavalleria [composta da 15.000 armati, N.d.R.] in tre parti; due schiere attaccano sui fianchi ed una impedisce la marcia alla colonna [dell'esercito romano, N.d.R.]. Cesare, informato, ordina anche alla sua cavalleria di contrattaccare il nemico gallico in tre colonne. Si combatte in contemporanea su tutti i fronti. L'esercito romano si ferma, mentre i bagagli sono messi al centro dello schieramento tra le legioni… infine i Germani sul lato destro, raggiunta la vetta di una collina, battono il nemico, lo mettono in fuga e lo inseguono fino al fiume, dove aveva preso posizione Vercingetorige con la fanteria e ne uccidono numerosi. Gli altri, per timore di essere circondati, fuggono. I Romani fanno strage ovunque. Tre nobili capi degli Edui furono catturati e portati in presenza di Cesare. Si trattava di un certo Coto, comandante dei cavalieri… di Cavarillo, che dopo la defezione di Litavicco era divenuto comandante della fanteria, ed Eporedorige…». (Cesare, De bello Gallico, VII, 67.).
Visto che la sua cavalleria era stata messa in fuga dai Germani della cavalleria romana, Vercingetorige marcia in direzione di Alesia mentre Cesare, collocate le salmerie sopra un colle vicino e lasciate a guardia due legioni, insegue il nemico per il resto della giornata e, dopo aver ucciso tremila uomini della retroguardia gallica, il giorno seguente si accampa presso Alesia, l'oppidum dei Mandubi. Qui, secondo Carcopino, Cesare, con implacabile logica, aveva previsto che sarebbe andato a rifugiarsi il capo degli Arverni, posizione apparentemente e sufficientemente sicura dove poter cullare l'illusione di essere invulnerabile, mentre i picconi dei legionari e la tecnica dei genieri romani lo avrebbero imprigionato senza speranza.
La coalizione delle tribù galliche che si era riunita sotto la guida di Vercingetorige, re degli Arverni, consisteva secondo quanto racconta Cesare di ben ottantamila armati, di cui quindicimila cavalieri, e si accampò lungo il lato orientale della città di Alesia, dopo aver scavato un fosso ed eretto un muro alto sei piedi (poco meno di due metri) a protezione.
Nel suo De bello Gallico, Cesare riferisce inoltre che l'esercito gallico giunto in soccorso contava duecentoquarantamila fanti ed ottomila cavalieri: cifre non necessariamente non veritiere, considerata l'importanza dello scontro finale, anche se le uniche testimonianze scritte sono di fonte romana (Cesare, De bello Gallico, VII, 75.), e che potrebbero risultare, pertanto, "di parte". Al comando di questo immenso esercito di soccorso c'erano l'atrebate Commio, gli edui Viridomaro ed Eporedorige e l'arverno Vercassivellauno, cugino di Vercingetorige.
È molto difficile disporre di un calcolo preciso riguardo alla grandezza numerica degli eserciti ed al numero di perdite umane subite. Tali grandezze sono sempre state un'arma di propaganda potente, e sono pertanto sospette. L'unico fatto certo è, come racconta lo stesso Cesare, che alla fine della battaglia ogni legionario ricevette un gallo come schiavo (il che significa quarantacinquemila uomini, ovviamente facenti parte dell'esercito assediato) e che furono lasciati liberi ben ventimila armati appartenenti ai popoli di Edui ed Arverni. Considerando le cifre di quanti tra gli assediati rimasero in vita (circa sessantacinquemila), se ne deduce che nel corso degli scontri avvenuti durante il mese e più di assedio, potrebbero aver perduto la vita attorno ai quindicimila armati Galli, cifra plausibile in base ai dati forniti da Cesare, il quale aveva indicato in ottantamila il numero complessivo dell'esercito di Vercingetorige, prima dell'arrivo dell'esercito gallico di soccorso.
L'esercito di soccorso subì verosimilmente pesanti perdite, come frequentemente accadeva nelle battaglie dell'antichità, quando a provocare la sconfitta e il successivo massacro a senso unico era la perdita di coesione negli schieramenti dell'esercito che aveva la peggio.
 |
| Ubicazione di Alesia, da https://it. wikiùpedia.org/wiki/Battaglia_di_ Alesia#/media/File:Gallia_ Cesare_52_aC.png . |
 |
| Museopark di Alesia: Arnaud 25 - Opera propria CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ w/index.php?curid=19818625. |
 |
| Fortificazioni romane ad Alesia: Cristiano64 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons .wikimedia.org/w/index.php?curid=27166867. |
Erano necessarie considerevoli capacità ingegneristiche per realizzare una tale opera, ma non nuove per uomini come gli edili, gli ufficiali di Roma, che solo pochi anni prima, in dieci giorni, avevano costruito un ponte attraverso il Reno con somma meraviglia dei Germani. Ed infine, per non trovarsi poi costretto ad uscire dal campo con pericolo per l'incolumità delle sue armate, Cesare ordinò di avere un deposito di foraggio e di frumento per trenta giorni.
 |
| Alesia, lo schieramento delle fortificazioni romane: Cristiano64 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ ùw/index.php?curid=8833737 . |
Mentre Cesare provvedeva alla costruzione di questa seconda linea di fortificazioni, le condizioni di vita dentro Alesia cominciarono a farsi insostenibili per gli assediati. Si racconta che, passato il giorno nel quale gli assediati aspettavano gli aiuti dai loro alleati, consumato tutto il frumento, si riunirono in consiglio per valutare la situazione ed il da farsi: «…parlò Critognato, il cui discorso merita di non essere trascurato per la singolare e aberrante crudeltà: "…Nel prendere una decisione dobbiamo considerare tutta la Gallia che abbiamo chiamato in nostro aiuto. Quale coraggio pensate che avranno i nostri amici e parenti dopo l'uccisione in un solo luogo [ Alesia, ndr] di ottantamila uomini? …Dunque qual è il mio consiglio? Di fare come fecero i nostri antenati nella guerra contro i Cimbri ed i Teutoni… quando, respinti nelle città e costretti da simile carestia, si cibarono dei corpi di coloro che per età non erano più adatti alla guerra e non si arresero ai nemici…"» (Cesare, De bello Gallico, VII, 77.)
Al termine di questa riunione, Vercingetorige e l'intero Consiglio stabilirono che tutti quelli che per età o salute non erano adatti alla guerra, uscissero dalla città. Non potevano considerare di accogliere l'opinione di Critognato se non in ultima analisi. Decisero, pertanto, di costringere le donne, i bambini ed i vecchi del popolo dei Mandubi ad uscire dalla cittadella nella speranza non solo di risparmiare cibo per i soldati, ma che Cesare potesse accoglierli nelle fortificazioni, per poi lasciarli andare liberi. Ma ciò non avvenne poiché, come racconta Dione, morirono tutti di fame tra le mura della città di Alesia e le linee fortificate romane, nella "terra di nessuno". Cesare, infatti, dispose numerose guardie sul bastione e vietò che fossero accolti malgrado le loro preghiere ed i pianti. Il destino di quei civili peggiorò il già compromesso morale all'interno delle mura. La fortuna volle però che di lì a poco, in quelle ore disperate, giungesse finalmente l'esercito gallico di soccorso, dando loro nuove energie a resistere all'assedio e combattere per la possibile vittoria finale.
Primo attacco dei Galli: scontro di cavallerie - Il giorno successivo all'arrivo dell'esercito di soccorso, i capi dei Galli disposero la cavalleria in modo da riempire tutta la piana ad occidente delle fortificazioni romane (per circa tre miglia), mentre collocarono le fanterie in luoghi più elevati, in posizione un poco arretrata (ai piedi della collina di Mussy-la-Fosse). Dall'alto della città di Alesia si potevano vedere chiaramente le manovre operate dall'esercito di soccorso, tanto che gli assediati si precipitarono all'esterno, prendendo posizione davanti alla città, coprendo con graticci e riempiendo con terra la fossa più vicina (distante dalle fortificazioni romane seicento metri), pronti ad intervenire lungo il fronte interno. Cesare, avendo disposto per ogni unità di fanteria uno specifico settore lungo le due linee di fortificazione (sia interna, sia esterna), ordinò che la cavalleria fosse condotta fuori dagli accampamenti ed attaccasse battaglia. Dall'alto delle colline le fanterie legionarie e le falangi galliche potevano così godersi l'intera vista della piana di Laumes, e seguire l'evolversi di questa battaglia equestre tra i due schieramenti.
 |
| Alesia, la battaglia finale. Di Cristiano64 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons. wikimedia.org/w/index. php?curid=8833736. |
Il giorno dopo (che alcuni studiosi moderni datano alla metà del mese di ottobre del calendario giuliano) il comandante gallico con fierezza convocò il consiglio e dichiarò di aver intrapreso questa guerra non per utilità propria, ma per la libertà della Gallia. Egli rimetteva la sua vita nelle mani dell'assemblea: era disponibile sia a morire per dare soddisfazione ai Romani, sia ad essere consegnato quale preda di guerra a Cesare. Furono, pertanto, inviati ambasciatori al proconsole romano per trattare le condizioni della resa. La risposta non si fece attendere: dovevano consegnare tutte le armi e presentare i capi della rivolta. Il proconsole romano, che aveva fatto porre il proprio seggio davanti alle fortificazioni («Ipse in munitione pro castris consedit»), accolse la resa dei capi galli e la consegna del comandante sconfitto. «Vercingetorige, indossata l'armatura più bella, bardò il cavallo, uscì in sella dalla porta della città di Alesia e, fatto un giro attorno a Cesare seduto, scese da cavallo, si spogliò delle armi che indossava e chinatosi ai piedi di Cesare, se ne stette immobile, fino a quando non fu consegnato alle guardie per essere custodito fino al Trionfo.» (Plutarco, Vite parallele, Cesare, 27, 9-10.)
La fine di Alesia segnò la fine della resistenza e del sogno di libertà della Gallia unita. I soldati di Alesia furono fatti prigionieri e in parte assegnati in schiavitù ai legionari di Cesare come bottino di guerra, ad eccezione di ventimila armati facenti parte delle tribù degli Edui e degli Arverni, che furono liberati per salvaguardare l'alleanza dei due più importanti popoli gallici con Roma. Vercingetorige fu rinchiuso nel Carcere Mamertino e nei sei anni successivi rimase nell'attesa di essere esibito nella sfilata trionfale di Cesare, per poi essere strangolato una volta terminata la processione, come era tradizione per i comandanti nemici catturati. L'inflessibile crudeltà del proconsole verso il capo della coalizione dei Galli, che si era offerto a lui per salvare la sorte delle sue genti con tanto onore e passione, risulta però poco comprensibile allo storico Jérôme Carcopino, il quale sottolinea quanto contrastasse con la fama che Cesare fino a quel momento aveva avuto di uomo clemente. Forse la ragione è da ricercarsi in un profondo rancore che il generale romano nutriva non tanto nei confronti dell'amico che lo aveva tradito, ma quanto nel capo della coalizione che aveva compromesso la sua vittoria finale ed il suo avvenire in un momento tanto difficile della sua vita politica romana.
 |
| 50 a.C., domini di Roma dopo la conquista delle Gallie. Di Cristiano64 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index .php?curid=2986575. |
Dalla riforma mariana le legioni, schierate secondo il nuovo ordinamento coortale, venivano disposte normalmente su due linee (duplex acies), soluzione che permetteva di avere un fronte sufficientemente lungo ma anche profondo e flessibile. Vi erano poi altri tipi di schieramenti praticati dalle armate romane del tardo periodo repubblicano: su una sola linea, ovviamente quando era necessario coprire un fronte molto lungo come nel caso del Bellum Africum durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo; o su tre linee (triplex acies), formazione spesso utilizzata da Cesare durante la conquista della Gallia, con la prima linea formata da 4 coorti e le restanti due linee, formate da tre coorti ciascuna. Le coorti schierate lungo la terza linea costituivano spesso una "riserva tattica" da utilizzare in battaglia, come avvenne contro Ariovisto in Alsazia.
Giulio Cesare fu il primo a comprendere che la dislocazione permanente di una parte delle forze militari repubblicane doveva costituire la base per un nuovo sistema strategico di difesa dei confini del mondo romano, gettando così le basi per lo sviluppo dei vari limes.
Tacito aggiunge che accanto alle schiere di combattenti, stanno nelle retrovie i loro famigliari, così vicini da sentire le urla di incitamento delle loro donne e dei loro figli. Questi sono per ogni soldato le persone più care, a cui porgono le ferite da curare (a madri e mogli) e dalle quali sono nutriti con cibo, esortati ed incoraggiati. «Si racconta che a volte le schiere che ripiegarono, tanto da trovarsi sul punto di cedere, furono sospinte a tornare a combattere grazie alle insistenti preghiere delle donne che, mostrando i loro petti, facevano capire ai loro uomini il pericolo che su di loro incombeva se cadevano prigioniere. E infatti i Germani temono maggiormente la prigionia delle donne, che la propria.» (Tacito, De origine et situ Germanorum, VIII, 1.). Nella battaglia tra Cesare ed Ariovisto presso Mulhouse, nel 58 a.C., il comandante dei Germani ordinò l'esercito per tribù: prima quella degli Arudi, poi i Marcomanni, i Triboci, i Vangioni, i Nemeti, i Sedusi ed infine i Suebi. Ogni tribù fu poi circondata da carri e carrozze, affinché non ci fosse la possibilità di fuga per nessuno: sopra i carri c'erano le donne, che imploravano i loro uomini di non abbandonarle alla schiavitù dei Romani.
Cesare descrive i combattimenti equestri dei Germani nel suo libro IV del De bello Gallico (55 a.C.): «Nei combattimenti equestri spesso scendono da cavallo e combattono a piedi. Hanno addestrati i loro cavalli e rimanere sul posto. Quando ne hanno bisogno ritornano velocemente da soli. Secondo loro, nulla è considerato di più vile che utilizzare la sella. E quindi, solo pochi hanno il coraggio di andare alla carica di cavalieri con sella in un certo numero.» (Cesare, De bello Gallico, IV, 2.3-5.). «I Germani, non appena videro 5.000 cavalieri romani, sebbene non fossero più di 800 [...], decisero di attaccare e rapidamente batterono i Romani, non avendo alcun timore [...]. Quando poi i Romani provavano a resistere, secondo il loro costume [i Germani] saltavano giù da cavallo a piedi: disarcionavano quindi molti Romani trafiggendo loro i cavalli, cacciando gli altri in fuga, e tanto impauriti li inseguivano, fino a quando non giunsero in vista dell'esercito [di Cesare]. In quello scontro perirono 74 Romani.» (Cesare, De bello Gallico, IV, 12.1-2.). Tacito, un secolo e mezzo più tardi, aggiunge altri particolari ai reparti di cavalleria, sostenendo che i loro cavalli non erano né belli a vedersi, né veloci nella cavalcata. I Germani non insegnavano loro a compiere delle evoluzioni, come invece facevano i Romani. Li guidavano dritti davanti a loro, oppure li facevano ripiegare con un solo tipo di conversione verso destra, in modo da non ostacolarsi vicendevolmente in caso di ritirata, evitando così che qualcuno potesse rimanere indietro.
Cesare inoltre osservava come ogni popolo germanico considerasse la massima gloria che vi fossero attorno ai confini della loro nazione, territori disabitati per la più vasta estensione possibile. Questo significava per loro che un certo numero di nazioni non fossero grado di superare la loro forza d'arme. Cesare racconta che da una parte dei confini dei Suebi, fosse disabitato un tratto di paese pari a circa 600.000 passi, cioè 600 miglia (pari a poco meno di 900 km). «La gloria più grande per un popolo consiste ne fare il deserto intorno ai propri confini, devastando i territori circostanti. Considerano segno particolare del loro valore che le popolazioni limitrofe, cacciate dai loro territori, si ritirino, e che nessuno si azzardi a fermarsi vicino a loro. Allo stesso tempo credono che tale situazione li renda più sicuri, eliminando il timore di un'invasione improvvisa.» (Cesare, De bello Gallico, VI, 23.1-3.).
Da questi accorgimenti nacque anche l'importante innovazione tattica del primo prototipo di coorti equitate, costituite da corpi di cavalleria misti a quelli di fanteria, sull'esempio del modo di combattere di molte tribù germaniche, tra cui i Sigambri. Esse furono utilizzate da Cesare con continuità a partire dall'assedio finale di Alesia. In questa unità tattica, dove a ciascun cavaliere era abbinato un uomo a piedi, si combinavano i vantaggi della cavalleria con quelli della fanteria, permettendo a queste due tipologie di armati di completarsi vicendevolmente e proteggersi in modo più efficace.
L'ultimo tentativo di far rinascere la cavalleria cittadina Romana fu fatto da Pompeo nella guerra contro Cesare, ma è nota la cattiva prova fatta da tale cavalleria a Farsalo.
 |
| Marco Vipsanio Agrippa al Louvre di Parigi, di Shawn Lipowski QUI. |
Marco Vipsanio Agrippa (Arpino, 63 a.C. circa - Campania, 12 a.C.) è stato un politico, militare e architetto romano. Amico di Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, è stato suo fedele collaboratore e anche suo genero. Agrippa è stato artefice di molti trionfi militari di Ottaviano, il più considerevole dei quali è stata la vittoria navale nella battaglia di Azio contro le forze di Marco Antonio e Cleopatra. Di origini modeste, era nato forse ad Arpino, in Campania, ma la questione è dibattuta: alcuni studiosi, tra i quali Victor Gardthausen, David Ridgway, e R. E. A. Palmer, sostengono che la sua famiglia fosse originaria di Pisa, nell'Etruria settentrionale. Era della stessa età di Ottaviano e i due erano amici intimi dall'infanzia. Ottaviano e Agrippa avevano servito come ufficiali di cavalleria, al comando di Giulio Cesare, nella battaglia di Munda nel 45 a.C., dove Agrippa si era distinto per il suo grande valore.
 |
Marco Giunio Bruto da: |
 |
Cavalieri dell'età di Augusto dal mausoleo gallo-romano dell'antica città di Glanum, vicino
all'odierna Saint- Rémy-de-Provence, in Francia, eretto tra il 30 e il 20 a.C., durante il principato di Augusto. Da notare che il cavallo a terra è dotato di sella gallica. Immagine di genevieveromier - Flickr: bas-relief
du mausolée de Glanum, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org |
Al termine delle guerre civili tra Marco Antonio ed Ottaviano, si contavano 60 legioni circa, pur se non a ranghi completi.
La stessa cavalleria legionaria in servizio presso le legioni non aveva una funzione tattica sul campo, ma era utilizzata per compiti di ricognizione, di picchetto e avanscoperta. Si capisce quindi come le forze ausiliarie (fanteria e cavalleria leggere, tiratori) fossero componenti complementari e non alternative alle legioni; una campagna di conquista senza queste forze e senza l'apporto della loro cavalleria (organizzata in alae e cohortes equitatae), sarebbe stata altrimenti inattuabile.
 |
Statua di Augusto a Prima Porta, in uniforme militare (paludamentun). Musei Vaticani, da QUI. |
La fanteria legionaria è divisa in 10 coorti (di cui nove di 480 armati ciascuna), che al loro interno contano 3 manipoli oppure 6 centurie. La riforma della prima coorte avvenne in un periodo imprecisato, sicuramente tra l'epoca di Augusto e quella dei Flavi. Si trattava di una coorte milliare, vale a dire di dimensioni doppie rispetto alle altre nove coorti, con 5 centurie (non 6) di un numero doppio di armati (160 ciascuna), pari a 800 legionari complessivi, a cui era affidata l'aquila della legione.
Sotto Augusto, con la riforma dell'esercito e delle truppe ausiliarie, 16 turmae andarono a costituire un'ala di cavalleria. Una decuria era formata da 10 cavalieri e tre decurie di cavalieri a loro volta costituivano una turma.
In origine, le popolazioni che costituivano cavalleria ausiliaria (formata da provinciali e alleati, i cosiddetti peregrini) venivano arruolate localmente lungo le frontiere perché, conoscendo bene i luoghi, potevano difenderne meglio di chiunque altro i confini. Erano inoltre affidate al comando di un re o principe cliente nativo del posto (il praefectus equitum citato dallo stesso Cesare), almeno fino alla seconda metà del I secolo, quando furono poi sottoposte ad un praefectus alae o ad un praefectus cohortis equitatae dell'ordine equestre. Con il passare del tempo però, furono inviate ovunque lungo i confini imperiali, pur conservando le loro caratteristiche di omogeneità etnica, per cui si equipaggiavano e combattevano secondo le loro tradizioni. Vegezio racconta che tutti i soldati romani, dai cavalieri ai legionari, erano comunque addestrati a montare a cavallo. L'epoca non è specificata, anche se noi ipotizziamo possa trattarsi degli inizi del periodo imperiale, quando fu reintrodotta la cavalleria legionaria:
«Non soltanto alle reclute, ma anche ai soldati di professione è sempre stata richiesta la capacità di montare a cavallo. [...] Cavalli di legno erano predisposti in inverno al coperto [nei castra stativa], d'estate nel castrum. I giovani dovevano montare inizialmente senza nessuna armatura, fino a quando non avevano sufficiente esperienza e in seguito armati. Ed è così grande la cura che ci mettono che questi non solo imparavano a salire e scendere da destra ma anche da sinistra, tenendo in mano persino le spade sguainate e le lance. Si dedicavano a questo esercizio in modo assiduo, poiché nel tumulto della battaglia potevano montare a cavallo senza indugio, visto che si erano esercitati tanto bene nei momenti di tregua.» (Vegezio, Epitoma rei militaris, I, 18.).
Augusto volle distinguere prima di tutto le carriere superiori dalle inferiori. Egli dettò dei parametri d'avanzamento che comunque, in particolare per l'ordine equestre, videro la loro completa definizione a partire da Claudio, se non dai Flavi. In particolare per le carriere militari, Augusto riorganizzò il cursus honorum con il seguente percorso: Prefetto di coorte, Tribuno angusticlavio di legione, compreso il triplo Tribunato a Roma per il Prefetto dei vigili, il Prefetto urbano, il Prefetto del Pretorio e il Prefetto d'ala.
Sempre ad Augusto si deve l'introduzione di un esercito di professionisti che rimanessero in servizio non meno di sedici anni per i legionari, portati a venti nel 5 (come era successo fin dai tempi di Polibio, in caso di massima crisi), e venti-venticinque per le truppe ausiliarie. A questo periodo di servizio poteva subentrarne uno ulteriore di alcuni anni tra le "riserve" di veterani, in numero di 500 per legione (sotto il comando di un curator veteranorum).
I soldati ausiliari prestavano servizio per 25 anni, al termine del quale ricevevano un diploma militare che ne attestava il congedo (honesta missio), oltre ad un premio (in denaro o un appezzamento di terra, quasi fosse una forma di pensione dei giorni nostri), la cittadinanza romana ed il diritto a contrarre matrimonio (conubium). La paga (stipendium) per un cavaliere di ala si aggirava attorno ai 250 denari (pari a 1.000 sesterzi, e nel I sec un sesterzio valeva circa 2 €), mentre per un cavaliere di coorte equitata attorno ai 150/200 denari (pari a 600/800 sesterzi). Nel I sec. 1 denario equivaleva ad 8 € attuali.
Le alae di cavalleria ausiliaria romana inizialmente erano solo quingenarie (composte cioè da 500 armati circa). Erano divise in 16 turmae da 32 uomini (ciascuna comandata da un decurione), per un totale di 512 cavalieri. Fornivano alle legioni truppe di ricognizione e di inseguimento, oltre a costituire elemento d'urto sui fianchi dello schieramento nemico.
Le coorti equitatae erano anch'esse inizialmente solo quingenarie. Di loro abbiamo notizia fin dal principato di Augusto, da un'iscrizione rinvenuta a Venafro nel Sannio. Si caratterizzavano dalle normali coorti ausiliarie per essere unità militari miste. Erano formate da 6 centurie di 80 fanti ciascuna (secondo Giuseppe Flavio da 6 centurie di 100 fanti) e 4 turmae di cavalleria di 32 cavalieri ciascuna, per un totale di 480 fanti e 120 cavalieri. L'origine di queste formazioni risalirebbe al tipico modo di combattere dei Germani, descritto da Cesare nel suo "De bello Gallico".
La "spina dorsale" dell'esercito romano erano comunque le sue legioni, in numero di 28 (25 dopo la disfatta di Teutoburgo). Ogni legione era composta di circa 5.000 cittadini, in prevalenza Italici ma non di Roma (attorno al 65% erano perlopiù provenienti dalla Gallia Cisalpina, mentre il restante 35% era formato da cittadini romani residenti nelle province), per un totale di circa 140.000 uomini (e in seguito circa 125.000), che si rinnovavano con una media di 12.000 armati all'anno. L'ufficiale a capo della legione divenne ora un membro dell'ordine senatorio con il titolo legatus Augusti legionis. Le legioni erano arruolate fra i circa 4.000.000 di cittadini romani.
 |
| La Germania romanizzata, nel 9, con l'ubicazione della foresta di Teutoburgo, da https://upload.wi kimedia.org/wikipedia/common s/b/b3/Germania_7-9_Varo.jpg. |
Nel 9 d.C., dal 9 all'11 settembre, si combatte la battaglia della Foresta di Teutoburgo, chiamata clades Variana (la disfatta di Varo) dagli storici romani, tra tre legioni romane più ausiliari, guidate da Publio Quintilio Varo e una coalizione di tribù germaniche comandate da Arminio, ufficiale delle truppe ausiliarie di Varo, ma segretamente anche capo dei Cherusci. La battaglia ebbe luogo nei pressi dell'odierna località di Kalkriese, nella Bassa Sassonia, e si risolse in una delle più gravi disfatte subite dai Romani: tre intere legioni (composte di 5/6.000 armati ciascuna), la XVII, la XVIII e la XIX, furono annientate, oltre a 6 coorti di fanteria ausiliaria (di circa 600 uomini ciascuna) e 3 ali di cavalleria ausiliaria (di circa 500 armati l'una).
 |
| Tiberio, dal Museo di Venezia QUI. |
«[...] i soldati romani si trovavano là [in Germania] a svernare, e delle città stavano per essere fondate, mentre i barbari si stavano adattando al nuovo tenore di vita, frequentavano le piazze e si ritrovavano pacificamente [...] non avevano tuttavia dimenticato i loro antichi costumi [...] ma perdevano per strada progressivamente le loro tradizioni [...] ma quando Varo assunse il comando dell'esercito che si trovava in Germania [...] li forzò ad adeguarsi ad un cambiamento troppo violento, imponendo loro ordini come se si rivolgesse a degli schiavi e costringendoli ad una tassazione esagerata, come accade per gli stati sottomessi. I Germani non tollerarono questa situazione, poiché i loro capi miravano a ripristinare l'antico e tradizionale stato di cose, mentre i loro popoli preferivano i precedenti ordinamenti al dominio di un popolo straniero. Pur tuttavia non si ribellarono apertamente [...]». (Cassio Dione, Storia romana, LVI,18.).
Ignaro del reale stato d'animo dei Germani e approcciandosi a loro come se fossero dei sudditi arresisi alla volontà romana più che tribù vinte sul campo e costrette alla romanizzazione, Varo non coglieva il crescente rancore che covava nell'animo dei Germani per l'invasione romana, voluta a tutti i costi da Augusto per equipararsi al prozio Gaio Giulio Cesare, che aveva conquistato e mantenuto assoggettata, pur a prezzo di aspre insurrezioni, la Gallia dei Celti. Varo non considerava consistente questa situazione problematica a cui invece avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, tanto più che di esempi del passato ve ne erano stati in abbondanza, dal sanguinoso epilogo della vicina conquista della Gallia di 50-60 anni prima, alla recentissima rivolta delle genti dalmato-pannoniche.
«[...] Varo credeva che [i Germani] potessero essere civilizzati con il diritto, questo popolo che non si era potuto domare con le armi. Con questa convinzione egli si inoltrò in Germania come se si trovasse tra uomini che godono della serenità della pace e trascorreva il periodo estivo esercitando la giustizia [...] davanti al suo tribunale [...] ma i Germani, molto astuti nella loro estrema ferocia e fingendo [di essersi adeguati alla legge romana] indussero Varo ad una tale disattenzione ai problemi reali, che Varo si immaginava di amministrare la giustizia quasi fosse un Pretore urbano nel Foro Romano, non il comandante di un esercito in Germania [...]». (Velleio Patercolo, Storia romana, II, 117).
Nel settembre dell'anno 9, finita la stagione di guerra (che per i Romani incominciava a marzo e finiva a ottobre), Varo si muoveva verso i tre campi invernali che si trovavano a Alise (Haltern am See, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania), sede amministrativa lungo il Reno della nuova provincia di Germania, a Castra Vetera (l'attuale Xanten, in Renania Settentrionale/Vestfalia, Germania) e il terzo ad Ara Ubiorum (Köln/Colonia, anch'essa sul Reno). Il percorso abituale sarebbe stato quello di scendere dal fiume Weser (presso l'attuale località di Minden), attraversare il passo di Doren (le cosiddette porte della Vestfalia) e raggiungere l'alto corso della Lippe presso Anreppen, per poi proseguire fino a Haltern (la romana Aliso) e di qui al Reno. Al comando di tre legioni (la XVII, la XVIII e la XIX), reparti ausiliari (3 ali di cavalleria e 6 coorti di fanteria) e numerosi civili, Varo si spinse invece verso un nuovo percorso, in direzione ovest, affidandosi alle indicazioni di Arminio, ufficiale nelle sue truppe ausiliarie ma segretamente anche capo dei germani Cherusci.
Varo non sospettava che Arminio avesse progettato un'imboscata per sopraffare l'esercito romano in Germania, ma al contrario considerava Arminio un fedele alleato. Sia Velleio Patercolo che Cassio Dione raccontano che Varo non prestò fede a quelli (incluso Segeste, futuro suocero di Arminio), che lo avevano informato sul progetto di un agguato nei suoi confronti. Così, quando credette di assistere ad una rivolta (in realtà solo simulata) nei pressi del massiccio calcareo di Kalkriese (una collina alta 157 metri, situata nella Bassa Sassonia, oggi sito e museo archeologico di rilevante importanza), nel territorio dei Bructeri, Varo accettò di marciare su un percorso finora mai esplorato e all'interno di una folta foresta circondata da acquitrini, senza alcuna precauzione che lo mettesse al riparo da possibili aggressioni e non prendendo nemmeno in considerazione le voci circa un possibile agguato al suo esercito, assecondando così la volontà di Arminio.
Varo disponeva di tre intere legioni: la XVII, XVIII e XIX, oltre ad alcune unità ausiliarie (3 ali e 6 coorti), pari a circa 15.000 legionari e 5.000 ausiliari (a ranghi completi). I Germani di Arminio potevano invece contare su circa 20.000/25.000 guerrieri delle tribù dei Cherusci, Bructeri, oltre probabilmente a Sigambri, Usipeti, Marsi, Camavi, Angrivari e Catti.
E mentre i Romani si trovavano in serie difficoltà anche solo per avanzare, in un territorio a loro totalmente sconosciuto, dei Germani li attaccarono. Si trattava di una coalizione di popoli, sotto il comando di Arminio, che conosceva ottimamente le tattiche belliche romane, avendo egli stesso militato negli ausiliari durante la rivolta dalmato-pannonica del 6-9.
Arminio aveva predisposto con estrema cura tutti i dettagli dell'imboscata, aveva scelto come luogo dell'agguato il punto in cui la grande palude a nord si avvicinava di più alla collina calcarea di Kalkriese, e dove il passaggio era ristretto a soli 80-120 metri. Aveva fatto deviare Varo dal normale tracciato della strada, con lo scopo di condurre l'esercito romano in un imbuto senza uscita, dove aveva fatto costruire un terrapieno lungo circa 500-600 metri e largo 4-5 alla base della collina di Kalkriese (alta circa 100 metri), dietro cui si erano nascoste parte delle sue truppe (sul posto erano concentrati non meno di 20-25.000 armati), che stavano ora attaccando il fianco sinistro delle truppe romane.
 |
| Schema dell'agguato nella foresta di Teutoburgo, da https://best5.it/post/ le-5-sconfitte-peggiori -dellimpero-romano/. |
Alla fine della giornata, dopo numerose perdite subite, Varo riuscì a riorganizzare l'esercito, accampandosi in una zona favorevole, per quanto fosse possibile, su un'altura boscosa.
Secondo giorno: la difesa di Varo e l'avanzata impossibile. Il secondo giorno, dopo aver bruciato e abbandonato la maggior parte dei carriaggi e tutti i bagagli non necessari, i Romani avanzarono disposti in schieramenti più ordinati fino a raggiungere una località in campo aperto, non senza ulteriori perdite.
Da lì continuarono la marcia, forse ancora fiduciosi di potersi salvare, con la speranza di potersi avvicinarsi all'accampamento di Castra Vetera, sul fiume Reno, dove forse il legato Asprenate avrebbe potuto raggiungerli e salvarli. L'esercito procedeva in zone boscose che sembravano interminabili, assalito senza pietà dagli uomini di Arminio, che conoscevano bene il terreno e che non dovevano permettere ai Romani di organizzarsi e schierarsi, dato che in campo aperto le legioni avrebbero prevalso certamente. Fu proprio in questo frangente che i Romani subirono le perdite maggiori, poiché, per quanto cercassero di serrare i ranghi, lo spazio era troppo limitato per schierare una difesa. «[...] i Romani avevano serrato i ranghi in uno spazio assai stretto, in modo tale che sia i cavalieri sia i fanti attaccassero i nemici con uno schieramento compatto, ma in parte si scontravano tra loro ed in parte andavano ad urtare gli alberi [...]». (Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LVI, 21, 2.).
Terzo giorno: la morte di Varo e la strage dell'esercito romano. Il terzo giorno fu l'ultimo e il più tragico per l'armata romana, ormai decimata dalla furiosa lotta dei giorni precedenti. La pioggia e il vento si erano scatenati nuovamente, impedendo ai soldati romani di avanzare oltre e di poter costruire un nuovo accampamento entro cui difendersi. La pioggia era talmente copiosa che avevano difficoltà a usare le armi, in quanto scivolose. I Germani pativano di meno questa condizione poiché, per prima cosa il loro armamento era più leggero, poi conoscevano la zona e potevano attaccare e ritirarsi velocemente nella foresta. L'eco della battaglia aveva inoltre dato morale alle vicine tribù barbare che, fiduciose per l'esito finale della battaglia, avevano inviato nuovi rinforzi e infoltito così il già cospicuo numero di armati germani. I romani, sempre più decimati e ormai ridotti allo stremo, erano ovunque circondati e colpiti e si resero conto che non avrebbero resistito ulteriormente agli attacchi delle forze germaniche. «[...] per questi motivi Varo, e gli altri ufficiali di alto rango, nel timore di essere catturati vivi o di morire per mano dei Germani [...] compirono un suicidio collettivo [...]». (Cassio Dione Cocceiano, Storia romana, LVI, 21, 5.). «[... Quintilio Varo] si mostrò più coraggioso nell'uccidersi che nel combattere [...] e si trafisse con la spada [...]». (Velleio Patercolo, Storia romana, II, 119, 3).
Gran parte dei superstiti romani vennero sacrificati alle divinità germaniche. I restanti vennero liberati o scambiati con prigionieri germanici, oppure riscattati, se è vero che durante la spedizione del 15 (sei anni dopo la disfatta) Germanico si fece ricondurre sul campo di Kalkriese avvalendosi dell'aiuto dei pochissimi superstiti della battaglia (gli unici che fossero in grado di indicare il luogo), per dare degna sepoltura ai resti dei commilitoni morti sei anni prima. E fu qui che vide lo scempio di un autentico massacro.
Arminio, dopo questo grande successo militare, avrebbe voluto proseguire l'attacco a Roma alleandosi con l'altro grande sovrano germano Maroboduo, il re dei Marcomanni, come ci racconta Velleio Patercolo: «La crudeltà dei nemici germani aveva fatto a pezzi il cadavere, quasi completamente carbonizzato, di Varo, e la sua testa, una volta tagliata, fu portata a Maroboduo, il quale la inviò a Tiberio Cesare, perché fosse seppellita con onore [...]» (Velleio Patercolo, Storia romana II, 119)
Ora a Roma necessitava una reazione militare immediata e decisa per non permettere al nemico germanico di prendere coraggio e di invadere i territori della Gallia e magari dell'Italia stessa, mettendo a rischio non solo una provincia ma la stessa salvezza di Roma.
 |
| Ottaviano Augusto nell' Ara Pacis. |
In una situazione tanto drammatica, Augusto fu costretto anche ad arruolare liberti:
«[...] Augusto organizzò comunque le rimanenti forze con ciò che aveva a disposizione [...] arruolò nuovi uomini [...] tra veterani e liberti e poi li inviò con la massima urgenza, insieme a Tiberio, nella provincia di Germania [...]» (Cassio Dione Cocceiano, Storia Romana, LVI, 23, 3.)
«[...] due volte soltanto arruolò i liberti come soldati: la prima volta fu per proteggere le colonie vicine dell'Illirico, la seconda per sorvegliare la riva del Reno. Erano schiavi che provenivano da uomini e donne facoltosi, ma egli preferì affrancarli subito e li collocò in prima linea, senza mescolarli ai soldati di origine libera (peregrini) e senza dar loro le stesse armi.» (Svetonio, Augustus, 25.)
«[...] (Tiberio Cesare) viene inviato in Germania, e qui rafforza le Gallie, prepara e riorganizza gli eserciti, fortifica i presidi e avendo coscienza dei propri mezzi, non timoroso di un nemico che minacciava l'Italia con un'invasione simile a quella dei Cimbri e dei Teutoni, attraversava il Reno con l'esercito e passava al contrattacco, mentre al padre Augusto ed alla patria sarebbe bastato di tenersi sulla difensiva. Tiberio avanza così in territorio germano, si apre nuove strade, devasta campi, brucia case, manda in fuga quanti lo affrontano e con grandissima gloria torna ai quartieri d'inverno senza perdere nessuno di quanti aveva condotto al di là del Reno [...]» (Velleio Patercolo, Storia di Roma, II, 120.)
Nel settembre del 9, dopo aver brillantemente sconfitto i ribelli dalmati, Tiberio torna a Roma dove decide, giunta la notizia della battaglia della Foresta di Teutoburgo, di posticipare la celebrazione del trionfo che gli era stato tributato in modo tale da rispettare il lutto imposto per la disfatta di Varo. Augusto lo invia sul Reno, per evitare che il nemico germanico attacchi la Gallia e che le province appena pacificate possano rivoltarsi nuovamente in cerca dell'indipendenza. Giunto in Germania, Tiberio poté constatare la gravità della disfatta di Varo e delle sue conseguenze, che impedivano di progettare una nuova riconquista delle terre che andavano fino all'Elba. Adottò, dunque, una condotta particolarmente prudente, prendendo ogni decisione assieme al consiglio di guerra ed evitando di far ricorso, per la trasmissione di messaggi, a uomini del luogo come interpreti. Sceglieva allo stesso modo con cura i luoghi in cui erigere gli accampamenti, in modo tale da fugare qualsiasi pericolo di rimanere vittima di una nuova imboscata e mantenne infine, tra i legionari una disciplina ferrea, punendo in modo estremamente rigoroso tutti coloro che trasgredivano i suoi rigidi ordini. In questo modo poté ottenere numerose vittorie e confermare il confine lungo il fiume Reno, mantenendo fedeli a Roma i popoli germanici dei Batavi, Frisi e Cauci, che abitavano quei luoghi.
E comunque, dopo la pesante sconfitta, i Romani per riscattare l'onore dell'esercito sconfitto, diedero inizio a una guerra durata sette anni. La battaglia di Idistaviso del 16 è considerata la rivincita dell'Impero romano contro i Germani.
 |
| Germanico Giulio Cesare, figlio di Druso, da QUI. |
Le legioni romane, salite durante le guerre civili a 60 circa e attestate alla morte di Augusto a 25, non superarono durante l’impero il numero di 30 contemporaneamente in armi. Erano dislocate lungo tutto il limes difensivo dell’impero in campi permanenti costruiti in posti strategici. Dall’età di Augusto a quella di Caligola le legioni erano composte in maggioranza da italici. La legione, forte in età imperiale di circa 5.500 uomini, ebbe da Augusto un comandante permanente con il titolo di legatus (Augusti) legionis, solitamente un senatore di rango pretorio; nell’ufficialità furono confermate le figure dei 6 tribuni, acquisì grande importanza quella del praefectus castrorum e, soprattutto, quella del centurio, spina dorsale della legione.
Nei primi tre secoli, d.C., dopo la riforma mariana dell'esercito, le centurie erano composte tipicamente da ottanta uomini, in epoca tarda da cento, distribuiti in circa dieci contubernia. L'intera centuria era comandata normalmente da un centurione.
Il contubernium era la più piccola unità militare dell'esercito romano e in epoca classica indicava anche un rapporto permanente tra servi o tra dominus e serva. Il contubernium era composto da otto uomini possibilmente facenti capo ad un decano e in alcuni casi uno o più servi erano a disposizione dei legionari che ne facevano parte, secondo le disponibilità economiche degli stessi soldati. Dieci contubernia formavano una centuria. I soldati di uno stesso contubernium condividevano la stessa tenda (per questo erano definiti contubernales) ed erano ricompensati o puniti insieme. Tale termine ha passato tutta la storia romana divenendo un termine adoperato addirittura dai soldati dell'esercito inglese del 1800 per indicare i compagni di tenda, esattamente come accadeva nelle legioni dell'antica Roma.
In età alto-imperiale venne riorganizzato anche il reparto di tecnici e ingegneri militari atti a rendere più agevole il cammino delle armate romane durante le campagne militari o la loro permanenza negli alloggiamenti estivi (castra aestiva) ed invernali (hiberna). E così se le strade romane potevano essere utilizzate per velocizzare lo schieramento degli eserciti durante le operazioni di "polizia" lungo i confini imperiali, alcuni tipi di ponti potevano essere montati e smontati velocemente senza l'utilizzo di chiodi: in questo modo i legionari, che trasportavano un equipaggiamento di circa 40 chili (comprendente anche un palo per la palizzata del campo) potevano percorrere nella marcia circa 24 chilometri al giorno (40 quando potevano viaggiare più leggeri). In altri casi si provvedeva alla costruzione di strade in zone acquitrinose (pontes longi), come avvenne in Germania durante il periodo della sua occupazione, dal 12 a.C. al 9 d.C.
 |
| Balista romana. |
 |
| Ariete romana. |
 |
| Catapulta romana. |
 |
| Gaio Cesare Caligola da QUI. |
 |
| Nerone, da QUI. |
Nerone crea una nuova legione nel 66-67, composta da italici tutti di statura molto elevata, a cui viene dato il nome di I Italica, e che lo stesso Nerone ribattezza “falange di Alessandro Magno”, circostanza che denota le grandiose idee che si celavano nella sua mente. L'obiettivo della campagna militare consisteva nell'occupare le cosiddette “porte del Caspio” (passo di Darial), sottomettendo il popolo degli Albani e forse degli stessi Sàrmati Alani più a nord.
Galba porta a termine l'arruolamento di due legioni: la I Adiutrix (i cui effettivi erano costituiti da uomini che avevano prestato servizio nelle flotte italiche di Miseno e Ravenna) e la VII Gemina.
Vespasiano, al termine della guerra civile e della rivolta dei Batavi, scioglie ben quattro legioni che avevano trascinato nel fango le proprie insegne macchiandosi di disonore (I Germanica, IV Macedonica, XV Primigenia e XVI Gallica) e ne riformò tre nuove (II Adiutrix Pia Fidelis, IV Flavia Felix, e XVI Flavia Firma) dando la possibilità ad alcuni di fare pubblica ammenda. Il figlio Domiziano creava una nuova legione in vista delle campagne in Germania, nella regione degli agri decumates: la I Minervia.
 |
| Vespasiano: Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, foto di Carole Raddato da QUI. |
Con la dinastia dei Flavi (dal 69 al 96, con Vespasiano, Tito e Domiziano), furono introdotte per prime le unità ausiliarie milliariae, ovvero composte da circa 1.000 armati (create ex novo oppure incrementandone gli armati da una preesistente quingenaria) in tutte le sue tipologie: dalle cohortes peditatae, a quelle equitatae fino alle alae di cavalleria (quest'ultima considerata l'élite dell'esercito romano). Le alae milliariae erano formate, a differenza di quelle quingenariae, da 24 turmae di 32 uomini per un totale di 768 cavalieri. Il comandante di un'ala, che in origini era un principe nativo appartenente alla tribù dell'unità ausiliaria, era stato sostituito con un praefectus alae dell'ordine Equestre, che poteva restare in carica per un periodo di 3 o 4 anni, al termine del quale poteva accedere all'ordine senatorio. La paga (stipendium) fu invece aumentata di un quarto, portando così il compenso annuo a 333 denari per un cavaliere d'ala e a 200/266 denari per un cavaliere di cohors equitata. Nel I sec. 1 denario equivaleva ad 8 € attuali.
Dall’età di Augusto a quella di Caligola le legioni erano composte in maggioranza da italici, ma già negli anni fra Claudio e Nerone le proporzioni si equilibrarono, fino ad arrivare al periodo compreso tra i Flavi e Traiano in cui la proporzione divenne di 4 a 1 in favore dell’arruolamento provinciale.
Al tempo di Vespasiano sembra si attuò la riforma della prima coorte, che secondo alcuni studiosi moderni potrebbe essere invece avvenuta all'epoca di Augusto. Si trattava di una coorte milliare, vale a dire di dimensioni doppie rispetto alle altre nove coorti, con 5 manipoli (non quindi 6) di 160 armati ciascuno (pari a 800 legionari), a cui era affidata l'aquila della legione. Primo esempio di costruzione che ospitasse coorti di queste dimensioni, è la fortezza legionaria di Inchtuthill, in Scozia.
 |
| Carta dell'antica Giudea con indicata Masada. |
_01.jpg) |
| Vista aerea di Masada. "Aerial view of Masada (Israel) 01" di Godot13 - Opera propria. Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia .org/wiki/ File%3AAerial_ view_of_Masada_(Israel) _01.jpg. |
 |
La rampa d'assedio vista di lato, dall'alto di Masada. "Rampe massada1" di Posi66 dal de.wikipedia.org. Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons |
 |
| Torre mobile d'assedio romana. |
A Roma, nel II secolo, nella guardia pretoriana vengono istituiti gli Equites singulares Augusti (cavalieri personali dell'imperatore), corpo militare composto inizialmente da 500 cavalieri che costituivano la scorta dell'imperatore e ne garantivano la sicurezza durante le campagne militari. Il corpo, istituito al tempo della dinastia flavia e successivamente rinforzato da Traiano, fu sciolto da Costantino I dopo la battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio, in quanto gli Equites singulares si erano schierati al fianco di Massenzio.
Erano organizzati in alae di cavalleria, con ciascuna ala divisa in 16 turmae da 32 uomini, 16 decurioni, un decurione princeps, e comandate da un praepositus consularis per un totale di 512 cavalieri. Il loro numero potrebbe essere stato raddoppiato a 1.000 uomini da Diocleziano. Per poter diventare equites singulares occorreva aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni negli altri reparti dell'esercito, il servizio durava complessivamente venticinque anni, mentre sembra che non ricevessero alcuna paga extra rispetto alle alae di cavalleria. Gli equites singulares erano reclutati solitamente tra le alae ausiliarie, mentre l'etnia prevalente era dapprima germanica, successivamente a partire da Settimio Severo, in maggioranza fu composta da Pannoni, Daci e Traci.Traiano formò due nuove legioni, la prima in vista della conquista della Dacia (la XXX Ulpia Victrix, il cui numerale indicava che in quel momento vi erano esattamente 30 unità legionarie), la seconda prima delle campagne partiche (la II Traiana Fortis).
 |
| Traiano: Museo Archeologico di Venezia, foto di Carole Raddato da QUI. |
Durante le guerre di conquista di Traiano, imperatore romano dal 98 al 117, è introdotto l'uso del contus (lunga lancia da "carica", che misurava fino a 3,65 metri di lunghezza) per la cavalleria, oltre ad un primo reparto di cavalieri su dromedari ed un contingente di Daci.
 |
| Scena XXIII della Colonna traiana, da https://it.wikipedia.org/wiki/ Sarmati#/media/File:028_Conrad_ Cichorius,_Die_Reliefs_der_ Traianss%C3%A4ule,_Tafel _XXVIII_(Ausschnitt_01).jpg |
 |
| Cavalieri romani del II sec., dalla colonna traiana. Da https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria_%28storia_ romana%29#/media/File:104_Conrad_Cichorius,_ Die_Reliefs_der_Traianss%C3%A4ule, _Tafel_CIV.jpg |
La cavalleria legionaria potrebbe essere stata abolita, almeno per un breve periodo di tempo dall'imperatore Traiano, considerando che viene citata in un discorso del suo successore, Adriano. In questo periodo esistevano, infatti, numerosi reparti di cavalleria ausiliaria (formata da provinciali e alleati, i cosiddetti peregrini), quale degno completamento tattico e strategico alla fanteria legionaria (formata invece da cittadini romani).
 |
| Impero Romano nel 125, con le sue strade principali e gli stanziamenti delle sue legioni, da https://upload.wikimedia .org/wiki pedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png. |
 |
| Adriano: Museo delle Terme, Roma. Foto di Livioandronico2013 da QUI. |
La cavalleria romana "pesante" come gli equites cataphractarii o equites clibanarii (di origine sarmatica), adottata partire dal principato di Adriano, era dotata di una lunga e pesante lancia, chiamata contus (usata normalmente con l'ausilio di entrambe le mani, poiché a volte raggiungeva i 3,65 metri di lunghezza), inoltre cavalieri e cavalli erano interamente rivestiti di una maglia di metallo chiamata lorica squamata se formata da "scaglie" di metallo o lorica hamata se fatta invece da anelli del diametro di 3-9 mm.
Da Adriano in poi, l’elemento italico nelle legioni divenne pressoché inesistente e iniziò la tendenza a reclutare gli effettivi della legione nella stessa regione in cui essa era stanziata.
Intorno al 165-166, l'imperatore Marco Aurelio istituisce due nuove legioni. Si trattava della II e III Italica.
 |
Marco Aurelio: Musei Capitolini di Roma. |
 |
Commodo rappresentato con gli attributi di |
 |
| Settimio Severo |
Nel III secolo alcune tribù associate con la cultura di Wielbark (nota anche come cultura di Willenberg, cultura pre-letterata che gli archeologi hanno identificato con i Goti), stanziate nei pressi del mar Baltico, abbandonano la Scandinavia e, seguendo i fiumi Vistola, Bug Occidentale e il Nistro (Dnestr), si stanziano fra le steppe del mar Nero, mescolandosi con Daci, Sàrmati, Bastarni e altre tribù. Queste popolazioni germaniche improntarono usi e costumi facendo evolvere la cultura di Černjachov (la parte della popolazione gota che visse in Ucraina e in parte della Bielorussia). Nello stesso periodo una parte dei Vandali e dei Burgundi presero altri percorsi: i Vandali, verso le pianure del Danubio centrale; i Burgundi, verso la riva sinistra del fiume Oder. Dal 1200 a.C. popolazioni nomadi a cavallo e armate di arco, fra cui i sarmatici Roxolani, Iazigi, Aorsi e Alani oltre a Taifali, domineranno a lungo il territorio che andava dalle pianure del Danubio fino alle steppe del mar Nero. Nonostante l'invasione di Goti e Vandali nel III sec. d.C., gli eserciti dei quali erano principalmente formati da agricoltori appiedati, Sàrmati e Taifali riuscirono a preservare il loro dominio in alcune aree, almeno sino alla comparsa degli Unni.
La tabella qui sotto riporta la consistenza numerica e la gerarchia interna alle principali unità ausiliarie nel II secolo, compresa quella relative alle unità di cavalleria o mista di fanti e cavalieri.
Unità ausiliaria Servizio Comandante Subordinato n°sotto-unità composte da n°tot. nell'Unità
Ala quingenaria cavalleria praefectus alae decurione 16 turmae 30 (o 32) 480 (o 512)
Ala milliaria cavalleria praefectus alae decurione 24 turmae 30 (o 32) 720 (o 768)
Cohors quingenaria fanteria praefectus cohortis centurione 6 centuriae 80 480
Cohors milliaria fanteria tribunus militum centurione 10 centuriae 80 800
Cohors equitata fanteria praefectus cohortis centurione (fanti) 6 centuriae 80 480 fanti) quingenaria e cavalleria equitatae decurione (cav.) 4 turmae 30 120 cav.
Cohors equitata fanteria tribunus militum centurione (fanti) 10 centuriae 80 800 fanti) milliaria e cavalleria decurione (cav.) 8 turmae 30 240 cav.
Risultano alcune discrepanze sui risultati delle analisi sul numero delle truppe ausiliarie nell'esercito romano, tra Spaul (analisi effettuate nel 2000) e Holder (analisi effettuate nel 2003), lungo il limes romano attorno alla metà del II secolo:
Autore n° Alae n° Cohortes n° tot. unità Totale cavalieri Totale fanti Totale degli effettivi
J. Spaul (2000) 80 247 327 56.160 124.640 180.800
P.A.Holder (2003) 88 279 367 74.624 143.200 217.624
Nelle forze in campo non sono conteggiati gli ufficiali (centurioni e decurioni), che rappresentavano una forza di circa 3.500 uomini in totale. La differenza di 40 unità ausiliarie e circa 40.000 effettivi fra i due conteggi è dovuta principalmente al fatto che:
 |
| Busto di Alessandro Severo, Roma, Musei Capitolini. https://it.wikipedia.org/wiki/ Alessandro_Severo#/media/ File:Alexander_Severus _Musei_Capitolini_ MC471.jpg. |
 |
| Gaio Giulio Vero Massimino, noto come Massimino il Trace, il primo imperatore barbaro, da: QUI. |
Questo processo di graduale incremento di reparti di cavalleria, che potrebbe aver generato una maggiore "mobilità" anche nella legione stessa, culminò nella riforma di Gallieno. Di fatto la cavalleria andava a costituire una sorta di "nuova riserva strategica" collocata nelle retrovie, in aggiunta alla legio II Parthica. L'esercito iniziava a tradursi in una forza meno stanziale, non più puramente di "confine o sbarramento", come era stato per i due secoli precedenti, in cui era apparsa legata in prima istanza alle forze di fanteria e in misura ridotta a quelle montate.
 |
Valeriano su sesterzio. Di Classical Numismatic |
 |
| L'Europa centrale nel 258-260 con i percorsi delle migrazioni delle delle confederazioni dei Franchi, dei Suebi Alemanni, Marcomanni e Quadi, dei Sàrmati Iazigi. Immagine da: QUI. |
L'imperatore d'Occidente dal 253 al 268 Gallieno, resosi conto dell'impossibilità di proteggere contemporaneamente tutte le province dell'impero solo con una frontiera lineare, sviluppò una pratica che era iniziata verso la fine del II secolo sotto Settimio Severo (con il posizionamento di una legione, la legio II Parthica, a pochi chilometri da Roma), ovvero una riserva strategica, formata prevalentemente da unità di cavalleria pesante, di soldati ben addestrati pronti ad intervenire dove servisse nel minor tempo possibile. La base principale scelta da Gallieno per la nuova armata, fu posta a Milano, punto strategico equidistante da Roma e dalle vicine frontiere settentrionali di Rezia e Norico.
Con la riforma di Gallieno, la nuova unità di cavalleria legionaria si divideva tra le dieci coorti della legione, e alla prima coorte erano affiancati 132 cavalieri (pari a 4 turmae, ciascuna composta da 32 cavalieri, sotto il comando di un decurione), mentre alle altre nove coorti, 66 cavalieri ciascuna (pari a 2 turmae per ciascuna delle rimanenti 9 coorti).
In totale quindi, si avevano ben 22 turmae per ogni nuova legione, comandate da 22 decurioni. La riprova di tutto ciò sembra derivare da un'iscrizione trovata a Baden, in Germania, dove su un anello è scritto: "EQ(ues) LEG(ionis) XXI SEXTI T(urmarum?)". Una predisposizione per la cavalleria dunque, che riguardava non solo le forze ausiliarie ed i numeri ma anche le legioni, dove il numero di cavalieri passava da 120 a 726 per legione, con la prima coorte affiancata da 132 cavalieri e le altre nove da 66 cavalieri ciascuna. Questo incremento era dovuto proprio alla necessità di avere un esercito sempre più "mobile".
 |
| L'imperatore Gallieno. |
La cavalleria legionaria di questo periodo appare divisa ancora in turmae e guidata da decurioni. In battaglia, il decurione era affiancato dal draconarius, portatore dell'insegna del draco (simbolo di nuova introduzione per le coorti e le unità di cavalleria, di derivazione dacico-sarmatica), e seguito da un calo (lo schiavo del decurione che montava il suo cavallo di riserva).
Sembra che i cunei o cunei equitum, unità di cavalleria, siano stati costituiti nel corso del III secolo. Erano in sostanza similari ai numeri, quindi con marcate connotazioni etniche, ma a differenza di quest'ultimi, sembra che si differenziassero proprio per la caratteristica di utilizzare solo reparti di truppe montate a cavallo.
 |
Aureliano, da: QUI. |
Ai tempi di Aureliano le legioni scesero a 31, per un totale di 150.000 legionari, affiancati probabilmente da un'altra metà di ausiliari, certamente maggiore in alcune province, per un esercito complessivamente composto da 300.000 uomini, di molto inferiore a quello di settant'anni prima a causa dell'incidenza delle guerre civili, delle numerose sconfitte e delle difficoltà di reclutamento. Il ricorso a unità di cavalleria svincolate dalle legioni (le vessillazioni) si era fatto sempre più frequente.
 |
Diocleziano. |
Data la crescente difficoltà a contenere le numerose rivolte all'interno dell'impero, nel 293 si procedette a un'ulteriore divisione funzionale e territoriale, al fine di facilitare le operazioni militari: Diocleziano nomina come suo cesare (vice e successore) per l'oriente Galerio e Massimiano fece lo stesso con Costanzo Cloro per l'occidente, così che la diarchia tramuta in tetrarchia. Nell'ambito della cavalleria avverranno importanti riforme collegate a questa nuova divisione dei territori imperiali, operate poi anche dal successore Costantino I.
Lo sfondamento ripetuto di tutte le frontiere romane, eredità della crisi del III secolo, costrinse Diocleziano a creare un modello di difesa che moltiplicasse il normale ed unico comando imperiale in uno formato ora da quattro imperatori: la tetrarchia. Ciò determinò, di conseguenza, la necessità di creare nuove e numerose legioni da porre lungo i confini imperiali. Questa necessità strategica di difesa del limes, portò inevitabilmente ad un incremento del fabbisogno finanziario statale per mantenere le armate che ormai sembra raggiungessero i 450.000/500.000 uomini. Si rese così necessaria un'ulteriore tassazione del cittadino romano e una miglior distribuzione della circolazione monetaria per meglio rifornire le truppe alloggiate e distribuite a guardia dei confini provinciali.
La forma di governo a quattro, se da un lato non fu così felice nella trasmissione dei poteri (vedi successiva guerra civile), ebbe tuttavia il grande merito di fronteggiare con tempestività i pericoli esterni al mondo romano. La presenza di due Augusti e due Cesari facilitava, infatti, la rapidità dell'intervento armato e riduceva i pericoli che la prolungata assenza di un unico sovrano poteva arrecare alla stabilità dell'Impero.
Diocleziano creò una vera e propria gerarchia militare sin dalle più alte cariche statali, quelle dei "quattro" Imperatori, dove il più alto in grado era l'Augusto Iovio (protetto da Giove), assistito da un secondo Augusto Herculio (protetto da un semidio, Ercole), a cui si aggiungevano i due rispettivi Cesari, ovvero i "successori designati".
In sostanza si trattava di un sistema politico-militare che permetteva di dividere meglio i compiti di difesa del confine: ogni tetrarca, infatti, curava un singolo settore strategico e la sua sede amministrativa era il più possibile vicino alle frontiere che doveva controllare (Augusta Treverorum e Mediolanum-Aquileia in Occidente; Sirmium e Nicomedia in Oriente), in questo modo era possibile stroncare rapidamente i tentativi di incursione dei barbari, evitando che diventassero catastrofiche invasioni come quelle che si erano verificate nel III secolo.
 |
| Sculture raffiguranti i Tetrarchi trafugate dai Veneziani nel 1201 a Costantinopoli durante la IV crociata. |
Diocleziano riorganizzerà l'esercito, uscito dalla grande crisi del III secolo, comprendendo quale importanza rivestisse allora la di cavalleria, l'unica forza che potesse essere tempestiva lungo tutto il limes.
Trasformò infatti la "riserva strategica mobile" introdotta da Gallieno (di sola cavalleria) in un vero e proprio "esercito mobile" detto comitatus, nettamente diverso da un "esercito di confine" stanziale.
Il comitatus era costituito da:
Si divisero le forze armate in esercito di campagna (truppe palatinae, della guardia imperiale; comitatenses, del comitatus dell’imperatore) ed esercito confinario (truppe riparienses, poichè limitrofe a fiumi o limitaneae se nei pressi del limes). Con la riforma di Diocleziano, ma soprattutto con quella di Costantino e dei suoi figli, le vessillazioni divennero unità di cavalleria standard: le vexillationes palatinae e quelle comitatentes erano nominalmente formate da 300 o 600 cavalieri. La Notitia dignitatum, un documento che riporta la disposizione delle unità militari all'inizio del V secolo, elenca ben 88 vessillazioni.
 |
Massenzio |
 |
La testa della colossale statua di Costantino, nei musei Capitolini di Roma. |
La Schola Palatina era una unità di cavalleria d'élite dell'esercito del tardo Impero romano, al diretto comando dell'imperatore, di cui costituivano la guardia. Le scholae palatinae furono istituite all'inizio del IV secolo, per opera di Diocleziano o di Costantino I, che aveva sciolto l'antica guardia imperiale dei Pretoriani, compresi gli Equites singulares Augusti (letteralmente la cavalleria personale dell'imperatore). Le scholae furono poi divise tra l'Impero romano d'Occidente e d'Oriente: le prime, in quanto guardia imperiale, furono sciolte da Teodorico il Grande (e continuarono ad esistere, forse come guardie cittadine di Ravenna, fino al VI-VII secolo), le seconde sopravvissero fino al tardo XI secolo, quando scomparvero durante il regno di Alessio I Comneno. Ogni schola era una unità di cavalleria, composta, all'epoca di Giustiniano I (VI secolo), da 500 cavalieri, reclutati soprattutto tra le tribù germaniche: Franchi e Alemanni nella parte occidentale dell'impero e Goti in quella orientale. Ogni schola era comandata da un tribuno, poi successivamente al V secolo da un comes scholarorum, che aveva sotto il suo diretto comando un certo numero di ufficiali anziani detti domestici o protectores. Se all'inizio de IV secolo erano elencate tre unità, nel V secolo la Notitia dignitatum elenca sette scholae nella parte orientale dell'Impero e cinque in quella occidentale.
E se si ricordano solo poche unità di Cataphractarii nell'esercito del Principato (fino al 284), furono invece assai più numerose quelle nel tardo Impero romano, soprattutto in Oriente. Se ne registrano ben 19 unità secondo la Notitia Dignitatum, una delle quali era una schola, reggimento imperiale di guardie a cavallo. Tutte queste unità, tranne due, appartenevano al Comitatus, con una minoranza tra i Comitatensi palatini, mentre ci fu solo un'unità militare di arcieri catafratti.
Reggimenti cataphractarii nel tardo Impero romano:
 |
| Carta con quella che ancora oggi chiamiamo "Pianura Sarmatica" fino al Kuban' caucasico. |
 |
| Mesia con evidenziata Adrianopoli, in Tracia, da: QUI. |
 |
| Solidus di Flavio Giulio Valente (Cibalae, Vinkovci città della Croazia, 328 - Adrianopoli, 9 agosto 378), imperatore d'Oriente, da: QUI. |
 |
| Battaglia di Adrianopoli. |
 |
| Schema della battaglia di Adrianopoli, da https://best5.it /post/le-5-sconfitte-pegg iori-dellimpero-romano/. |
 |
Carta con le date dell'avanzata della migrazione dei Visigoti attraverso l'Europa. |
 |
Solidus di Flavio Graziano (359 - 383). Di Rasiel Suarez - Opera propria, CC BY- SA 3.0: QUI. |
La perdita dell'Africa ebbe riverberi inevitabili e seri sulle finanze dello stato, indebolendo ulteriormente l'esercito (attorno al 444). Le perdite subite portarono all'ammissione in grosse quantità di ausiliari e foederati germanici (ad esempio Unni): ciò poteva portare benefici a breve termine, ma era deleterio a lungo termine, in quanto diminuiva gli investimenti nel rafforzamento delle unità regolari.
Nel tardo impero l'esercito, per difendere i confini imperiali dalla crescente pressione barbarica, non potendo contare su reclute insignite di cittadinanza, a causa sia del calo demografico all'interno dei confini dell'Impero, sia della resistenza alle coscrizioni, ricorse sempre di più a contingenti di gentiles (fino a una vera deriva "mercenaristica"), utilizzati dapprima come mercenari a fianco delle unità regolari tardo imperiali (legiones, vexillationes e auxilia), ed in seguito, in forme sempre più ingenti e diffuse, come alleati che conservavano le loro tradizioni e le loro usanze belliche. Il risultato fu un esercito romano nel nome, ma sempre più culturalmente estraneo alla società che era chiamato a proteggere.
Vegezio, autore di un manuale di strategia militare redatto tra la fine del IV secolo e la prima metà del V secolo, si lamentò per l'imbarbarimento progressivo dell'esercito romano, il quale, cominciando a combattere alla maniera barbarica, perse il suo tradizionale vantaggio nella superiore disciplina e strategia militare; lo stesso Vegezio si lamentò per il fatto che l'imperatore Graziano avesse permesso ai suoi fanti, probabilmente di origini barbariche, di non indossare più elmo e armature, esponendoli maggiormente alle armi nemiche e portando come nefasta conseguenza a diverse sconfitte contro gli arcieri goti. Vegezio lamentò poi che non si costruissero più accampamenti e riferisce le conseguenze nefaste di questa scelta. Sempre Vegezio lamentava poi che i proprietari terrieri, non intendendo perdere manodopera, escogitavano diversi espedienti pur di non fornire soldati all'esercito, ricorrendo anche alla corruzione degli ufficiali reclutatori: ciò fece sì che, invece di reclutare gente idonea al combattimento, venissero reclutati pescatori, pasticcieri, tessitori ed altre professioni ritenute non idonee da Vegezio. La soluzione di Vegezio era tornare all'antico modo di combattere, alla "maniera romana", abbandonando il modo di combattere "alla barbara" introdotto dal sempre più crescente arruolamento di Barbari; in Occidente, tuttavia, per diverse ragioni, non si riuscì a invertire questa tendenza, portando alla sua rovina.
 |
Territori degli Unni, con la loro capitale, nella pianura ungherese, |
 |
| Gli Unni in battaglia contro gli Alani in un'illustrazione ottocentesca di Johann Nepomuk Geiger, da https ://it.wikipedia.org/wiki/Unni |
 |
Quinotauro, di Andrea Farronato. |
Nel V sec. si registravano nell'impero Romano 175 legioni, ormai notevolmente ridotte di consistenza e importanza rispetto ai numeri barbarici, assai più bellicosi.
 |
| Invasioni nell'Impero Romano dal 375 Immagine modificata da: MapMaster- Opera propria, CC BY-SA 2.5: QUI. |
 |
| Flavio Belisario, generale dell'Impero Romano d'Oriente, dal mosaico della chiesa di S. Vitale di Ravenna, da http://tizi anobedonni.blogspot. com/p/la-staffa-origini -e-storia.html |
 |
Kaganato degli Àvari nel 600 da https://upload. wikimedia .org/wikipedia/commons/a/af/East-Hem_ 600ad.jpg. Nella carta si possono vedere le posizioni dei Magiari, degli Oghuz e di altre popolazioni turco-mongole, varie popolazioni slave, tutte con le scritte nere, le popolazioni germaniche vassalle dell'impero romano scritte in blu, le popolazioni di stirpe iranica scritte in verde. |
In Europa, stante i ritrovamenti archeologici, le staffe sono dunque abbastanza frequenti a partire dal 560 d.C. nelle tombe degli Àvari in Ungheria, verosimilmente introdotte dai “nomadi delle steppe”. L'adozione della staffa non fu però dovunque immediata tant'è che fino all'ottavo secolo continuano ad apparire figure di cavalieri senza staffe. In nord Europa, i “Longobardi” stessi, un popolo germanico che pur venuto a contatto con gli Àvari nel V e VI sec. non ne apprese da loro l'uso, ma l'adottò solo dopo la migrazione in Italia (nel 586 d.C.), apprendendone qui l'uso evidentemente dai popoli locali e dai Romani Orientali (Bizantini).
LA CAVALLERIA nella TARDA ANTICHITÀ e nel MEDIOEVO - La tarda epoca imperiale romana e gli albori del primo medio-evo, con l'introduzione della staffa, vedono stravolgere in Eurasia e in Europa ogni tattica militare ed avviano il progredire di differenti e nuove tecniche equestri. Analizzando la storia militare della cavalleria non possiamo non rilevare come si contrappongano e si alternino ripetutamente due concezioni tattiche opposte: la “cavalleria leggera” e la “cavalleria pesante”.
La cavalleria leggera: rapida, con cariche veloci che non arrivano quasi mai a fondo; con attacco a distanza e la cui arma più tipica è l'arco; con cavalieri che scagliano le frecce e con una rapida conversione si ritirano per poi tornare all'attacco di nuovo; evitando sempre di prendere contatto col nemico. Una tattica tipica dei cavalieri nomadi delle vaste steppe e di chi principalmente assale e non deve difendere né città né beni immobili. Una tattica specializzata nell'impegnare il nemico in lunghe corse per stancarlo ed attirarlo lontano dalle basi per poi attaccarlo agevolmente in orde. Cavalli veloci, agili e leggeri, di tipo “meso-dolicomorfo” selezionati per l'uso. Cavalieri agili, con staffature corte e selle leggere. Poco ingombranti. Cavalieri “leggeri sulle staffe” e che proprio grazie all'utilizzo delle staffe non “gravano” seduti sul dorso dei “destrieri” ma se ne distaccano in velocità distribuendo maggiormente il loro peso su ambo i lati lasciando al cavallo la massima libertà di “schiena” in manovra e in tutti i “tempi di sospensione da terra”.
La cavalleria pesante: più lenta, più statica, d'urto e che ha come arma l'impatto travolgente e la lunga lancia; col cavaliere protetto da una più robusta e pesante corazza e da uno scudo e che pertanto ricerca lo scontro ravvicinato. Un tipo di combattimento e di “cavalleria” che pare sia stata introdotta dai cavalieri “Sarmati” e di cui l'avvento della staffa accentuò le differenze dalla tarda epoca imperiale in poi e con l'inizio del Medio-Evo. Cavalieri con staffature-lunghe e gambe praticamente distese in selle più avvolgenti e pesanti ed in grado di dare “stabilità” sia a chi indossava più voluminose armature che alle “reste” delle lance. Cavalieri seduti in toto sul dorso, col loro totale e ingombrante peso e quello delle armature gravante in toto sulle schiene dei cavalli. Cavalli morfologicamente diversi da quelli funzionali alla “cavalleria-leggera”: cavalli meso-brachimorfi, più robusti e più lenti; in grado di “portare-peso” e appositamente selezionati per l'uso.
Il diverso utilizzo della staffa (e delle selle) caratterizza sia i (due) diversi tipi di “monta” che di “cavalleria”; che di tecnica “equestre” e di “combattimento”.
Come già evidenziato nello "Strategikon" di Maurizio, i “cavalieri catafratti” entrarono a far parte stabilmente della cavalleria in epoca tardo-romana per contrastare le cavallerie dei Parti prima, dei Sassanidi poi, oltre che dei Sarmati, ecc.. Se all'inizio, in occidente, la cavalleria costituiva prevalentemente una particolare squadra di “esploratori” o di “inseguitori” leggeri; la “cavalleria pesante” divenne un corpo ben distinto di cavalleria “d'urto”. Inizialmente i primi “cavalieri-catafratti” di epoca romana erano armati con una lancia a due punte e di una spada leggermente più lunga del corto gladio già in dotazione ai legionari, e avevano un elmo con pennacchio e con apertura a visiera, e la loro corazza (praticamente una evoluzione modificata della “lorica-squamata”) proteggeva anche braccia e gambe. Le prime unità di “catafratti” furono introdotte nell'esercito romano da Adriano e si trattava di poche unità, che divennero numerose solo nel periodo del tardo impero soprattutto in Oriente, dove era sorta la “scuola” di addestramento ed erano state create ben 19 unità di base oltre al primo-reggimento di guardie-imperiali a cavallo che la storia ricordi. Tutte queste unità imperiali comprendevano sia arcieri che lancieri catafratti. Il catafratto-bizantino fu in pratica il diretto erede di quello romano di Adriano. In epoca tardo imperiale e bizantina il “cavaliere-catafratto” vide rinnovato il suo equipaggiamento, con l'aggiunta di un differente ed efficace arco e frecce; la spada tipo “gladio” fu sostituita con la sciabola , molto utile in un combattimento a cavallo. Furono dotati di una corazza molto più forte, di un elmo di epoca medievale, con più vistosi pennacchi (per abbellirlo e per far più timore al nemico); e come conferma lo “Strategikon” (il manuale scritto da Maurizio di Bisanzio), furono adottate le staffe e aggiunti i ferri ai cavalli. In definitiva cambiò un'epoca e grazie al reparto dei cavalieri-catafratti e staffati, Bisanzio riuscì ad ottenere molti successi in Occidente. In realtà, la cavalleria bizantina rappresenta una fusione delle due tattiche. Con essi inizia tuttavia il Medio-Evo e l'epopea cavalleresca. In tal senso occorre rammentare che poiché anche nelle tombe dei “Franchi”, nella tomba di Carlo Martello (714-741) avo di Carlo Magno è stata trovata una staffa; la qual cosa ci autorizza a supporre che anche la sua cavalleria ne facesse uso corrente già nella storica battaglia di Poitiers del 732 contro i “mori”; e ad ipotizzarne l'utilità che tale ausilio possa avere avuto in quella vittoria che tanta influenza ebbe per il successivo corso della storia medievale. Gli Arabi sconfitti a Poitiers da Carlo Martello infatti, che erano divenuti padroni dell'Africa Settentrionale, della Spagna e di parte della Sicilia, non conoscevano l'uso della staffa avendo adottato una cavalleria leggera e priva di staffe. Essi la adottarono infatti poi assai tardi, in pratica dopo il 1000 e quando ormai in tutto il resto d'Europa (e oltre) il suo uso era diffuso e tecnicamente consolidato da secoli.
Così come l'invenzione e l'introduzione della staffa e della sella ha segnato una svolta epocale e storica nell'utilizzo del cavallo e nell'equitazione (tecnica equestre), ancor oggi il diverso utilizzo della staffa e delle selle caratterizza sia i diversi tipi di “monta” (discipline sportive), che di tecnica “equestre”, che di “utilizzo” del cavallo. E l'utilizzo (la destinazione d'uso) ne condiziona ancor oggi come in passato la “selezione” e la scelta in quanto a “razze” e “tipi” morfologici più funzionali ai diversi impieghi.
In Europa, con la definitiva adozione delle staffe, i cavalieri poterono utilizzare in battaglia il peso del loro corpo e quello del cavallo per condurre gli attacchi “lancia in resta”, ossia con la lancia fissata a un’apposita appendice dell’armatura (la resta, appunto). Per mezzo delle staffe il cavaliere poteva sostenersi poggiando esclusivamente sui piedi, e ciò gli rendeva libere le braccia e le mani per usare le armi, potendo così scagliare in modo più efficace lance e frecce nonché maneggiare la spada durante la battaglia.
Fin dall’epoca dell'invincibile cavalleria macedone di Alessandro, dove i cavalieri avevano l’immenso gap operativo di dover controllare le bestie solo con le ginocchia mentre andavano alla carica, rischiando comunque al momento dell’urto con il nemico di essere sbalzati di sella, l’avvento della staffa rivoluzionerà le tattiche militari tardo-antiche e medievali. Sarà questo semplicissimo strumento, ovvero un cerchio metallico a fondo piatto che pende ai lati della sella e nel quale il cavaliere può riporre il piede, a consegnare definitivamente il ruolo di regina delle battaglie, dalla fanteria di epoca classica alla cavalleria romano-orientale e medievale. In campo militare costituirà la più importante delle innovazioni, poiché garantendo maggior stabilità, permetterà movimenti più complessi e articolati. Infatti il cavaliere poteva finalmente utilizzare al meglio sia la lancia da carica sia l’arco, senza rischiare il disarcionamento per aveva mollato le briglie della cavalcatura.
Fin dalla crisi del III secolo, durante il periodo di anarchia militare iniziato con la scomparsa della dinastia dei Severi, l’esercito aveva avuto un tracollo. Questo era dovuto alla sua usura costante durante le guerre civili, non alla forza barbarica. Va detto infatti che quando i romani trovarono un forte leader, vedi Aureliano dal 270 al 275, riuscirono a schiacciare sia usurpatori, sia stati secessionisti come le Gallie o Palmira, sia barbari esterni come alemanni e goti. Un’altra prova della superiorità legionaria a dispetto dell’opinione degli storici filo-cavalleria si può notare ancora un secolo dopo. Nel 357 il cesare Giuliano, poi passato alla storia come Giuliano l’Apostata, sconfisse con una coalizione di popoli germanici guidata dagli alemanni presso Argentorarum.
Ma analizziamo più compiutamente quello che avevamo accennato a proposito dei cambiamenti avvenuti fin dal III secolo. Quello che voglio evidenziare è che l’esercito romano abbia per certo subito cambiamenti, ma il suo nucleo, l’essenza di forze di fanteria pesante, sia rimasto intatto almeno fino al definitivo tracollo che passa tra due eventi traumatici: Adrianopoli nel 378 in oriente e la caduta del limes renano nel 406 in occidente.
I cavalieri sono sempre stati il tallone d’Achille dei romani. Fin dall’epoca repubblicana i loro contingenti erano reclutati prima presso i socii italici, poi presso gli alleati o i popoli sottomessi (esempi famosi sono stati i numidi o i galli). Lo strumento principe, quello dove militavano i giovani rampolli dell’aristocrazia dell’Urbe e che era l’unico degno di un vero cittadino, era la legione. Il suo bacino di reclutamento si allargò lentamente fino all’inizio del III secolo d.C., all’inizio riservato ai soli cives romani, poi inglobò tutti gli italici e infine anche i provinciali di comprovata fedeltà (come galli e africani). Con la Constitutio Antoniniana del 212 la cittadinanza venne estesa a tutti i cittadini liberi dell’Impero con l’obbiettivo di allargare le possibilità di tassazione, ma l’effetto più incisivo fu di declassare definitivamente l’arruolamento degli italici nell’esercito, in favore delle provincie. Segno distintivo di questo passaggio è l’aumento esponenziale di galli, illirici, africani, ispanici e orientali nelle legioni, nei quadri di comando superiori e infine sul gradino più alto della gerarchia romana, ovvero il soglio imperiale (da Massimino il Trace fino a Filippo l’Arabo).
Tra la fine del III e l’inizio del IV secolo salì al potere un illirico passato alla storia come l’ultimo grande persecutore di cristiani, Diocleziano, che riuscì, dopo decenni di guerre civili, a rimanere in sella abbastanza tempo (vent’anni, un vero record!) da poter ridare respiro all’esausta compagine imperiale. Qui non affronterò né la riforma fiscale da lui intrapresa, né l’importante esperimento della tetrarchia (fallita con Costantino, che spazzò via tutti i tetrarchi), ma mi limiterò ad analizzare con voi la sua ristrutturazione dell’esercito.
Questo è uno dei motivi per i quali molti storici sbrigativi hanno affermato, facendo calcoli basati sul testo della Notitia Dignitatum (una sorta di elenco di tutte le forze imperiali della fine del IV secolo), che le forze romane potevano annoverare oltre 650.000 uomini tra oriente e occidente agli inizi del V secolo. La Notitia, per quanto sia effettivamente un documento redatto dalla Cancelleria Imperiale di quel periodo, presenta due ordini di problemi:
Alla cavalleria più antica, che serviva per operazioni di esplorazione, pattugliamento e disturbo, si stava sempre più associando quella di un altro tipo, finalizzata a cercare l’urto e lo sfondamento dei ranghi avversari. Copiando le formidabili truppe a cavallo persiane, sia corazzate sia equipaggiate come arcieri montati, che erano tanto temute nelle guerre in oriente, nacquero i reparti di catafracti e clibanarii, truppe a cavallo dotate di pesanti armature sia per gli uomini sia per i cavalli.
Con i due momenti traumatici del 378 e del 406 questo sistema militare si avviò verso il tramonto. Le forze comitatenses, travolte non per loro demeriti o deficienze ma per la mancanza di una guida autorevole (Valente per la prima data e l’imbelle Onorio per la seconda), vennero sempre più spesso rimpiazzate da contingenti barbari che non venivano più addestrati “alla romana”, ma tendevano a combattere alla maniera dei loro avi, chi con l’ascia e la lancia a piedi come franchi e alemanni, chi a cavallo come goti e più tardi gli unni.
Ma ora analizziamo i diversi casi che, tra il V e il XV secolo, resero famosa la cavalleria. Infatti questo non è un percorso perfettamente lineare, anzi ebbe diverse oscillazioni a seconda dei popoli che la adottarono nei propri eserciti, dei suoi usi e del suo armamento.
Queste due deficienze vennero superate dal popolo delle steppe che seppe creare il più grande impero della storia (nel XIII secolo contava trentasei milioni di km², con cento milioni di sudditi), i mongoli.
Passiamo ora al cavaliere bizantino, unità che aveva preso spunto dalle innovazioni portate dai numerosi popoli della steppa che vennero in contatto con Costantinopoli, dagli unni fino ai turchi selgiuchidi.
Ma ora abbandoniamo il teatro di guerra bizantino per spostarci ad ovest, andando a studiare lo strumento principe degli eserciti medievali dell’Europa occidentale, il cavaliere pesante. Di sicuro l’antenato del cavaliere feudale dell’anno mille è il guerriero montato di epoca carolingia. I franchi infatti, dall’epoca in cui erano famosi per i fanti armati d’ascia, si erano pian piano riconvertito all’uso di forti contingenti a cavallo armati e bardati pesantemente. Dalle fonti degli storici dell’epoca sappiamo che il popolo franco, insediatosi nella Gallia romana fin da quel fatidico 406, basò tutta la sua fase di affermazione e conquista degli altri barbari (burgundi, alemanni, sassoni e visigoti) della regione sulla sua resistente fanteria e questo modo di fare la guerra rimase in uso almeno fino a Carlo Martello. Questi era il maggiordomo di palazzo dei sovrani merovingi del regno franco. Gli ultimi sovrani erano passati alla storia come re fannulloni, tanto che vennero rimpiazzati dalla famiglia dei loro primi ministri, ovvero Carlo e suo figlio Pipino. Probabilmente è merito del loro operato se i franchi si convertirono alla cavalleria pesante, introducendo nei loro eserciti la staffa e l’uso di poderose cariche di cavalieri corazzati. Nel 732, nella battaglia di Poitiers, quella che insieme alla difesa di Costantinopoli ad oriente (717-718) respinse la marea musulmana e preservò l’Europa cristiana, questo processo doveva essere appena iniziato o ancora in fase di progettazione. Infatti il contributo della cavalleria, a parte l’intervento del duca d’Aquitania Oddone fu minimo, mentre lo scontro fu deciso dalla solidità del muro di scudi, lance e spade che la fanteria pesante franca, sassone, frisona e bavara oppose alle cavallerie leggere e ai guerrieri musulmani.
Anche l’entità numerica degli eserciti utilizzati da Carlo Magno nelle sue guerre di conquista non è purtroppo certa, ma siamo ragionevolmente sicuri che oltre ad una buona fanteria potesse schierare un nucleo di diverse migliaia di cavalieri. Ma come mai i franchi adottarono questo tipo di contingente così lontano dal loro modo di fare la guerra? La risposta potrebbe essere ricercata nelle nuove esigenze militari di un regno che stava diventando sempre più simile ad un impero europeo. Era passato molto tempo da quando i franchi erano una semplice confederazione di tribù che agiva come foederata dell’Impero Romano. Fin dai tempi di re Clodoveo (VI secolo) avevano conquistato Parigi ed esteso i loro confini in tutte le direzioni, sia a sud, sia ad est.
Cosa è successo quel 10 agosto? Come mai la tanto consolidata cavalleria leggera nomade era stata sconfitta? Fino ad allora, la sua mobilità e la sua capacità di attaccare il nemico a distanza con potenti archi compositi le aveva dato la qualifica di strumento praticamente invincibile in campo aperto. Le sue sconfitte erano state pochissime, tutte dovute ad un nemico diventato in quella tecnica bravo come loro (vedi i bizantini) oppure in seguito a particolari condizioni (nella battaglia di Nedao gli unni vennero sconfitti perché la pioggia rese inutilizzabili i loro archi e meno mobili le loro forze a cavallo).
 |
| "Battaglia di Legnano" di Amos Cassioli (1860-70). Firenze, Galleria d'arte moderna di palazzo Pitti. |
clicca QUI
Per "Il senso della vita nell'antichità e l'Homo Faber degli antichi Romani" clicca QUI
Per "Pontificato e sacerdozio nell'antica Roma" clicca QUI
Per "I Patrizi dell'antica Roma" clicca QUI
Per "Mos maiorum e Humanitas nell'antica Roma" clicca QUI
Per "Elezioni, elettori ed eletti nell'antica Repubblica di Roma" clicca QUI
Per "Conflitto degli Ordini e Secessione della Plebe nell'antica Repubblica di Roma" clicca QUI
Per "Le leggi delle XII tavole dell'antica Repubblica di Roma" clicca QUI
Per "L'ordinamento politico-sociale dell'antica Roma monarchica" clicca QUI
Per "Scienza applicata all'ecosistema globale: il mare può pulirsi da solo" clicca QUI
clicca QUI
Per "Nell'Etiopia dell'antichità, eventi che segnano il pensiero contemporaneo" clicca QUI
clicca QUI
Per "Pontificato e sacerdozio nell'antica Roma" clicca QUI
Per "I Patrizi dell'antica Roma" clicca QUI
Per "Mos maiorum e Humanitas nell'antica Roma" clicca QUI
Per "Il potere dell'imperium nell'antica Roma" clicca QUI
Per "L'apporto di Esseni, Zeloti (o Sicari) e Gnostici alla nascita del Cristianesimo" clicca QUI
Per "Gesù Cristo nel suo contesto storico" clicca QUI
Per "Ermetismo e Alchimia" clicca QUI
Per "Salomone e il suo tempio, massoneria e demoni" clicca QUI
Per "Paolo Rossi: Pericle e la Democrazia" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Ciriaco De Mita" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Claudio Scajola" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Pier Ferdinando Casini" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Angelino Alfano" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Silvio Berlusconi" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Domenico Scilipoti" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Giulio Tremonti" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Ignazio La Russa" clicca QUI
Per "SatirOroscopo per Renato Brunetta" clicca QUI
Per "L'illustrissimo Maestro Ben Sarebb Sestesszitt ci fornirà il SatirOroscopo" clicca QUI
Per "La Storia" clicca QUI
Per "L'arte" clicca QUI
Per "Il perdono" clicca QUI
Per "Padre mio..." clicca QUI
Per "Massoneria: storia, usi e costumi" clicca QUI
Per "Nell'ambito geopolitico, il processo italiano di svilimento della Costituzione e perdita della sovranità nazionale
a favore dell'Ue a guida franco-tedesca" clicca QUI
Per i post "La politica nell'Italia contemporanea" clicca QUI
Per i post "Storia dell'Europa" clicca QUI
Per i post "Astrologia evolutiva, progressiva, oroscopo, numerologia" clicca QUI
Per "I Chakra o Centri energetici fisici: dove sono e come si possono rilevare" clicca QUI
Per "Il Cattura-sogni" clicca QUI
Per "Ruota di Medicina dei Nativi Americani" clicca QUI
Per i post "Aforismi, Foto e Frasi dei Nativi Nord Americani (gl'Indiani d'America)" clicca QUI
Per i post "Politica nell'antica Roma" clicca QUI
Per "Elenco degli storici antichi dell'Occidente" clicca QUI
Per "Ebraismo: origini, storia e cultura" clicca QUI
Per "Liguri: storia e cultura" clicca QUI









Nessun commento:
Posta un commento